Il baco e la farfalla (capitolo 6)
:: Vetrina Autori :: Opere :: Diego Repetto
Pagina 1 di 1
 Il baco e la farfalla (capitolo 6)
Il baco e la farfalla (capitolo 6)
Luglio 1952
Un nome, un cognome, un paese. Non era molto, ne ero consapevole, ma era tutto ciò che possedevo. Erano trascorsi molti anni, inoltre. Forse non viveva nemmeno più a Camogli. Nonostante tutto ero fiducioso. Salii sul treno diretto a Genova convinto che presto avrei conosciuto colei che mi aveva messo al mondo.
Feci scorrere la porta dello scompartimento e domandai a un signore in giacca e cravatta se c’era un posto libero. Mi accomodai di fronte a una bella donna sulla quarantina che sollevò appena lo sguardo per immergersi poi nuovamente nelle pagine di un libro. Una volta seduto iniziai a osservarli, facendo attenzione che non se ne accorgessero. Lui sfogliava il giornale, distrattamente. Ebbi l’impressione che stesse leggendo solamente i titoli. Lei alternava lo sguardo tra il libro e il finestrino. Gli occhi velati di malinconia. Entrambi sembravano non curarsi della mia presenza. Chissà se osservandomi avrebbero potuto rendersi conto delle mie emozioni. Tensione, attesa, eccitazione, angustia. Altre domande si fecero spazio nella mia mente. Cosa avrei fatto una volta arrivato a Camogli? Sarei riuscito a trovare mia madre? E se la mia ricerca avesse avuto successo, cosa ci saremmo detti quando ci saremmo ritrovati uno di fronte all’altro? Sarei riuscito a farle le domande a cui per tutti quegli anni avevo risposto solamente con astio e risentimento?
Alla stazione di Genova Principe scesi dal treno e aspettai che giungesse il diretto per Roma. Restai in piedi, le panchine erano tutte occupate. Il marciapiede era affollato. Come mi spiegò una signora particolarmente loquace, tra quelle persone c’era chi partiva per le vacanze e chi invece rientrava per qualche tempo al Sud, così diverso e così caro, abbandonato a malincuore per inseguire il sogno di un lavoro. Una terra ricca di calore umano, mai dimenticata e spesso rimpianta, soprattutto dopo essersi accorti che non era affatto facile sbarcare il lunario in un Nord che faticava ad uscire dalla crisi economica del dopoguerra.
Erano i pionieri di un esodo interno che solamente una decina di anni dopo avrebbe assunto proporzioni straordinarie.
La giornata era afosa, senza una bava di vento, il caldo era soffocante. Uomini e donne trascinavano a fatica valigie enormi. L’odore rancido di sudore appestava l’aria. Dalla quantità e dalle dimensioni dei bagagli sembrava un trasloco definitivo più che un ritorno di qualche settimana alle proprie origini.
Un fischio acuto annunciò l’arrivo del convoglio ferroviario e i componenti dei vari gruppi iniziarono a posizionarsi a qualche metro l’uno dall’altro, sul bordo del marciapiede, per poter essere i primi ad avventarsi sulla porta, salire sul vagone e occupare i posti per i propri amici e famigliari. Non ero pronto per spintoni e gomitate. Salii per ultimo. Rinunciai a cercare un posto a sedere e mi fermai in piedi nel corridoio, vicino al finestrino. Anche le cose più belle, per poter essere ammirate e apprezzate, hanno bisogno del giusto stato d’animo e il mio, in quel momento, non era adatto alla contemplazione. Indifferente all’accecante bellezza dei raggi solari riflessi da un mare leggermente increspato, desiderai che quella mezz’ora che mi separava da Camogli passasse il più rapidamente possibile.
Scesi dal treno scortato da un chiassoso nugolo di bagnanti. Uscii dalla stazione e mi guardai intorno. Non ero mai stato a Camogli. Non avevo idea di dove fosse il centro del paese. Partivo da zero, non sapevo nemmeno se svoltare a destra o a sinistra. Vidi un bar dall’altro lato della strada. In fondo un posto valeva l’altro, pensai, e decisi di iniziare da lì la mia ricerca.
Il barista scosse la testa.
“Mi spiace ragazzo, non la conosco”.
“Grazie lo stesso, arrivederci”. Mi avviai all’uscita con la stessa sensazione con cui ero entrato. Non sarebbe stato facile, tutt’altro. Dovevo avere pazienza e non lasciarmi scoraggiare dai primi inevitabili insuccessi. Nemmeno il fabbro e il calzolaio mi furono di aiuto.
Scesi le ripide scale che portavano al mare. Una lunga fila ininterrotta di case colorate bordeggiava la passeggiata lungo il litorale. Si ergevano alte e strette, con le facciate dai toni sfumati, una di fianco all’altra, alcune appena un po’ più basse delle altre, come pastelli leggermente consumati in una scatola. Un mosaico variopinto di asciugamani ricopriva quasi interamente i ciottoli della spiaggia. La distesa di sassi terminava sotto la basilica, protetta dal mare da un castello medioevale e separata dal borgo abitato da uno stretto passaggio attraverso il quale si accedeva al porticciolo. Quel pittoresco paesino di pescatori mi piacque immediatamente. Pensai che se non avessi trovato mia madre avrei potuto in ogni caso trasferirmi lì e cercare un lavoro.
Per il momento, comunque, non avevo affatto abbandonato la speranza di riuscire nella mia missione. Entrai in una focacceria.
“Buongiorno, mi scusi, sto cercando Costanza Bertoli. Purtroppo non so dove abita, né, a dir la verità, se vive ancora qui a Camogli. Non so nemmeno che cosa faccia. Ma è estremamente importante per me incontrarla e le sarei infinitamente grato se potesse darmi qualsiasi informazione che pensa possa essermi utile”.
“Costanza Bertoli?” ripeté l’uomo dietro al bancone aggrottando le sopracciglia. “Il cognome mi suona. C’è una famiglia Bertoli che vive nella via qui sopra. In cima alle scale gira a sinistra, dopo un centinaio di metri, sulla destra, c’è un cancello verde, proprio di fronte alla latteria”.
Aveva accompagnato le parole con ampi gesti delle braccia e delle mani. Terminate le indicazioni, mi osservò come per chiedermi se avevo capito e restò in attesa di una mia reazione.
Dopo qualche istante di silenzio, lo ringraziai un paio di volte e uscii in strada. Avevo l’informazione di cui avevo bisogno. Sapevo dove avrei potuto incontrare mia madre o almeno qualcuno che forse mi avrebbe detto dove trovarla. Fissai la linea dell’orizzonte, dove mare e cielo si fondevano l’uno nell’altro. E improvvisamente mi assalì il panico. Proprio ora che il mio obiettivo era lì, così vicino, ero come paralizzato, non riuscivo a salire quella maledetta scalinata. Troppo ripida. I gradini troppo alti. Mia madre se n’era andata dopo la mia nascita e non si era mai preoccupata negli anni successivi di farsi viva. Provai a visualizzare la scena, la sua reazione al vedermi. Dovevo provare a cambiare il mio destino o era meglio accettarlo così com’era?
Non saprei dire quanto tempo rimasi seduto sul muretto, lo sguardo perso in mezzo al mare, a gambe incrociate, con i gomiti appoggiati sulle ginocchia, le mani con le dita raccolte contro le guance e i palmi a sorreggere il mento. Un’ora, forse due, lottando contro la tentazione di lasciare perdere tutto, ritornare alla stazione e salire sul primo treno per Genova. Sentivo il bisogno di rifugiarmi in un presente conosciuto. I ragazzi dell’istituto, la signora Milton.
Scossi la testa.
“Dovrai attendere ancora” pensai a voce alta rivolgendomi al mio passato.
“Chi ti aspetterà invano?”.
Mi volsi di scatto. Al mio fianco, con le mani appoggiate sul muretto, un vecchio mi stava scrutando. Aveva il viso solcato da profonde rughe, la pelle bruciata dal sole, due strette fessure al posto degli occhi e l’alito impregnato di alcol. Mi aveva spaventato, non mi ero accorto del suo arrivo. Chissà da quanto tempo era in piedi al mio fianco senza che avessi notato la sua presenza, aggrovigliato com’ero nei miei pensieri.
Indossava una maglietta bianca a maniche corte di almeno un paio di taglie più piccole della sua e dei pantaloni rossi di lino che a malapena coprivano i polpacci e lasciavano scoperte le caviglie, magre, ricoperte da una fitta rete di vene violacee. Sull’avambraccio sinistro si intravvedevano, deformati dalla pelle raggrinzita, tre tatuaggi. Un pesce, un’àncora e un veliero.
“Il mio passato” risposi sorridendo dopo qualche istante, più divertito che seccato dalla sua curiosità.
“Tu hai le idee confuse, ragazzo. È il futuro che ti sta aspettando, non il passato” biascicò indicandomi, faticando a schiudere le labbra di una bocca che, nonostante non fosse ancora mezzogiorno, era già stata innaffiata abbondantemente con “bianchetti” e “ammazzacaffè”. Ispirava simpatia.
“Devo chiarire prima alcune cose del mio passato. Non vorrei arrivare all’appuntamento col mio futuro con le idee... confuse ”.
“Sbrigati allora, non perdere tempo. A volte il futuro non aspetta, arriva e basta, senza nemmeno che te ne accorgi” ribatté spalancando gli occhi. Mi diede una pacca sulla spalla e, senza aggiungere altro, si volse e si incamminò barcollante lungo il marciapiede.
“Senza nemmeno che te ne accorgi” ripetei tra me mentre lo guardavo allontanarsi.
Rimasi seduto qualche minuto, con le gambe a penzoloni, fissandomi le punte dei piedi. Poi saltai sul marciapiede e mi avviai verso le scalinata. Iniziai a salire, i primi gradini lentamente, poi sempre più velocemente, gli ultimi di due in due. Arrivai in cima con il fiatone.
“In fondo non era poi così ripida” pensai.
Camminavo sospinto dai pensieri. Il dubbio e la certezza che fosse giusta la decisione che avevo preso si alternavano regolarmente, come le mosse di un’estenuante partita a scacchi. La strada era affollata, ma era come se non ci fosse nessuno. Procedevo lungo il marciapiede senza preoccuparmi di schivare i passanti, erano loro a evitare me. Arrivato davanti alla latteria, attraversai la strada e iniziai a scorrere i nomi sul citofono. L’uomo della focacceria non si era sbagliato. Le gambe faticavano a sorreggermi. Inspirai profondamente dal naso e svuotai i polmoni espirando rumorosamente con la bocca. Appoggiai l’indice sul campanello, chiusi gli occhi e premetti il pulsante per un tempo che mi parve troppo lungo. Dopo alcuni secondi travestiti da minuti, risuonò una voce metallica di donna:
“Chi è?”.
“Buongiorno, sto cercando Costanza Bertoli. Sono Guido”.
Mi tremava la voce.
“Non abita qui”.
Tre semplici parole che ebbero l’effetto di una pompa. Risucchiarono in un baleno le dense emozioni che avvolgevano ogni atomo del mio corpo e mi lasciarono in balìa di un’angosciante sensazione di vuoto.
“Però le posso dire dove trovarla. È mia sorella. Posso sapere perché la sta cercando?”.
Fortunatamente il cuore di un ragazzo di quattordici anni riesce a resistere al raddoppio istantaneo del battito cardiaco. Incapace di controllare l’eccitazione, avvicinai la bocca a pochi centimetri dal citofono e risposi con voce incerta:
“È mia madre”.
Il cancello verde si aprì con uno scatto improvviso. Non si entrava direttamente nel palazzo. Una scalinata ricoperta da una fitta bougainville portava a un secondo cancello che trovai aperto, superato il quale mi ritrovai in mezzo a un rigoglioso cortile interno su cui si affacciavano tre porte di legno scuro. Quella centrale si aprì e una donna con i capelli neri a caschetto mi venne incontro sorridendo.
“Vieni, entra”.
Fu mia nonna a riconoscermi. Seduta su una poltrona del salotto, dopo avermi osservato scrupolosamente, esclamò incredula:
“Questo ragazzo non mente. Gli occhi, il naso, la bocca, perfino il neo sotto lo zigomo. È la copia di Costanza”.
Dopo aver ascoltato con attenzione un breve riassunto della mia vita ed essersi fatta raccontare come ero giunto a Camogli, Stefania, la sorella di mia madre, visibilmente emozionata, mi invitò a seguirla.
“Andiamo, ti accompagno da tua madre”.
Lungo la strada mi raccontò che la loro famiglia non era originaria di Camogli. Mia nonna era bergamasca e dopo la morte del marito si era trasferita in Liguria con i quattro figli. Nonostante un titolo da segretaria d’azienda, giunta in riva al mare aveva rinunciato a cercare un lavoro che l’avrebbe rinchiusa in un ufficio e aveva speso tutto ciò che possedeva per acquistare un piccolo peschereccio. Il commercio del pesce si era rivelato particolarmente redditizio e dopo qualche anno la monoflotta si era arricchita di una nuova imbarcazione, il Barracuda. Quella che sembrava una macchina perfetta per fare soldi si era inceppata il giorno in cui il medico le aveva diagnosticato una malattia incurabile. I due pescherecci furono venduti per poter fare arrivare ogni settimana dalla Francia una costosissima medicina, rivelatasi utile solamente a prolungare di qualche anno la sua agonia.
Incontrammo casualmente Costanza a metà del lungomare. Mia zia mi prese per un braccio e mi indicò una donna a una decina di metri che avanzava verso di noi. Non era sola. Al suo fianco una bambina saltellava da un piede all’altro cercando di evitare le linee che separavano i vari lastroni di pietra. Spostai nuovamente lo sguardo sulla figura adulta. Era una donna bellissima. I capelli d’ebano le sfioravano le spalle e incorniciavano un viso latteo in mezzo al quale spiccavano due sottili labbra scarlatte. Ne rimasi abbagliato e per un attimo dimenticai tutto il rancore che avevo covato nei suoi confronti negli ultimi anni. La delusione fu grande però quando mi guardò con indifferenza e si rivolse alla sorella. Non mi aspettavo certo che mi riconoscesse, non avrebbe potuto, ma avrei voluto almeno che rimanesse colpita da qualcosa in me come io lo ero stato dalla sua bellezza.
“Costanza, questo ragazzo è Guido”.
Poi, vedendo che non reagiva, ripeté: “Guido”.
Non se l’aspettava, era stata colta di sorpresa. Era evidentemente imbarazzata. Non sapeva cosa dire. Avrebbe potuto abbracciarmi, in silenzio. E in quell’abbraccio si sarebbero sciolte come neve al sole tensioni e paure. I dubbi sarebbero svaniti improvvisamente, schiantati dall’umanità e dal calore di quel semplice gesto d’affetto. Non lo fece. Rimase a guardarmi, inebetita, e dopo qualche istante, dalle labbra socchiuse, uscì un asettico:
“Sei arrivato”.
La freddezza con cui mi accolse agì da detonatore per la mia rabbia.
“Se aspettavo te, non ci saremmo mai incontrati“ risposi sprezzante fulminandola con uno sguardo carico di fiele.
Incurante del tono delle mie parole, si volse verso la bambina, che nel frattempo aveva smesso di saltellare e fissava incuriosita la scena.
“Giovanna, lui è Guido, tuo fratello”.
Alcune reazioni non appartengono al mondo dei bambini. Un adulto si sarebbe stupito, avrebbe spalancato occhi e bocca, incredulo. Le reazioni dei bambini invece sono spesso disarmanti, soprattutto nei momenti più drammatici. Assorbono in modo apparentemente indolore il trauma, conservandolo gelosamente per anni, facendolo fermentare lentamente fino a quando, una volta cresciuti, si trovano costretti a pagarne le conseguenze sottoforma di insicurezze, fobie, gelosie e paranoie. I genitori molte volte se ne dimenticano, non riflettono su ciò che dicono e fanno, e si stupiscono quando i figli, da grandi, decidono di superare i traumi infantili con l’aiuto di uno psicologo. La sorpresa è dovuta al fatto che nel momento del trauma i bambini quasi sempre ti spiazzano. Giovanna, tutt’altro che sconvolta per aver vissuto nove anni pensando di essere figlia unica, mi sorrise e con voce candida disse:
“Ciao. Vuoi giocare con me a “saltarello”?”.
L’innocenza della sua domanda aiutò a stemperare la tensione. Ci avviammo verso casa di mia madre. Chiese alla sorella di restare con Giovanna e mi invitò a seguirla in cucina. Chiuse la porta, si sedette dall’altro lato del tavolo e rimase ad osservarmi, come paralizzata. Nemmeno io sapevo cosa dire. Ero felice di averla trovata, ma non riuscivo a comunicarglielo. Né a parole, né a gesti, e credo neppure con lo sguardo. Allo stesso tempo non riuscivo a liberare le domande che tanto mi avevano assillato nelle ultime settimane. Trascorse un minuto, forse due, poi mia madre allungò il braccio e depose il dorso della mano sul tavolo, di fronte a me. Accolsi l’invito e adagiai il mio palmo sul suo. Avvicinò la mano rimasta libera, strinse forte la mia tra le sue e si sciolse in un pianto contagioso.
Le raccontai della poliomielite, della vecchia strega, di come era stato ammazzato papà. Le parlai degli anni trascorsi alla Casa Svizzera, della signora Milton e di come era nato il desiderio di incontrarla. Non le chiesi nulla della mia nascita e di perché se n’era andata. Mi mancò il coraggio. Mi ascoltò attenta, senza interrompermi. Rise quando le raccontai come il vecchio pescatore mi avesse fatto cambiare nuovamente idea. “... quando mi ha visto, la nonna mi ha riconosciuto, ha detto che sono la tua copia”.
Restò a pensare in silenzio, un attimo, poi mi sorrise con tenerezza materna.
“Perché non ti trasferisci a vivere qui con noi?”.
Due giorni dopo scendevo alla stazione di Camogli con la solita valigia piena delle solite poche cose. Mi accompagnava l’illusione di poter far parte finalmente di una famiglia normale. Il direttore della Casa Svizzera mi aveva salutato facendomi capire che avrei trovato le porte dell’istituto sempre aperte, ma il suo abbraccio forte e prolungato mi sembrò molto più un addio che un arrivederci.
Un nome, un cognome, un paese. Non era molto, ne ero consapevole, ma era tutto ciò che possedevo. Erano trascorsi molti anni, inoltre. Forse non viveva nemmeno più a Camogli. Nonostante tutto ero fiducioso. Salii sul treno diretto a Genova convinto che presto avrei conosciuto colei che mi aveva messo al mondo.
Feci scorrere la porta dello scompartimento e domandai a un signore in giacca e cravatta se c’era un posto libero. Mi accomodai di fronte a una bella donna sulla quarantina che sollevò appena lo sguardo per immergersi poi nuovamente nelle pagine di un libro. Una volta seduto iniziai a osservarli, facendo attenzione che non se ne accorgessero. Lui sfogliava il giornale, distrattamente. Ebbi l’impressione che stesse leggendo solamente i titoli. Lei alternava lo sguardo tra il libro e il finestrino. Gli occhi velati di malinconia. Entrambi sembravano non curarsi della mia presenza. Chissà se osservandomi avrebbero potuto rendersi conto delle mie emozioni. Tensione, attesa, eccitazione, angustia. Altre domande si fecero spazio nella mia mente. Cosa avrei fatto una volta arrivato a Camogli? Sarei riuscito a trovare mia madre? E se la mia ricerca avesse avuto successo, cosa ci saremmo detti quando ci saremmo ritrovati uno di fronte all’altro? Sarei riuscito a farle le domande a cui per tutti quegli anni avevo risposto solamente con astio e risentimento?
Alla stazione di Genova Principe scesi dal treno e aspettai che giungesse il diretto per Roma. Restai in piedi, le panchine erano tutte occupate. Il marciapiede era affollato. Come mi spiegò una signora particolarmente loquace, tra quelle persone c’era chi partiva per le vacanze e chi invece rientrava per qualche tempo al Sud, così diverso e così caro, abbandonato a malincuore per inseguire il sogno di un lavoro. Una terra ricca di calore umano, mai dimenticata e spesso rimpianta, soprattutto dopo essersi accorti che non era affatto facile sbarcare il lunario in un Nord che faticava ad uscire dalla crisi economica del dopoguerra.
Erano i pionieri di un esodo interno che solamente una decina di anni dopo avrebbe assunto proporzioni straordinarie.
La giornata era afosa, senza una bava di vento, il caldo era soffocante. Uomini e donne trascinavano a fatica valigie enormi. L’odore rancido di sudore appestava l’aria. Dalla quantità e dalle dimensioni dei bagagli sembrava un trasloco definitivo più che un ritorno di qualche settimana alle proprie origini.
Un fischio acuto annunciò l’arrivo del convoglio ferroviario e i componenti dei vari gruppi iniziarono a posizionarsi a qualche metro l’uno dall’altro, sul bordo del marciapiede, per poter essere i primi ad avventarsi sulla porta, salire sul vagone e occupare i posti per i propri amici e famigliari. Non ero pronto per spintoni e gomitate. Salii per ultimo. Rinunciai a cercare un posto a sedere e mi fermai in piedi nel corridoio, vicino al finestrino. Anche le cose più belle, per poter essere ammirate e apprezzate, hanno bisogno del giusto stato d’animo e il mio, in quel momento, non era adatto alla contemplazione. Indifferente all’accecante bellezza dei raggi solari riflessi da un mare leggermente increspato, desiderai che quella mezz’ora che mi separava da Camogli passasse il più rapidamente possibile.
Scesi dal treno scortato da un chiassoso nugolo di bagnanti. Uscii dalla stazione e mi guardai intorno. Non ero mai stato a Camogli. Non avevo idea di dove fosse il centro del paese. Partivo da zero, non sapevo nemmeno se svoltare a destra o a sinistra. Vidi un bar dall’altro lato della strada. In fondo un posto valeva l’altro, pensai, e decisi di iniziare da lì la mia ricerca.
Il barista scosse la testa.
“Mi spiace ragazzo, non la conosco”.
“Grazie lo stesso, arrivederci”. Mi avviai all’uscita con la stessa sensazione con cui ero entrato. Non sarebbe stato facile, tutt’altro. Dovevo avere pazienza e non lasciarmi scoraggiare dai primi inevitabili insuccessi. Nemmeno il fabbro e il calzolaio mi furono di aiuto.
Scesi le ripide scale che portavano al mare. Una lunga fila ininterrotta di case colorate bordeggiava la passeggiata lungo il litorale. Si ergevano alte e strette, con le facciate dai toni sfumati, una di fianco all’altra, alcune appena un po’ più basse delle altre, come pastelli leggermente consumati in una scatola. Un mosaico variopinto di asciugamani ricopriva quasi interamente i ciottoli della spiaggia. La distesa di sassi terminava sotto la basilica, protetta dal mare da un castello medioevale e separata dal borgo abitato da uno stretto passaggio attraverso il quale si accedeva al porticciolo. Quel pittoresco paesino di pescatori mi piacque immediatamente. Pensai che se non avessi trovato mia madre avrei potuto in ogni caso trasferirmi lì e cercare un lavoro.
Per il momento, comunque, non avevo affatto abbandonato la speranza di riuscire nella mia missione. Entrai in una focacceria.
“Buongiorno, mi scusi, sto cercando Costanza Bertoli. Purtroppo non so dove abita, né, a dir la verità, se vive ancora qui a Camogli. Non so nemmeno che cosa faccia. Ma è estremamente importante per me incontrarla e le sarei infinitamente grato se potesse darmi qualsiasi informazione che pensa possa essermi utile”.
“Costanza Bertoli?” ripeté l’uomo dietro al bancone aggrottando le sopracciglia. “Il cognome mi suona. C’è una famiglia Bertoli che vive nella via qui sopra. In cima alle scale gira a sinistra, dopo un centinaio di metri, sulla destra, c’è un cancello verde, proprio di fronte alla latteria”.
Aveva accompagnato le parole con ampi gesti delle braccia e delle mani. Terminate le indicazioni, mi osservò come per chiedermi se avevo capito e restò in attesa di una mia reazione.
Dopo qualche istante di silenzio, lo ringraziai un paio di volte e uscii in strada. Avevo l’informazione di cui avevo bisogno. Sapevo dove avrei potuto incontrare mia madre o almeno qualcuno che forse mi avrebbe detto dove trovarla. Fissai la linea dell’orizzonte, dove mare e cielo si fondevano l’uno nell’altro. E improvvisamente mi assalì il panico. Proprio ora che il mio obiettivo era lì, così vicino, ero come paralizzato, non riuscivo a salire quella maledetta scalinata. Troppo ripida. I gradini troppo alti. Mia madre se n’era andata dopo la mia nascita e non si era mai preoccupata negli anni successivi di farsi viva. Provai a visualizzare la scena, la sua reazione al vedermi. Dovevo provare a cambiare il mio destino o era meglio accettarlo così com’era?
Non saprei dire quanto tempo rimasi seduto sul muretto, lo sguardo perso in mezzo al mare, a gambe incrociate, con i gomiti appoggiati sulle ginocchia, le mani con le dita raccolte contro le guance e i palmi a sorreggere il mento. Un’ora, forse due, lottando contro la tentazione di lasciare perdere tutto, ritornare alla stazione e salire sul primo treno per Genova. Sentivo il bisogno di rifugiarmi in un presente conosciuto. I ragazzi dell’istituto, la signora Milton.
Scossi la testa.
“Dovrai attendere ancora” pensai a voce alta rivolgendomi al mio passato.
“Chi ti aspetterà invano?”.
Mi volsi di scatto. Al mio fianco, con le mani appoggiate sul muretto, un vecchio mi stava scrutando. Aveva il viso solcato da profonde rughe, la pelle bruciata dal sole, due strette fessure al posto degli occhi e l’alito impregnato di alcol. Mi aveva spaventato, non mi ero accorto del suo arrivo. Chissà da quanto tempo era in piedi al mio fianco senza che avessi notato la sua presenza, aggrovigliato com’ero nei miei pensieri.
Indossava una maglietta bianca a maniche corte di almeno un paio di taglie più piccole della sua e dei pantaloni rossi di lino che a malapena coprivano i polpacci e lasciavano scoperte le caviglie, magre, ricoperte da una fitta rete di vene violacee. Sull’avambraccio sinistro si intravvedevano, deformati dalla pelle raggrinzita, tre tatuaggi. Un pesce, un’àncora e un veliero.
“Il mio passato” risposi sorridendo dopo qualche istante, più divertito che seccato dalla sua curiosità.
“Tu hai le idee confuse, ragazzo. È il futuro che ti sta aspettando, non il passato” biascicò indicandomi, faticando a schiudere le labbra di una bocca che, nonostante non fosse ancora mezzogiorno, era già stata innaffiata abbondantemente con “bianchetti” e “ammazzacaffè”. Ispirava simpatia.
“Devo chiarire prima alcune cose del mio passato. Non vorrei arrivare all’appuntamento col mio futuro con le idee... confuse ”.
“Sbrigati allora, non perdere tempo. A volte il futuro non aspetta, arriva e basta, senza nemmeno che te ne accorgi” ribatté spalancando gli occhi. Mi diede una pacca sulla spalla e, senza aggiungere altro, si volse e si incamminò barcollante lungo il marciapiede.
“Senza nemmeno che te ne accorgi” ripetei tra me mentre lo guardavo allontanarsi.
Rimasi seduto qualche minuto, con le gambe a penzoloni, fissandomi le punte dei piedi. Poi saltai sul marciapiede e mi avviai verso le scalinata. Iniziai a salire, i primi gradini lentamente, poi sempre più velocemente, gli ultimi di due in due. Arrivai in cima con il fiatone.
“In fondo non era poi così ripida” pensai.
Camminavo sospinto dai pensieri. Il dubbio e la certezza che fosse giusta la decisione che avevo preso si alternavano regolarmente, come le mosse di un’estenuante partita a scacchi. La strada era affollata, ma era come se non ci fosse nessuno. Procedevo lungo il marciapiede senza preoccuparmi di schivare i passanti, erano loro a evitare me. Arrivato davanti alla latteria, attraversai la strada e iniziai a scorrere i nomi sul citofono. L’uomo della focacceria non si era sbagliato. Le gambe faticavano a sorreggermi. Inspirai profondamente dal naso e svuotai i polmoni espirando rumorosamente con la bocca. Appoggiai l’indice sul campanello, chiusi gli occhi e premetti il pulsante per un tempo che mi parve troppo lungo. Dopo alcuni secondi travestiti da minuti, risuonò una voce metallica di donna:
“Chi è?”.
“Buongiorno, sto cercando Costanza Bertoli. Sono Guido”.
Mi tremava la voce.
“Non abita qui”.
Tre semplici parole che ebbero l’effetto di una pompa. Risucchiarono in un baleno le dense emozioni che avvolgevano ogni atomo del mio corpo e mi lasciarono in balìa di un’angosciante sensazione di vuoto.
“Però le posso dire dove trovarla. È mia sorella. Posso sapere perché la sta cercando?”.
Fortunatamente il cuore di un ragazzo di quattordici anni riesce a resistere al raddoppio istantaneo del battito cardiaco. Incapace di controllare l’eccitazione, avvicinai la bocca a pochi centimetri dal citofono e risposi con voce incerta:
“È mia madre”.
Il cancello verde si aprì con uno scatto improvviso. Non si entrava direttamente nel palazzo. Una scalinata ricoperta da una fitta bougainville portava a un secondo cancello che trovai aperto, superato il quale mi ritrovai in mezzo a un rigoglioso cortile interno su cui si affacciavano tre porte di legno scuro. Quella centrale si aprì e una donna con i capelli neri a caschetto mi venne incontro sorridendo.
“Vieni, entra”.
Fu mia nonna a riconoscermi. Seduta su una poltrona del salotto, dopo avermi osservato scrupolosamente, esclamò incredula:
“Questo ragazzo non mente. Gli occhi, il naso, la bocca, perfino il neo sotto lo zigomo. È la copia di Costanza”.
Dopo aver ascoltato con attenzione un breve riassunto della mia vita ed essersi fatta raccontare come ero giunto a Camogli, Stefania, la sorella di mia madre, visibilmente emozionata, mi invitò a seguirla.
“Andiamo, ti accompagno da tua madre”.
Lungo la strada mi raccontò che la loro famiglia non era originaria di Camogli. Mia nonna era bergamasca e dopo la morte del marito si era trasferita in Liguria con i quattro figli. Nonostante un titolo da segretaria d’azienda, giunta in riva al mare aveva rinunciato a cercare un lavoro che l’avrebbe rinchiusa in un ufficio e aveva speso tutto ciò che possedeva per acquistare un piccolo peschereccio. Il commercio del pesce si era rivelato particolarmente redditizio e dopo qualche anno la monoflotta si era arricchita di una nuova imbarcazione, il Barracuda. Quella che sembrava una macchina perfetta per fare soldi si era inceppata il giorno in cui il medico le aveva diagnosticato una malattia incurabile. I due pescherecci furono venduti per poter fare arrivare ogni settimana dalla Francia una costosissima medicina, rivelatasi utile solamente a prolungare di qualche anno la sua agonia.
Incontrammo casualmente Costanza a metà del lungomare. Mia zia mi prese per un braccio e mi indicò una donna a una decina di metri che avanzava verso di noi. Non era sola. Al suo fianco una bambina saltellava da un piede all’altro cercando di evitare le linee che separavano i vari lastroni di pietra. Spostai nuovamente lo sguardo sulla figura adulta. Era una donna bellissima. I capelli d’ebano le sfioravano le spalle e incorniciavano un viso latteo in mezzo al quale spiccavano due sottili labbra scarlatte. Ne rimasi abbagliato e per un attimo dimenticai tutto il rancore che avevo covato nei suoi confronti negli ultimi anni. La delusione fu grande però quando mi guardò con indifferenza e si rivolse alla sorella. Non mi aspettavo certo che mi riconoscesse, non avrebbe potuto, ma avrei voluto almeno che rimanesse colpita da qualcosa in me come io lo ero stato dalla sua bellezza.
“Costanza, questo ragazzo è Guido”.
Poi, vedendo che non reagiva, ripeté: “Guido”.
Non se l’aspettava, era stata colta di sorpresa. Era evidentemente imbarazzata. Non sapeva cosa dire. Avrebbe potuto abbracciarmi, in silenzio. E in quell’abbraccio si sarebbero sciolte come neve al sole tensioni e paure. I dubbi sarebbero svaniti improvvisamente, schiantati dall’umanità e dal calore di quel semplice gesto d’affetto. Non lo fece. Rimase a guardarmi, inebetita, e dopo qualche istante, dalle labbra socchiuse, uscì un asettico:
“Sei arrivato”.
La freddezza con cui mi accolse agì da detonatore per la mia rabbia.
“Se aspettavo te, non ci saremmo mai incontrati“ risposi sprezzante fulminandola con uno sguardo carico di fiele.
Incurante del tono delle mie parole, si volse verso la bambina, che nel frattempo aveva smesso di saltellare e fissava incuriosita la scena.
“Giovanna, lui è Guido, tuo fratello”.
Alcune reazioni non appartengono al mondo dei bambini. Un adulto si sarebbe stupito, avrebbe spalancato occhi e bocca, incredulo. Le reazioni dei bambini invece sono spesso disarmanti, soprattutto nei momenti più drammatici. Assorbono in modo apparentemente indolore il trauma, conservandolo gelosamente per anni, facendolo fermentare lentamente fino a quando, una volta cresciuti, si trovano costretti a pagarne le conseguenze sottoforma di insicurezze, fobie, gelosie e paranoie. I genitori molte volte se ne dimenticano, non riflettono su ciò che dicono e fanno, e si stupiscono quando i figli, da grandi, decidono di superare i traumi infantili con l’aiuto di uno psicologo. La sorpresa è dovuta al fatto che nel momento del trauma i bambini quasi sempre ti spiazzano. Giovanna, tutt’altro che sconvolta per aver vissuto nove anni pensando di essere figlia unica, mi sorrise e con voce candida disse:
“Ciao. Vuoi giocare con me a “saltarello”?”.
L’innocenza della sua domanda aiutò a stemperare la tensione. Ci avviammo verso casa di mia madre. Chiese alla sorella di restare con Giovanna e mi invitò a seguirla in cucina. Chiuse la porta, si sedette dall’altro lato del tavolo e rimase ad osservarmi, come paralizzata. Nemmeno io sapevo cosa dire. Ero felice di averla trovata, ma non riuscivo a comunicarglielo. Né a parole, né a gesti, e credo neppure con lo sguardo. Allo stesso tempo non riuscivo a liberare le domande che tanto mi avevano assillato nelle ultime settimane. Trascorse un minuto, forse due, poi mia madre allungò il braccio e depose il dorso della mano sul tavolo, di fronte a me. Accolsi l’invito e adagiai il mio palmo sul suo. Avvicinò la mano rimasta libera, strinse forte la mia tra le sue e si sciolse in un pianto contagioso.
Le raccontai della poliomielite, della vecchia strega, di come era stato ammazzato papà. Le parlai degli anni trascorsi alla Casa Svizzera, della signora Milton e di come era nato il desiderio di incontrarla. Non le chiesi nulla della mia nascita e di perché se n’era andata. Mi mancò il coraggio. Mi ascoltò attenta, senza interrompermi. Rise quando le raccontai come il vecchio pescatore mi avesse fatto cambiare nuovamente idea. “... quando mi ha visto, la nonna mi ha riconosciuto, ha detto che sono la tua copia”.
Restò a pensare in silenzio, un attimo, poi mi sorrise con tenerezza materna.
“Perché non ti trasferisci a vivere qui con noi?”.
Due giorni dopo scendevo alla stazione di Camogli con la solita valigia piena delle solite poche cose. Mi accompagnava l’illusione di poter far parte finalmente di una famiglia normale. Il direttore della Casa Svizzera mi aveva salutato facendomi capire che avrei trovato le porte dell’istituto sempre aperte, ma il suo abbraccio forte e prolungato mi sembrò molto più un addio che un arrivederci.
 Argomenti simili
Argomenti simili» Il baco e la farfalla (capitolo 20)
» Il baco e la farfalla (capitolo 39)
» Il baco e la farfalla (capitolo 34)
» Il baco e la farfalla (capitolo 9)
» Il baco e la farfalla (capitolo 21)
» Il baco e la farfalla (capitolo 39)
» Il baco e la farfalla (capitolo 34)
» Il baco e la farfalla (capitolo 9)
» Il baco e la farfalla (capitolo 21)
:: Vetrina Autori :: Opere :: Diego Repetto
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.|
|
|






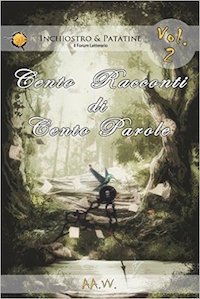
» concorso internazionale poesia e narrativa UN MONTE DI POESIA
» Premio di Poesia, Narrativa, Teatro e Pittura "Luce dell'Arte" 6^ Edizione
» concorso letterario internazionale UN MONTE DI POESIA XVI edizione
» IV^ Edizione del Premio di Narrativa, Teatro e Poesia "Il buon riso fa buon sangue". Scadenza bando 20/07/2022
» UN PONTE TRA NOI - RECENSIONE DI ARMANDO MASCHINI
» UN PONTE TRA NOI - RECENSIONE DI GIULIANA PARAGLIOLA