Il baco e la farfalla (capitolo 37)
:: Vetrina Autori :: Opere :: Diego Repetto
Pagina 1 di 1
 Il baco e la farfalla (capitolo 37)
Il baco e la farfalla (capitolo 37)
Luglio 2002
Mi accorsi del cigolio del cancello automatico troppo tardi. Pensare che ero stato io ad insistere affinché il binario su cui scorreva venisse lubrificato con dell’olio perché lo stridore acuto provocato dall’attrito del metallo sul metallo era diventato insopportabile. Quando mi volsi feci appena in tempo a vedere il cancello che mi investiva, facendomi perdere l’equilibrio. Una volta a terra, provai disperatamente a spostarmi dalla traiettoria. Non ne ebbi il tempo e il cancello si richiuse pesantemente, schiacciandomi contro il muro. Sentii un dolore acuto e profondo all’altezza del bacino. Ebbi la sensazione che il corpo si fosse spezzato in due, come se le gambe non mi appartenessero più. Poi mi si annebbiò la vista e persi conoscenza.
Quando riaprii gli occhi vidi il volto offuscato di un uomo chino su di me. Alle sue spalle una fredda luce al neon e in sottofondo l’ululato continuo di una sirena. Mi trovavo sulla barella di un’ambulanza. Non ricordavo nulla dell’incidente.
“Cosa è successo? Perché mi trovo qui?”.
“È stato investito da un’automobile di fronte all’ingresso della ditta per cui lavora”.
Automobile? Non ricordavo niente. Sentii la testa esplodere, poi nuovamente il nulla.
Marcella era seduta accanto al letto e mi teneva la mano stretta tra le sue. Sorrise.
“Finalmente ti sei svegliato”.
“Dove siamo?” domandai ancora mezzo intontito.
“All’ospedale. Hai avuto un incidente grave, ti hanno operato”.
“Non sento le gambe”.
“È l’effetto dell’anestesia. Il medico ha detto che ci vorrà qualche ora per riacquistare la completa sensibilità degli arti inferiori”.
“Che tipo di incidente?”.
“Sei stato investito da un’automobile all’uscita del lavoro. Il conducente della macchina non si è fermato per soccorrerti, un ragazzo che passava di lì in scooter ti ha trovato sul marciapiede in un lago di sangue e ha chiamato l’ambulanza. Purtroppo non ci sono testimoni dell’incidente”.
Chiusi gli occhi e mi sforzai per recuperare il ricordo della scena dell’incidente. Non si materializzò nessuna vettura. La stanza era invasa dall’odore di verdure bollite.
“Marcella, che cosa ho?”.
“Hai una frattura delle branche ileo e ischiopubiche”.
“Cioè?”.
“Hai il bacino rotto in più punti”.
“Nient’altro?”.
“Sì. Sei stato sottoposto a un intervento chirurgico di uretroplastica”.
“Cazzo Marcella, mi sembra di parlare con un dottore! Non mi puoi spiegare con parole semplici quello che mi hanno fatto?”.
“Avevi l’uretra spezzata e ti hanno inserito un catetere”.
“Vuoi dire che piscerò attraverso un tubo di plastica? Per quanto tempo?”.
“Almeno tre settimane”.
Affondai il capo nel cuscino e restai a fissare il soffitto bianco della stanza. Era scrostato in alcuni punti. Un vecchio ventilatore fendeva l’afa e ronzava ritmicamente come una mosca instancabile. Non sentivo le gambe. Allungai una mano e l’appoggiai su una coscia.
“Tornerò a camminare?”.
“Certo! Però ci vorrà tempo”.
“Quanto?”.
“La riabilitazione sarà lunga, circa tre mesi”.
Tre mesi. Mi domandai se fosse un tempo sufficiente per essere licenziato. Sì, era fin troppo. Lavoravo come custode per quella ditta da parecchi anni e conoscevo bene i padroni, due fratelli senza scrupoli che avrebbero trovato facilmente una scusa per sbattermi la porta in faccia nonostante il contratto in regola. Le condizioni di lavoro degli operai nella fabbrica erano pessime, i turni massacranti, gli straordinari non pagati all’ordine del giorno, le malattie dei dipendenti sopportate mal volentieri dai titolari, il tutto sotto la subdola e costante minaccia della cassa integrazione. Essere licenziato a sessantaquattro anni significava avere la garanzia di aspettare la pensione per dodici mesi da disoccupato. Guardai Marcella con sconforto.
“Sarà dura”.
Mi strinse più forte la mano.
“Ce la farai”.
“Sì, ma sarà difficile. Non solo per me, sarà dura per noi. Potrebbero licenziarmi”.
Un lampo d’odio le attraversò lo sguardo.
“Sarebbe una bastardata”.
“Dimentichi che i fratelli Marzorati sono dei bastardi”.
“Non pensiamoci adesso” sospirò. “Ora devo andare, ma tornerò domani”.
Mi accarezzò la testa, mi sfiorò la fronte con un rapido bacio e uscì dalla stanza.
Mi guardai intorno. Il letto di fianco al mio era vuoto. Quelli di fronte erano occupati da due anziani che, da quando ero sveglio, non avevano ancora ricevuto visite. Entrò un’infermiera a cambiarmi la flebo e misurarmi la temperatura.
“Non ha febbre, ottimo. Cerchi di riposare, ne ha bisogno per riprendersi dall’operazione”. La voce un po’ cantilenante.
“Dove vuole che vada” replicai brusco.
Mi osservò sorpresa.
“Mi scusi, sono un po’ nervoso” mi giustificai.
Rimasto solo, ripercorsi un’altra volta gli attimi precedenti all’incidente. Nell’ultima immagine che mi ricordavo ero sul cancello che parlavo con alcuni dipendenti che avevano finito il turno. Poi il buio. A che ora era successo l’incidente? Avevo già finito di lavorare? Perché mi trovavo in mezzo alla strada? Mi avevano ritrovato dopo quanto tempo? Possibile che nessuno avesse visto niente? Avvertii un leggero formicolio alle gambe. Mano a mano che ne riacquistavo la sensibilità, aumentava il dolore intorno alla vita. Quello alla testa non mi aveva mai abbandonato da quando avevo riaperto gli occhi.
Restai in ospedale venti giorni. Il decorso post-operatorio venne in parte rovinato da una fastidiosa gastrite che mi colpì alcuni giorni dopo l’intervento chirurgico. Dopo due settimane Marcella mi disse che era giunta a casa una lettera della ditta dei fratelli Marzorati. Non avevano perso tempo. Dall’ospedale San Raffaele venni in seguito trasferito nella struttura ospedaliera di San Pancrazio ad Arco, in provincia di Trento, presso la sezione di Riabilitazione Motoria. Ogni mattina venivo sottoposto a esercizi di mobilizzazione articolare e rinforzo muscolare e dopo tre settimane iniziai un allenamento deambulatorio con l’aiuto delle stampelle. Con un breve ma doloroso intervento mi venne tolto il catetere e tornai finalmente a orinare per via naturale. Un elettrocardiogramma di controllo evidenziò una necrosi anterosettale e un’ischemia subepicardica antero-laterale. Secondo i medici soffrivo di una cardiopatia postinfartuale per la quale mi suggerivano caldamente una rivascolarizzazione coronarica. Suscitando il loro stupore, rifiutai con decisione l’eventualità di un’ulteriore operazione. Non ne potevo più di restare rinchiuso in un ospedale. Non sopportavo più le infermiere troppo gentili, il cibo precotto, le visite giornaliere dei dottori, l’asfissiante loquacità dei compagni di stanza, ma soprattutto non soffrivo più gli orari e i ritmi da prigione che mi riportavano con la mente indietro nel tempo, riesumando un’epoca della mia vita che avevo accuratamente seppellito nella parte più profonda della memoria. L’unica cosa che desideravo in quel momento era tornare a casa.
La degenza nel secondo ospedale durò un mese.
Marcella si presentò puntuale a mezzogiorno. Aveva ripreso a lavorare al mercato e da quando ero stato trasferito in Trentino riusciva a venire a trovarmi solamente durante il fine settimana, ma per riportarmi a casa si era presa un giorno di ferie e si era svegliata all’alba per giungere in ospedale il prima possibile. Quando la vidi entrare ebbi la tentazione di saltare giù dal letto e correrle incontro per abbracciarla. Impiegammo pochi minuti a mettere in una borsa le poche cose che avevo e, dopo avere firmato il foglio di dimissioni, mi ritrovai finalmente all’aria aperta, nel piazzale di fronte all’ospedale. Mi fermai un attimo e feci tre lunghi respiri, poi saltellando sulle stampelle seguii Marcella verso l’uscita. Giunti a pochi metri dal gabbiottino, il tizio che vi era rinchiuso dentro ci salutò con la mano e azionò il cancello automatico. L’immagine mancante dell’incidente si materializzò improvvisa davanti ai miei occhi.
“Non mi ha investito una macchina” pensai ad voce alta.
“Cosa hai detto?”.
“Non mi ha investito una macchina” ripetei, questa volta rivolto a Marcella.
“Cosa stai dicendo, Guido. Ti hanno trovato in mezzo alla strada”.
“Mi ci hanno trascinato. Sono rimasto schiacciato dal cancello di ingresso della fabbrica”.
“Ti ha trascinato chi?”.
“Non lo so, ma credo qualcuno che lavora alla fabbrica, non vedo altra possibilità”.
“Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? È un’accusa gravissima. E poi dimmi, che motivo avevano per farlo?”.
Era come se all’improvviso fosse tutto chiaro, lampante, così evidente da sembrare impossibile che non lo avessi capito prima.
“Un incidente all’interno della fabbrica avrebbe avuto come conseguenza immediata un controllo da parte dell’ispettorato del lavoro”.
“E allora?”.
Marcella non capiva, ma in fondo non era colpa sua. Non poteva capire. Marcella ignorava che i fratelli Marzorati avevano più a cuore le sorti della loro squadra di calcio preferita che la vita degli operai che lavoravano nella fabbrica di famiglia. Non sapeva che all’interno dei capannoni non venivano rispettate in alcun modo le misure di sicurezza. Il fatto che non fossero ancora accaduti incidenti gravi e che la nostra fabbrica non avesse fornito il proprio contribuito alle agghiaccianti statistiche riguardanti i morti sul lavoro era da imputare esclusivamente al caso. Da mesi avevo segnalato alla direzione il funzionamento difettoso del cancello, ma ero stato accuratamente ignorato. Non ne avevo mai parlato con Marcella per non farla preoccupare inutilmente. Ora però mi rendevo conto che il mio incidente si sarebbe potuto evitare e sentii il bisogno di renderla partecipe della mia rabbia.
“Un’ispezione avrebbe avuto effetti disastrosi per i proprietari della fabbrica. Là dentro non si rispettano le misure di sicurezza, la vita degli operai viene messa in pericolo in continuazione e gli ispettori non avrebbero alcuna difficoltà a riscontrarlo”.
“Ma... vuoi dire che sono stati i padroni a suggerire ai tuoi compagni di simulare l’incidente?”. Gli occhi sbarrati. Era sconvolta, incredula.
“Non penso. In ogni caso lo scoprirò presto”.
“Cosa pensi di fare?” domandò timorosa.
“Telefonerò a Piero. È l’unica persona di cui mi fidi ciecamente”.
Lo chiamai da un autogrill. La mia telefonata lo colse di sorpresa.
“Guido, sei tu. Come stai?”.
Non avevo alcuna intenzione di perdere tempo con una ridicola farsa.
“Sto come potrebbe stare dopo una lunga riabilitazione una persona rimasta schiacciata da un cancello automatico”.
Silenzio. Dall’altro capo del ricevitore giungeva l’inconfondibile voce di Maria Callas. Piero, oltre ad essere un appassionato di pesca sul fiume, era un amante competente dell’opera.
“Non capisco” balbettò dopo un po’.
Persi le staffe.
“Piero cazzo, almeno tu, smettila con questa commedia” urlai furioso nell’apparecchio.
“Io... io... io lo sapevo che era una cazzata!” gridò.
“Sbattermi in mezzo alla strada, vero? Ma come cazzo avete potuto fare una stronzata del genere!”.
Ero fuori di me. Mi accorsi che Piero era scoppiato a piangere. Quell’uomo alto un metro e novanta per quasi cento chili stava singhiozzando come un bambino. Stavo per finire il credito. Feci cenno a Marcella di passarmi altre monete.
“Piero, smettila di frignare e raccontami come sono andate le cose”.
Tirò su col naso.
“Sai anche tu che le norme di sicurezza non sono rispettate, nemmeno quelle di base. L’altro giorno ho controllato le date sugli estintori e sono tutti scaduti da almeno tre anni. Quando sei rimasto schiacciato dal cancello c’erano Donadoni e Del Re. Hanno capito subito che a un incidente sul lavoro sarebbe seguita un’ispezione e a un’ispezione sarebbe potuta seguire la chiusura della fabbrica. Eri privo di sensi, per un attimo hanno anche pensato che fossi morto. Hanno aspettato che non passasse nessuno e ti hanno adagiato sul bordo della strada. Poi sono tornati in fabbrica e hanno chiesto una mano per pulire il sangue dal cancello. Lì dentro hanno quasi tutti una famiglia da mantenere, Guido, è stata una bastardata, ma cerca di capire”. Piero raccontava concitato, senza pause, era chiaro che confessandomi come erano andate i fatti si stava togliendo un peso dalla coscienza, ed io incassavo le sue parole incapace di reagire, come un pugile suonato in balìa dell’avversario. “È capitato a loro due, ma poteva capitare ad altri. Nessuno in fabbrica ha trovato a ridire su ciò che avevano fatto. Anzi, la sensazione che ho avuto è che molti fossero perfino grati per la prontezza di spirito e il sangue freddo che avevano dimostrato. Non tutti avrebbero avuto le palle per agire così”.
A tanto era giunta la lotta dei poveri per la sopravvivenza. Ebbi la tentazione di sbattere il ricevitore sul telefono e mettere fine a quella conversazione. Inspirai profondamente.
“Grazie al sangue freddo di quei due avrei potuto morire” dissi ritrovando la calma.
“Lo so. E forse era quello che si aspettavano che accadesse. Quando si è saputo che eri sopravvissuto qualcuno ha iniziato a preoccuparsi che potessi ricordarti dell’incidente, di come erano andate le cose realmente. Poi però non succedeva nulla e la gente poco a poco si è tranquillizzata”.
“I Marzorati sono al corrente della verità?” domandai.
“No, è stata un’iniziativa di noi operai”.
Un flusso caldo si espanse per tutto il corpo. Avevo le mani viscide di sudore. La testa iniziò a girarmi, sentii la nausea strozzarmi le viscere. La Callas spezzò il silenzio che si era creato con un acuto da pelle d’oca.
“Mi hanno licenziato lo sai?”.
“Mi è giunta voce. Mi dispiace”.
“Ah ti dispiace? E dimmi, ti dispiace anche che sono ancora vivo?”.
“Guido ti prego, basta”.
“Basta lo decido io. Ti ho fatto una domanda”.
“No, sono contento”.
“E mi dici che cazzo dovrei fare adesso? Denunciarvi tutti?”.
“Non pensare solamente a noi. Pensa anche alle nostre famiglie”.
Una rabbia cieca mi montò dentro ed esplose violenta come un’eruzione vulcanica.
“Ma porca puttana Piero, come cazzo fai a dirmi una cosa del genere?! Pensare alle vostre famiglie? E alla mia di famiglia, me lo dici chi cazzo ci pensa?”.
“Scusa, hai ragione” farfugliò imbarazzato.
“Scusa un cazzo. Andate tutti a cagare”. Riagganciai la cornetta con foga e sfogai la mia ira tirando un pugno contro il vetro della cabina.
Feci un riassunto della telefonata a Marcella che mi ascoltò allibita e incapace di proferire qualcosa.
Quella sera la testa mi scoppiava e rimasi sveglio fino a tardi senza riuscire ad addormentarmi. Mi alzai dal letto e andai a sedermi sul divano in sala. Fu in quel momento, con lo sguardo fisso sullo schermo spento della televisione, che decisi quello che avrei fatto e che il giorno dopo effettivamente feci. Avrei raccontato ai fratelli Marzorati la verità sul mio incidente, offrendo loro la possibilità di scegliere tra la mia riassunzione o la denuncia alla magistratura di come si erano svolti i fatti. Non avevo dubbi su cosa avrebbero scelto. Nonostante non fossero direttamente responsabili, erano comunque ampiamente coinvolti nella vicenda e avevano la coscienza sufficientemente sporca per volere evitare ad ogni costo che il nome della loro azienda finisse sui banchi di un tribunale.
Il lunedì successivo infatti ripresi regolarmente il mio posto di lavoro come custode. Gli operai entrarono in fabbrica lanciandomi rapide occhiate e abbassando immediatamente lo sguardo, come se avessero visto un fantasma. Non salutai nessuno. Per me erano tutti morti.
Mi accorsi del cigolio del cancello automatico troppo tardi. Pensare che ero stato io ad insistere affinché il binario su cui scorreva venisse lubrificato con dell’olio perché lo stridore acuto provocato dall’attrito del metallo sul metallo era diventato insopportabile. Quando mi volsi feci appena in tempo a vedere il cancello che mi investiva, facendomi perdere l’equilibrio. Una volta a terra, provai disperatamente a spostarmi dalla traiettoria. Non ne ebbi il tempo e il cancello si richiuse pesantemente, schiacciandomi contro il muro. Sentii un dolore acuto e profondo all’altezza del bacino. Ebbi la sensazione che il corpo si fosse spezzato in due, come se le gambe non mi appartenessero più. Poi mi si annebbiò la vista e persi conoscenza.
Quando riaprii gli occhi vidi il volto offuscato di un uomo chino su di me. Alle sue spalle una fredda luce al neon e in sottofondo l’ululato continuo di una sirena. Mi trovavo sulla barella di un’ambulanza. Non ricordavo nulla dell’incidente.
“Cosa è successo? Perché mi trovo qui?”.
“È stato investito da un’automobile di fronte all’ingresso della ditta per cui lavora”.
Automobile? Non ricordavo niente. Sentii la testa esplodere, poi nuovamente il nulla.
Marcella era seduta accanto al letto e mi teneva la mano stretta tra le sue. Sorrise.
“Finalmente ti sei svegliato”.
“Dove siamo?” domandai ancora mezzo intontito.
“All’ospedale. Hai avuto un incidente grave, ti hanno operato”.
“Non sento le gambe”.
“È l’effetto dell’anestesia. Il medico ha detto che ci vorrà qualche ora per riacquistare la completa sensibilità degli arti inferiori”.
“Che tipo di incidente?”.
“Sei stato investito da un’automobile all’uscita del lavoro. Il conducente della macchina non si è fermato per soccorrerti, un ragazzo che passava di lì in scooter ti ha trovato sul marciapiede in un lago di sangue e ha chiamato l’ambulanza. Purtroppo non ci sono testimoni dell’incidente”.
Chiusi gli occhi e mi sforzai per recuperare il ricordo della scena dell’incidente. Non si materializzò nessuna vettura. La stanza era invasa dall’odore di verdure bollite.
“Marcella, che cosa ho?”.
“Hai una frattura delle branche ileo e ischiopubiche”.
“Cioè?”.
“Hai il bacino rotto in più punti”.
“Nient’altro?”.
“Sì. Sei stato sottoposto a un intervento chirurgico di uretroplastica”.
“Cazzo Marcella, mi sembra di parlare con un dottore! Non mi puoi spiegare con parole semplici quello che mi hanno fatto?”.
“Avevi l’uretra spezzata e ti hanno inserito un catetere”.
“Vuoi dire che piscerò attraverso un tubo di plastica? Per quanto tempo?”.
“Almeno tre settimane”.
Affondai il capo nel cuscino e restai a fissare il soffitto bianco della stanza. Era scrostato in alcuni punti. Un vecchio ventilatore fendeva l’afa e ronzava ritmicamente come una mosca instancabile. Non sentivo le gambe. Allungai una mano e l’appoggiai su una coscia.
“Tornerò a camminare?”.
“Certo! Però ci vorrà tempo”.
“Quanto?”.
“La riabilitazione sarà lunga, circa tre mesi”.
Tre mesi. Mi domandai se fosse un tempo sufficiente per essere licenziato. Sì, era fin troppo. Lavoravo come custode per quella ditta da parecchi anni e conoscevo bene i padroni, due fratelli senza scrupoli che avrebbero trovato facilmente una scusa per sbattermi la porta in faccia nonostante il contratto in regola. Le condizioni di lavoro degli operai nella fabbrica erano pessime, i turni massacranti, gli straordinari non pagati all’ordine del giorno, le malattie dei dipendenti sopportate mal volentieri dai titolari, il tutto sotto la subdola e costante minaccia della cassa integrazione. Essere licenziato a sessantaquattro anni significava avere la garanzia di aspettare la pensione per dodici mesi da disoccupato. Guardai Marcella con sconforto.
“Sarà dura”.
Mi strinse più forte la mano.
“Ce la farai”.
“Sì, ma sarà difficile. Non solo per me, sarà dura per noi. Potrebbero licenziarmi”.
Un lampo d’odio le attraversò lo sguardo.
“Sarebbe una bastardata”.
“Dimentichi che i fratelli Marzorati sono dei bastardi”.
“Non pensiamoci adesso” sospirò. “Ora devo andare, ma tornerò domani”.
Mi accarezzò la testa, mi sfiorò la fronte con un rapido bacio e uscì dalla stanza.
Mi guardai intorno. Il letto di fianco al mio era vuoto. Quelli di fronte erano occupati da due anziani che, da quando ero sveglio, non avevano ancora ricevuto visite. Entrò un’infermiera a cambiarmi la flebo e misurarmi la temperatura.
“Non ha febbre, ottimo. Cerchi di riposare, ne ha bisogno per riprendersi dall’operazione”. La voce un po’ cantilenante.
“Dove vuole che vada” replicai brusco.
Mi osservò sorpresa.
“Mi scusi, sono un po’ nervoso” mi giustificai.
Rimasto solo, ripercorsi un’altra volta gli attimi precedenti all’incidente. Nell’ultima immagine che mi ricordavo ero sul cancello che parlavo con alcuni dipendenti che avevano finito il turno. Poi il buio. A che ora era successo l’incidente? Avevo già finito di lavorare? Perché mi trovavo in mezzo alla strada? Mi avevano ritrovato dopo quanto tempo? Possibile che nessuno avesse visto niente? Avvertii un leggero formicolio alle gambe. Mano a mano che ne riacquistavo la sensibilità, aumentava il dolore intorno alla vita. Quello alla testa non mi aveva mai abbandonato da quando avevo riaperto gli occhi.
Restai in ospedale venti giorni. Il decorso post-operatorio venne in parte rovinato da una fastidiosa gastrite che mi colpì alcuni giorni dopo l’intervento chirurgico. Dopo due settimane Marcella mi disse che era giunta a casa una lettera della ditta dei fratelli Marzorati. Non avevano perso tempo. Dall’ospedale San Raffaele venni in seguito trasferito nella struttura ospedaliera di San Pancrazio ad Arco, in provincia di Trento, presso la sezione di Riabilitazione Motoria. Ogni mattina venivo sottoposto a esercizi di mobilizzazione articolare e rinforzo muscolare e dopo tre settimane iniziai un allenamento deambulatorio con l’aiuto delle stampelle. Con un breve ma doloroso intervento mi venne tolto il catetere e tornai finalmente a orinare per via naturale. Un elettrocardiogramma di controllo evidenziò una necrosi anterosettale e un’ischemia subepicardica antero-laterale. Secondo i medici soffrivo di una cardiopatia postinfartuale per la quale mi suggerivano caldamente una rivascolarizzazione coronarica. Suscitando il loro stupore, rifiutai con decisione l’eventualità di un’ulteriore operazione. Non ne potevo più di restare rinchiuso in un ospedale. Non sopportavo più le infermiere troppo gentili, il cibo precotto, le visite giornaliere dei dottori, l’asfissiante loquacità dei compagni di stanza, ma soprattutto non soffrivo più gli orari e i ritmi da prigione che mi riportavano con la mente indietro nel tempo, riesumando un’epoca della mia vita che avevo accuratamente seppellito nella parte più profonda della memoria. L’unica cosa che desideravo in quel momento era tornare a casa.
La degenza nel secondo ospedale durò un mese.
Marcella si presentò puntuale a mezzogiorno. Aveva ripreso a lavorare al mercato e da quando ero stato trasferito in Trentino riusciva a venire a trovarmi solamente durante il fine settimana, ma per riportarmi a casa si era presa un giorno di ferie e si era svegliata all’alba per giungere in ospedale il prima possibile. Quando la vidi entrare ebbi la tentazione di saltare giù dal letto e correrle incontro per abbracciarla. Impiegammo pochi minuti a mettere in una borsa le poche cose che avevo e, dopo avere firmato il foglio di dimissioni, mi ritrovai finalmente all’aria aperta, nel piazzale di fronte all’ospedale. Mi fermai un attimo e feci tre lunghi respiri, poi saltellando sulle stampelle seguii Marcella verso l’uscita. Giunti a pochi metri dal gabbiottino, il tizio che vi era rinchiuso dentro ci salutò con la mano e azionò il cancello automatico. L’immagine mancante dell’incidente si materializzò improvvisa davanti ai miei occhi.
“Non mi ha investito una macchina” pensai ad voce alta.
“Cosa hai detto?”.
“Non mi ha investito una macchina” ripetei, questa volta rivolto a Marcella.
“Cosa stai dicendo, Guido. Ti hanno trovato in mezzo alla strada”.
“Mi ci hanno trascinato. Sono rimasto schiacciato dal cancello di ingresso della fabbrica”.
“Ti ha trascinato chi?”.
“Non lo so, ma credo qualcuno che lavora alla fabbrica, non vedo altra possibilità”.
“Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? È un’accusa gravissima. E poi dimmi, che motivo avevano per farlo?”.
Era come se all’improvviso fosse tutto chiaro, lampante, così evidente da sembrare impossibile che non lo avessi capito prima.
“Un incidente all’interno della fabbrica avrebbe avuto come conseguenza immediata un controllo da parte dell’ispettorato del lavoro”.
“E allora?”.
Marcella non capiva, ma in fondo non era colpa sua. Non poteva capire. Marcella ignorava che i fratelli Marzorati avevano più a cuore le sorti della loro squadra di calcio preferita che la vita degli operai che lavoravano nella fabbrica di famiglia. Non sapeva che all’interno dei capannoni non venivano rispettate in alcun modo le misure di sicurezza. Il fatto che non fossero ancora accaduti incidenti gravi e che la nostra fabbrica non avesse fornito il proprio contribuito alle agghiaccianti statistiche riguardanti i morti sul lavoro era da imputare esclusivamente al caso. Da mesi avevo segnalato alla direzione il funzionamento difettoso del cancello, ma ero stato accuratamente ignorato. Non ne avevo mai parlato con Marcella per non farla preoccupare inutilmente. Ora però mi rendevo conto che il mio incidente si sarebbe potuto evitare e sentii il bisogno di renderla partecipe della mia rabbia.
“Un’ispezione avrebbe avuto effetti disastrosi per i proprietari della fabbrica. Là dentro non si rispettano le misure di sicurezza, la vita degli operai viene messa in pericolo in continuazione e gli ispettori non avrebbero alcuna difficoltà a riscontrarlo”.
“Ma... vuoi dire che sono stati i padroni a suggerire ai tuoi compagni di simulare l’incidente?”. Gli occhi sbarrati. Era sconvolta, incredula.
“Non penso. In ogni caso lo scoprirò presto”.
“Cosa pensi di fare?” domandò timorosa.
“Telefonerò a Piero. È l’unica persona di cui mi fidi ciecamente”.
Lo chiamai da un autogrill. La mia telefonata lo colse di sorpresa.
“Guido, sei tu. Come stai?”.
Non avevo alcuna intenzione di perdere tempo con una ridicola farsa.
“Sto come potrebbe stare dopo una lunga riabilitazione una persona rimasta schiacciata da un cancello automatico”.
Silenzio. Dall’altro capo del ricevitore giungeva l’inconfondibile voce di Maria Callas. Piero, oltre ad essere un appassionato di pesca sul fiume, era un amante competente dell’opera.
“Non capisco” balbettò dopo un po’.
Persi le staffe.
“Piero cazzo, almeno tu, smettila con questa commedia” urlai furioso nell’apparecchio.
“Io... io... io lo sapevo che era una cazzata!” gridò.
“Sbattermi in mezzo alla strada, vero? Ma come cazzo avete potuto fare una stronzata del genere!”.
Ero fuori di me. Mi accorsi che Piero era scoppiato a piangere. Quell’uomo alto un metro e novanta per quasi cento chili stava singhiozzando come un bambino. Stavo per finire il credito. Feci cenno a Marcella di passarmi altre monete.
“Piero, smettila di frignare e raccontami come sono andate le cose”.
Tirò su col naso.
“Sai anche tu che le norme di sicurezza non sono rispettate, nemmeno quelle di base. L’altro giorno ho controllato le date sugli estintori e sono tutti scaduti da almeno tre anni. Quando sei rimasto schiacciato dal cancello c’erano Donadoni e Del Re. Hanno capito subito che a un incidente sul lavoro sarebbe seguita un’ispezione e a un’ispezione sarebbe potuta seguire la chiusura della fabbrica. Eri privo di sensi, per un attimo hanno anche pensato che fossi morto. Hanno aspettato che non passasse nessuno e ti hanno adagiato sul bordo della strada. Poi sono tornati in fabbrica e hanno chiesto una mano per pulire il sangue dal cancello. Lì dentro hanno quasi tutti una famiglia da mantenere, Guido, è stata una bastardata, ma cerca di capire”. Piero raccontava concitato, senza pause, era chiaro che confessandomi come erano andate i fatti si stava togliendo un peso dalla coscienza, ed io incassavo le sue parole incapace di reagire, come un pugile suonato in balìa dell’avversario. “È capitato a loro due, ma poteva capitare ad altri. Nessuno in fabbrica ha trovato a ridire su ciò che avevano fatto. Anzi, la sensazione che ho avuto è che molti fossero perfino grati per la prontezza di spirito e il sangue freddo che avevano dimostrato. Non tutti avrebbero avuto le palle per agire così”.
A tanto era giunta la lotta dei poveri per la sopravvivenza. Ebbi la tentazione di sbattere il ricevitore sul telefono e mettere fine a quella conversazione. Inspirai profondamente.
“Grazie al sangue freddo di quei due avrei potuto morire” dissi ritrovando la calma.
“Lo so. E forse era quello che si aspettavano che accadesse. Quando si è saputo che eri sopravvissuto qualcuno ha iniziato a preoccuparsi che potessi ricordarti dell’incidente, di come erano andate le cose realmente. Poi però non succedeva nulla e la gente poco a poco si è tranquillizzata”.
“I Marzorati sono al corrente della verità?” domandai.
“No, è stata un’iniziativa di noi operai”.
Un flusso caldo si espanse per tutto il corpo. Avevo le mani viscide di sudore. La testa iniziò a girarmi, sentii la nausea strozzarmi le viscere. La Callas spezzò il silenzio che si era creato con un acuto da pelle d’oca.
“Mi hanno licenziato lo sai?”.
“Mi è giunta voce. Mi dispiace”.
“Ah ti dispiace? E dimmi, ti dispiace anche che sono ancora vivo?”.
“Guido ti prego, basta”.
“Basta lo decido io. Ti ho fatto una domanda”.
“No, sono contento”.
“E mi dici che cazzo dovrei fare adesso? Denunciarvi tutti?”.
“Non pensare solamente a noi. Pensa anche alle nostre famiglie”.
Una rabbia cieca mi montò dentro ed esplose violenta come un’eruzione vulcanica.
“Ma porca puttana Piero, come cazzo fai a dirmi una cosa del genere?! Pensare alle vostre famiglie? E alla mia di famiglia, me lo dici chi cazzo ci pensa?”.
“Scusa, hai ragione” farfugliò imbarazzato.
“Scusa un cazzo. Andate tutti a cagare”. Riagganciai la cornetta con foga e sfogai la mia ira tirando un pugno contro il vetro della cabina.
Feci un riassunto della telefonata a Marcella che mi ascoltò allibita e incapace di proferire qualcosa.
Quella sera la testa mi scoppiava e rimasi sveglio fino a tardi senza riuscire ad addormentarmi. Mi alzai dal letto e andai a sedermi sul divano in sala. Fu in quel momento, con lo sguardo fisso sullo schermo spento della televisione, che decisi quello che avrei fatto e che il giorno dopo effettivamente feci. Avrei raccontato ai fratelli Marzorati la verità sul mio incidente, offrendo loro la possibilità di scegliere tra la mia riassunzione o la denuncia alla magistratura di come si erano svolti i fatti. Non avevo dubbi su cosa avrebbero scelto. Nonostante non fossero direttamente responsabili, erano comunque ampiamente coinvolti nella vicenda e avevano la coscienza sufficientemente sporca per volere evitare ad ogni costo che il nome della loro azienda finisse sui banchi di un tribunale.
Il lunedì successivo infatti ripresi regolarmente il mio posto di lavoro come custode. Gli operai entrarono in fabbrica lanciandomi rapide occhiate e abbassando immediatamente lo sguardo, come se avessero visto un fantasma. Non salutai nessuno. Per me erano tutti morti.
 Argomenti simili
Argomenti simili» Il baco e la farfalla (capitolo 2)
» Il baco e la farfalla (capitolo 12)
» Il baco e la farfalla (capitolo 24)
» Il baco e la farfalla (capitolo 3)
» Il baco e la farfalla (capitolo 13)
» Il baco e la farfalla (capitolo 12)
» Il baco e la farfalla (capitolo 24)
» Il baco e la farfalla (capitolo 3)
» Il baco e la farfalla (capitolo 13)
:: Vetrina Autori :: Opere :: Diego Repetto
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.|
|
|






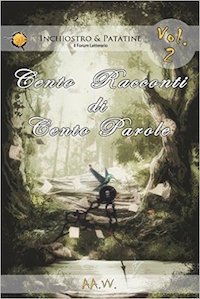
» concorso internazionale poesia e narrativa UN MONTE DI POESIA
» Premio di Poesia, Narrativa, Teatro e Pittura "Luce dell'Arte" 6^ Edizione
» concorso letterario internazionale UN MONTE DI POESIA XVI edizione
» IV^ Edizione del Premio di Narrativa, Teatro e Poesia "Il buon riso fa buon sangue". Scadenza bando 20/07/2022
» UN PONTE TRA NOI - RECENSIONE DI ARMANDO MASCHINI
» UN PONTE TRA NOI - RECENSIONE DI GIULIANA PARAGLIOLA