Il baco e la farfalla (capitolo 26)
:: Vetrina Autori :: Opere :: Diego Repetto
Pagina 1 di 1
 Il baco e la farfalla (capitolo 26)
Il baco e la farfalla (capitolo 26)
Ottobre 1967
Mancava una settimana all’operazione e Marco iniziava a manifestare visibili segni di nervosismo. Quello che lo angustiava non era l’intervento in sé, sulla cui riuscita non nutriva alcun dubbio, come aveva più volte sottolineato tessendo le lodi dell’ortopedico incaricato di ricostruirgli i legamenti del ginocchio. Lo terrorizzavano la convalescenza, il riposo forzato, il non poter lavorare per qualche settimana nella migliore delle ipotesi, o, nella peggiore, per qualche mese. Il periodo di inattività, gli aveva pazientemente spiegato il professor Desio, un luminare della medicina, sarebbe dipeso da come avrebbe reagito l’arto e solamente ventiquattrore dopo l’operazione si sarebbe potuta fare una previsione più accurata sui tempi di recupero. Perfino l’idea di dover trascorrere l’intera giornata con la moglie e i figli era per Lomellini fonte di preoccupazione. Sosteneva che con gli anni aveva imparato ad amarli a distanza, che non era più abituato alla loro presenza. Temeva che una nuova quotidianità potesse incrinare gli equilibri della loro relazione e che questi si rivelassero più deboli di quanto credesse.
Con l’operazione di Marco si avvicinava anche la mia partenza per la Puglia. Ormai non ero più solamente il suo autista, ero molto di più. Col tempo mi ero trasformato nell’amico fidato, nel compagno di viaggi, nel punchball su cui sfogare, in maniera controllata, ire e paure. Marco aveva bisogno di me e io di lui. Sentivo l’imminente partenza come un distacco dal grembo materno, protettivo e conosciuto, verso un mondo nuovo la cui scoperta mi affascinava e, contemporaneamente, mi intimoriva. Era come se mi fossi dimenticato dei mesi precedenti all’incontro con Marco, quando, seppur con alterni risultati, avevo dimostrato di essere in grado di badare a me stesso. Poi però la mia vita era cambiata e il lavoro non aveva più rappresentato un enigma da risolvere giorno per giorno. Uscire dal solido guscio che Lomellini mi aveva costruito intorno significava affrontare nudo e senza difese un cammino incognito. Ma in fondo, mi ripetevo per tranquillizzarmi, quattro mesi sarebbero passati in fretta. La mia era una scommessa che avrebbe avuto in ogni caso un lieto fine. Prima dell’arrivo della primavera infatti sarei tornato ad accomodarmi sul sedile dell’Alfa e avrei ripreso ad accompagnare Marco in giro per riunioni, incontri, cene e appuntamenti mondani. La sua vita, che ormai era diventata anche la mia.
Il giorno prima di finire sotto i ferri, Lomellini mi consegnò una lettera per il capo cantiere nella quale lo invitava a trovare qualcosa da farmi fare nei successivi quattro mesi. Per i miei primi passi avrei avuto ancora Marco al mio fianco, la sua lettera avrebbe reso l’inizio della mia avventura in Puglia molto più semplice.
“Ci vediamo nel mio ufficio a Milano il primo lunedì di marzo. Buona fortuna e mi raccomando, non fare cazzate”.
“Nella mia vita ne ho già fatta una piuttosto grande, non ho intenzione di concedere il bis” risposi ridendo. Quando ci abbracciammo sentii come se stessi salutando un padre più che un amico.
Mi presentai al cantiere stravolto dal lungo viaggio. All’operaio all’entrata dissi che volevo incontrare il capo. Dopo avermi osservato come se fossi un animale raro in via di estinzione, mi informò che sarebbe passato dopo pranzo. Avevo le gambe legnose impregnate di acido lattico e mi lasciai scivolare per terra, con la schiena appoggiata allo zaino.
“Ehi tu, ce l’hai qualcosa da mangiare?”.
Scossi la testa. L’operaio si avvicinò e mi porse un sacchetto di carta.
“Mia moglie esagera sempre, dice che sono pelle e ossa. Prendine uno, per me l’altro è più che sufficiente”.
“Grazie”.
Ero piacevolmente stupito, non mi aspettavo una simile accoglienza. Scartai l’involucro e ne estrassi un panino dall’aria invitante. Il primo morso ebbe l’effetto di un soffio di vento in un viale d’autunno e spazzò via i leggeri e ormai secchi timori della vigilia.
Il capo cantiere mi sorprese addormentato.
“Mi hanno detto che mi cercavi” brontolò scortese.
Gli porsi la lettera. Iniziò a leggerla e l’impazienza che aveva dipinta sul viso svanì immediatamente.
“Troveremo sicuramente un lavoro adatto a te” disse in tono cordiale. “Dimmi, cosa sai fare?”.
Elencai i lavori che avevo svolto nel corso della mia vita, tralasciando volutamente il pastore, il marinaio e il bagnino che ritenni inutili ai fini di un impiego in un cantiere edile.
“Ho proprio bisogno di un autista per il furgone, lo abbiamo appena preso. Farai la spola con il paese”.
Quell’incarico mi avrebbe permesso di andare spesso a Candela durante il giorno. Feci il possibile per mascherare il mio entusiasmo e per non tradire la vera ragione per cui mi trovavo di fronte a quell’uomo.
“Sai già dove andare a dormire?”.
“A dire il vero non ci avevo ancora pensato”.
“Qui dietro c’è una roulotte, puoi restarci un paio di notti. Poi dovrai trovarti una stanza da qualche altra parte”.
Mi strinse vigorosamente la mano.
“Benvenuto al Sud”.
Due giorni dopo affittai una mansarda nel centro del paese. Il proprietario l’aveva utilizzata negli ultimi anni come ripostiglio, riversandoci tutto ciò di cui non aveva più bisogno, ma che in mancanza di un buon motivo si era sempre rifiutato di buttare via. La mia richiesta aveva rappresentato l’occasione giusta per disfarsi finalmente di quell’accozzaglia di oggetti vecchi. Mi sarei dovuto incaricare dello sgombero, in cambio non avrei pagato l’affitto per la prima settimana. La mansarda si affacciava sulla via principale che tagliava a metà il paese, vicino al bar di fronte al quale era avvenuto lo scontro con Sara. Il posto mi parve un punto di osservazione strategico e accettai la proposta. Antonio, un compagno di lavoro, si offrì gentilmente di aiutarmi a rimetterla in ordine. Impiegammo un’intera giornata e un paio di litri di birra a testa per svuotarla e ripulirla dalla polvere e dalle ragnatele. Tra gli oggetti recuperai le uniche due sedie aventi quattro gambe, una brandina e una lucerna a olio. Antonio mi avrebbe procurato un materasso. Prima di richiudere la porta, diedi un’ultima occhiata al risultato della nostra fatica. Non era certo la villa di Lomellini e non ricordava nemmeno lontanamente una delle stanze degli alberghi di lusso che eravamo soliti frequentare durante i nostri viaggi, ma per il momento poteva bastare. Ora si trattava di attendere con pazienza e avere un po’ di fortuna.
La spola con il paese, su cui avevo riposto le speranze per rincontrare Sara, consisteva in realtà in sporadici viaggi, non più di un paio a settimana, effettuati per lo più per procurarsi piccoli utensili e materiale elettrico in piccola quantità. Giunto all’altezza delle prime case, rallentavo l’andatura e percorrevo il paese a passo d’uomo, spazzando con lo sguardo entrambi i marciapiedi, controllando ogni figura femminile che entrasse nel mio campo visivo, introducendomi con gli occhi in ogni angolo e stradina laterale. Dopo una quindicina di giorni durante i quali di Sara non avevo scorto nemmeno l’ombra, mi resi conto che avrei dovuto escogitare qualcosa per aumentare la frequenza delle mie visite in paese, ma soprattutto, pensai, avrei dovuto cambiare le mie destinazioni. Non l’avrei mai incontrata dal ferramenta, tanto meno dall’elettricista. Sei mesi prima il nostro incontro era avvenuto di mercoledì, lo avevo annotato sul calendario. Il mercoledì era il giorno del mercato, nella piazza del municipio. Era probabile che Sara avesse comprato la cassetta di albicocche proprio lì, forse ci andava ogni settimana a fare la spesa. Dovevo fare in modo di andarci anch’io, al mercato le probabilità di rivederla sarebbero aumentate, ne ero certo.
Il cantiere sorgeva in un luogo isolato lungo la statale e distava cinque chilometri dal centro abitato più vicino. Il collegamento tra Candela e il cantiere era garantito da una corriera che effettuava quattro corse giornaliere. Durante la pausa pranzo gli operai erano costretti a fermarsi al cantiere. Ognuno si portava da casa qualcosa da mangiare, un panino o qualche avanzo della cena del giorno prima. Fu grazie alla pigrizia nel prepararmi il pranzo che ebbi l’idea di come iniziare a frequentare il mercato. Gli operai mostrarono entusiasmo fin da subito, restava da convincere il capo cantiere. All’iniziò si dimostrò restio all’idea di trasformare in una mensa una parte del parcheggio. Tre tavoli di legno avrebbero occupato troppo spazio, e poi chi avrebbe cucinato per venti persone? Chi sarebbe andato a fare la spesa? Gli anni trascorsi al fianco di Lomellini giunsero in mio soccorso e si rivelarono particolarmente utili per persuadere il capo cantiere ad approvare il pranzo in comune. Lo spirito di squadra ne sarebbe uscito rafforzato, gli dissi, e le ripercussioni positive sul lavoro degli operai non avrebbero tardato a farsi notare. Gli operai avrebbero fatto una colletta per coprire i costi e avrebbero cucinato a turno. Per la spesa non c’era problema, mi offrivo io di farla, una volta alla settimana.
Il mercoledì successivo, alle dieci in punto, lasciavo il cantiere a bordo del furgone, col cuore che batteva all’impazzata, diretto al mercato.
Parcheggiai in un viottolo dietro al municipio e proseguii a piedi. All’ingresso della piazza, mi fermai ad osservare il via vai incessante di persone che entravano e uscivano dal mercato. Sembravano un esercito di formiche che diligentemente si intrufolavano una dietro l’altra tra i banchi ricolmi e ne riemergevano poi cariche di provviste, disperdendosi in tutte le direzioni, per far ritorno ognuna al proprio formicaio. Presi il respiro e mi immersi nel cuore del mercato. Venni travolto dalla confusione e sballottato da una parte all’altra. Le grida continue e assordanti dei venditori intenti a declamare le virtù dei propri prodotti si mischiavano a quelle dei compratori che si informavano sulla qualità e i prezzi della merce. Odori forti e profumi intensi riempivano l’aria e saturavano le narici. Trascinato dalla corrente, mi resi immediatamente conto che era impossibile intraprendere un percorso predeterminato e sostare anche solo un istante per guardarsi intorno. Trovare una persona lì dentro equivaleva a vincere alla lotteria. Mi aggirai tra le bancarelle per circa un’ora, sperduto e sempre più demoralizzato. Stavo per rinunciare quando all’improvviso, a una ventina di metri, di fronte a un banco di verdure, notai una ragazza, di spalle, con una folta chioma nera che scendeva fluente lungo la schiena. Ricordavo bene i suoi capelli, avevo impressa l’immagine di lei che si allontanava dopo che Lomellini le aveva detto di non preoccuparsi che alle albicocche sul marciapiede avremmo pensato noi. Con rinnovato entusiasmo, mi feci largo a gomitate per raggiungerla. Mi trovavo ormai a pochi metri quando la vidi salutare il mercante e allontanarsi tra la folla. Accelerai il passo fino a ritrovarmi alle sue spalle e la afferrai per un braccio. La ragazza si voltò di scatto, spaventata, e mi guardò con aria stupita. Non avevo mai visto quel viso prima di allora.
“Scusa, mi eri sembrata un’altra persona” balbettai, profondamente deluso.
Sollevò le spalle e si dileguò tra la calca.
Rassegnato, girai su me stesso per recuperare il senso dell’orientamento e mi avviai in direzione del municipio. Poco prima di abbandonare la piazza, realizzai che mi ero dimenticato di fare la spesa. Recuperai la lista dalla tasca dei pantaloni e ritornai, controvoglia, tra i banchi del mercato. Avrei riempito tre o quattro scatoloni e sarebbero stati necessari altrettanti viaggi. Rimpiansi di non aver parcheggiato il furgone più vicino. Appena fuori dal mercato, diedi una moneta a un bambino dall’aria scaltra affinché controllasse le scatole che mano a mano gli avrei portato. Terminata la spesa, le avrei recuperate tutte insieme, con il furgone.
“Ehi, ma a te ti conosco”.
Mi voltai in direzione della voce.
“Tu un giorno mi rovesciasti una cassetta di albicocche”.
L’avevo ritrovata, era davanti a me, con le braccia tese lungo i fianchi a sorreggere due sporte traboccanti. Sorrideva, disincantata. Lo stesso tono di voce, gli stessi capelli. Neri, aveva gli occhi neri.
“Beh, non dici niente? Che ci fai da queste parti?”.
“Lavoro al cantiere lungo la statale” risposi simulando indifferenza.
“Ma dai. Che caso, no?”.
“Sì, curioso”. Ormai mi ero ripreso dalla sorpresa. “Vivi da queste parti?”.
“A due passi”.
Purtroppo non aveva compiuto nessun gesto per indicare almeno una direzione, per fornirmi un indizio.
“E vieni ogni settimana a comprare al mercato?”.
Mi pentii di averglielo chiesto. Non volevo soffocarla con le domande. Sara sembrò non curarsene.
“Sì, ogni mercoledì”.
Significava attendere una settimana e tentare di ritrovarla tra la moltitudine di gente che affollava il mercato.
“Senti, ti andrebbe se ci incontrassimo un pomeriggio? Sono arrivato da poco, potresti farmi da guida e farmi conoscere il paese e i dintorni” azzardai senza riflettere troppo.
Abbassò lo sguardo, titubante. Forse avevo osato troppo.
“Se sei libero possiamo vederci sabato prossimo” mormorò dopo alcuni secondi di silenzio.
“Per me va benissimo”.
“Dopo pranzo, alle tre, dalle scale del municipio”.
“Dopo pranzo, alle tre, dalle scale del municipio” ripetei come un disco incantato.
“Allora ciao, a sabato”.
“Ciao”.
La osservai allontanarsi, con lo sguardo che lentamente ridiscese lungo la schiena, accarezzandola. Quella sera avrei faticato ad addormentarmi. Sentii il bisogno di condividere l’emozione. Prima di cena avrei telefonato a Marco, per raccontargli dell’incontro e per sapere come procedeva la convalescenza.
Tre giorni dopo Sara giunse puntuale all’appuntamento. Ero arrivato dieci minuti in anticipo e la stavo aspettando seduto sui gradini della scalinata. Le andai incontro. I capelli bruni erano raccolti in una lunga coda e le ciocche ribelli erano fissate ai lati da quattro mollette colorate. La pettinatura le lasciava scoperto interamente il viso, in mezzo al quale, nonostante la carnagione scura, risaltavano le turgide labbra scarlatte. Indossava una camicetta bianca piuttosto aderente, con gli ultimi due bottoni sbottonati, che le fasciava il busto sottile lasciando poco spazio all’immaginazione. Una larga gonna turchese scendeva svolazzante fino alle caviglie. Aveva un’aria serena e spensierata.
“Ciao, come stai?” mi domandò mettendo in mostra due file di denti candidi.
“Bene e tu?”.
“In perfetta forma. Vieni, non perdiamo tempo, ti svelerò i segreti e le meraviglie di questo paese”.
Percorremmo tutte le stradine, anche le più recondite. Entrammo nella chiesa e, di nascosto, nella sagrestia e da lì ci arrampicammo per la stretta scala a chiocciola su per il campanile, dalla cui cima si godeva uno splendido panorama sulla campagna circostante. Visitammo una fattoria dove bevemmo latte appena munto. Rubammo una zucca da un orto di un tizio che, secondo Sara, era il più brutto e antipatico di tutta la provincia. Ridemmo, scherzammo e parlammo senza sosta fino al crepuscolo.
“Mi piacerebbe rivederti” le rivelai prima di separarci.
Questa volta non ebbe tentennamenti.
“Sabato prossimo, stesso posto e stessa ora. Anzi no, facciamo dietro alla vecchia torre”.
Al lavoro notarono il buon umore che mi accompagnava da qualche giorno. Alcuni compagni mi domandarono esplicitamente quale fosse la causa di tanta euforia, ottenendo in cambio risposte vaghe e sibilline. Non avevo alcuna intenzione di svelare loro il mio piccolo segreto, consapevole comunque che presto, in un paese così piccolo, lo avrebbero in ogni caso scoperto. Era stata Sara a raccomandarsi di non rendere pubblici i nostri incontri. Suo padre, un uomo conservatore che esecrava le idee libertine che iniziavano a diffondersi in quegli anni, non avrebbe accettato che la figlia minorenne si incontrasse, sola, con un forestiero vicino alla trentina. Del quale, tra l’altro, non sapeva nulla, e a poco gli sarebbe valso ricorrere alla figlia per ottenere maggiori informazioni. Sara, infatti, aveva provato a scavare nel mio passato, interrogandomi sulla mia famiglia. Non ora, non ancora, le avevo sussurrato. E lei, accorgendosi di avere toccato un tasto sbagliato, aveva prontamente cambiato argomento.
Il posto scelto da Sara era piuttosto isolato. La torre, una costruzione in pietra che in passato era stata eretta a difesa del paese e in seguito utilizzata come granaio, sorgeva ai confini del borgo ed era ormai abbandonata da tempo. Lo spiazzo che la circondava era stato invaso da piante e arbusti selvatici, accentuandone l’aspetto decadente. Da dietro la torre si diramavano due sentieri che si perdevano tra i campi. Ne inforcammo uno tra due ulivi che apparivano come sentinelle, contorte su sé stesse. Sara camminava svelta, come se avesse fretta di allontanarsi dal paese. Dopo una ventina di minuti si arrestò e indicò il prato alla sinistra del sentiero. Non vidi nulla e mi limitai a seguirla tra il verde sbiadito dell’erba alta. Avevamo percorso una cinquantina di metri quando Sara si fermò e iniziò a calpestare l’erba. Dopo qualche minuto osservò soddisfatta il risultato e si coricò supina sul giaciglio che aveva realizzato.
“Qui staremo tranquilli. Dai, sdraiati”.
Mi distesi al suo fianco e restammo in silenzio a fissare il cielo.
“Hai mai pensato a come sarai tra dieci anni?” le domandai all’improvviso.
“Tra dieci anni?” ripeté divertita.
“Sì, come ti immagini”.
“Vediamo... tra dieci anni... mi immagino un’attrice famosa, come Sofia Loren o, quella tedesca, come si chiama...”
“Marlene Dietrich?”
“Esatto, Marlene Dietrich. E mi vedo con addosso vestiti di seta e gioielli preziosi. Mi piacerebbe girare il mondo, percorrere le strade di Roma... o di Parigi!”.
“Roma è meravigliosa. È un museo all’aria aperta. Nelle piazze e nelle strade si respira la grandezza dell’antico impero, si è avvolti da un’atmosfera epica, unica. Ogni pietra che calpesti ha una leggenda da raccontare, dietro ogni angolo si nasconde un pezzetto di Storia”.
“Ti invidio, sai, che ci sei stato. Per me è un sogno e resterà tale”.
“Il solo limite ai nostri sogni è la nostra immaginazione”.
Non era una frase mia, non mi ricordavo dove l’avessi sentita, ma mi sembrò appropriata alle circostanze. Ci voltammo contemporaneamente, le guance adagiate sull’erba, i visi l’uno vicino all’altro. Sorrise. Nei suoi occhi luminosi mi parve di scorgere la sagoma inconfondibile del Colosseo.
Senza quasi rendermene conto, iniziai a parlarle del mio passato. Rispetto al suo, vissuto tra le tranquille mura domestiche e le terre intorno al paese in cui era nata, il mio era eccezionalmente burrascoso e, quando terminai di raccontare, commentò strabiliata:
“È la storia più incredibile che abbia mai sentito”.
Era vero, era difficile da credere, eppure era andata proprio così. La signora Milton, quando cinque anni prima ero tornato da lei in cerca di aiuto, aveva usato lo stesso aggettivo: incredibile. E come allora, quando ebbi finito la narrazione, sentii i ricordi, i più pesanti, alleggerirsi. Ricordi che, malgrado gli anni recenti, non avevano smesso del tutto di tormentarmi. Ebbi la conferma che dar fiato agli episodi più dolorosi della mia vita aveva una funzione terapeutica, equivaleva ad aprire una valvola di sicurezza e diminuire la pressione interna. Conservavo comunque una gelosia perversa per tutto ciò che mi era accaduto e, a dispetto degli effetti benefici, riuscivo a rivelare il mio passato solamente a persone che sentivo particolarmente vicino. Sara, nonostante ci conoscessimo da poco, era una di quelle.
“Quando la realtà trascende l’immaginazione, accade ciò che non avevamo né sognato né immaginato” filosofai.
Sara aggrottò la fronte, intimorita.
“Non dire così, mi fai paura”.
Risi.
“Ma si può sempre ricominciare da zero, non è mai troppo tardi” la rassicurai e con il pensiero ripercorsi a ritroso gli ultimi anni fino all’incontro con Marco.
Sfumature rossastre tinsero il cielo.
“Si è fatto tardi, devo tornare a casa. Ho promesso a mia madre di aiutarla a preparare la cena”.
Mi alzai e le porsi la mano.
“Marlene....”.
“Dai, non mi prendere in giro” si lamentò afferrandomi il braccio e sollevandosi in piedi. Ci fissammo un secondo, seri, poi le nostre risate riecheggiarono nella valle.
Ci vedevamo il mercoledì, al mercato, ma erano incontri fugaci. Il sabato, invece, avevamo tutto il pomeriggio per noi. Più stavamo insieme, più mi sentivo attratto, più la desideravo fisicamente. Passarono alcune settimane fino a quando, una sera, prima di separarci, la attirai verso di me e posai la mia bocca sulla sua. Sara non si ritrasse e restò come in attesa. Spinsi allora la lingua tra le sue labbra morbide e trasformai quel contatto casto in bacio lungo e appassionato.
Mancava una settimana all’operazione e Marco iniziava a manifestare visibili segni di nervosismo. Quello che lo angustiava non era l’intervento in sé, sulla cui riuscita non nutriva alcun dubbio, come aveva più volte sottolineato tessendo le lodi dell’ortopedico incaricato di ricostruirgli i legamenti del ginocchio. Lo terrorizzavano la convalescenza, il riposo forzato, il non poter lavorare per qualche settimana nella migliore delle ipotesi, o, nella peggiore, per qualche mese. Il periodo di inattività, gli aveva pazientemente spiegato il professor Desio, un luminare della medicina, sarebbe dipeso da come avrebbe reagito l’arto e solamente ventiquattrore dopo l’operazione si sarebbe potuta fare una previsione più accurata sui tempi di recupero. Perfino l’idea di dover trascorrere l’intera giornata con la moglie e i figli era per Lomellini fonte di preoccupazione. Sosteneva che con gli anni aveva imparato ad amarli a distanza, che non era più abituato alla loro presenza. Temeva che una nuova quotidianità potesse incrinare gli equilibri della loro relazione e che questi si rivelassero più deboli di quanto credesse.
Con l’operazione di Marco si avvicinava anche la mia partenza per la Puglia. Ormai non ero più solamente il suo autista, ero molto di più. Col tempo mi ero trasformato nell’amico fidato, nel compagno di viaggi, nel punchball su cui sfogare, in maniera controllata, ire e paure. Marco aveva bisogno di me e io di lui. Sentivo l’imminente partenza come un distacco dal grembo materno, protettivo e conosciuto, verso un mondo nuovo la cui scoperta mi affascinava e, contemporaneamente, mi intimoriva. Era come se mi fossi dimenticato dei mesi precedenti all’incontro con Marco, quando, seppur con alterni risultati, avevo dimostrato di essere in grado di badare a me stesso. Poi però la mia vita era cambiata e il lavoro non aveva più rappresentato un enigma da risolvere giorno per giorno. Uscire dal solido guscio che Lomellini mi aveva costruito intorno significava affrontare nudo e senza difese un cammino incognito. Ma in fondo, mi ripetevo per tranquillizzarmi, quattro mesi sarebbero passati in fretta. La mia era una scommessa che avrebbe avuto in ogni caso un lieto fine. Prima dell’arrivo della primavera infatti sarei tornato ad accomodarmi sul sedile dell’Alfa e avrei ripreso ad accompagnare Marco in giro per riunioni, incontri, cene e appuntamenti mondani. La sua vita, che ormai era diventata anche la mia.
Il giorno prima di finire sotto i ferri, Lomellini mi consegnò una lettera per il capo cantiere nella quale lo invitava a trovare qualcosa da farmi fare nei successivi quattro mesi. Per i miei primi passi avrei avuto ancora Marco al mio fianco, la sua lettera avrebbe reso l’inizio della mia avventura in Puglia molto più semplice.
“Ci vediamo nel mio ufficio a Milano il primo lunedì di marzo. Buona fortuna e mi raccomando, non fare cazzate”.
“Nella mia vita ne ho già fatta una piuttosto grande, non ho intenzione di concedere il bis” risposi ridendo. Quando ci abbracciammo sentii come se stessi salutando un padre più che un amico.
Mi presentai al cantiere stravolto dal lungo viaggio. All’operaio all’entrata dissi che volevo incontrare il capo. Dopo avermi osservato come se fossi un animale raro in via di estinzione, mi informò che sarebbe passato dopo pranzo. Avevo le gambe legnose impregnate di acido lattico e mi lasciai scivolare per terra, con la schiena appoggiata allo zaino.
“Ehi tu, ce l’hai qualcosa da mangiare?”.
Scossi la testa. L’operaio si avvicinò e mi porse un sacchetto di carta.
“Mia moglie esagera sempre, dice che sono pelle e ossa. Prendine uno, per me l’altro è più che sufficiente”.
“Grazie”.
Ero piacevolmente stupito, non mi aspettavo una simile accoglienza. Scartai l’involucro e ne estrassi un panino dall’aria invitante. Il primo morso ebbe l’effetto di un soffio di vento in un viale d’autunno e spazzò via i leggeri e ormai secchi timori della vigilia.
Il capo cantiere mi sorprese addormentato.
“Mi hanno detto che mi cercavi” brontolò scortese.
Gli porsi la lettera. Iniziò a leggerla e l’impazienza che aveva dipinta sul viso svanì immediatamente.
“Troveremo sicuramente un lavoro adatto a te” disse in tono cordiale. “Dimmi, cosa sai fare?”.
Elencai i lavori che avevo svolto nel corso della mia vita, tralasciando volutamente il pastore, il marinaio e il bagnino che ritenni inutili ai fini di un impiego in un cantiere edile.
“Ho proprio bisogno di un autista per il furgone, lo abbiamo appena preso. Farai la spola con il paese”.
Quell’incarico mi avrebbe permesso di andare spesso a Candela durante il giorno. Feci il possibile per mascherare il mio entusiasmo e per non tradire la vera ragione per cui mi trovavo di fronte a quell’uomo.
“Sai già dove andare a dormire?”.
“A dire il vero non ci avevo ancora pensato”.
“Qui dietro c’è una roulotte, puoi restarci un paio di notti. Poi dovrai trovarti una stanza da qualche altra parte”.
Mi strinse vigorosamente la mano.
“Benvenuto al Sud”.
Due giorni dopo affittai una mansarda nel centro del paese. Il proprietario l’aveva utilizzata negli ultimi anni come ripostiglio, riversandoci tutto ciò di cui non aveva più bisogno, ma che in mancanza di un buon motivo si era sempre rifiutato di buttare via. La mia richiesta aveva rappresentato l’occasione giusta per disfarsi finalmente di quell’accozzaglia di oggetti vecchi. Mi sarei dovuto incaricare dello sgombero, in cambio non avrei pagato l’affitto per la prima settimana. La mansarda si affacciava sulla via principale che tagliava a metà il paese, vicino al bar di fronte al quale era avvenuto lo scontro con Sara. Il posto mi parve un punto di osservazione strategico e accettai la proposta. Antonio, un compagno di lavoro, si offrì gentilmente di aiutarmi a rimetterla in ordine. Impiegammo un’intera giornata e un paio di litri di birra a testa per svuotarla e ripulirla dalla polvere e dalle ragnatele. Tra gli oggetti recuperai le uniche due sedie aventi quattro gambe, una brandina e una lucerna a olio. Antonio mi avrebbe procurato un materasso. Prima di richiudere la porta, diedi un’ultima occhiata al risultato della nostra fatica. Non era certo la villa di Lomellini e non ricordava nemmeno lontanamente una delle stanze degli alberghi di lusso che eravamo soliti frequentare durante i nostri viaggi, ma per il momento poteva bastare. Ora si trattava di attendere con pazienza e avere un po’ di fortuna.
La spola con il paese, su cui avevo riposto le speranze per rincontrare Sara, consisteva in realtà in sporadici viaggi, non più di un paio a settimana, effettuati per lo più per procurarsi piccoli utensili e materiale elettrico in piccola quantità. Giunto all’altezza delle prime case, rallentavo l’andatura e percorrevo il paese a passo d’uomo, spazzando con lo sguardo entrambi i marciapiedi, controllando ogni figura femminile che entrasse nel mio campo visivo, introducendomi con gli occhi in ogni angolo e stradina laterale. Dopo una quindicina di giorni durante i quali di Sara non avevo scorto nemmeno l’ombra, mi resi conto che avrei dovuto escogitare qualcosa per aumentare la frequenza delle mie visite in paese, ma soprattutto, pensai, avrei dovuto cambiare le mie destinazioni. Non l’avrei mai incontrata dal ferramenta, tanto meno dall’elettricista. Sei mesi prima il nostro incontro era avvenuto di mercoledì, lo avevo annotato sul calendario. Il mercoledì era il giorno del mercato, nella piazza del municipio. Era probabile che Sara avesse comprato la cassetta di albicocche proprio lì, forse ci andava ogni settimana a fare la spesa. Dovevo fare in modo di andarci anch’io, al mercato le probabilità di rivederla sarebbero aumentate, ne ero certo.
Il cantiere sorgeva in un luogo isolato lungo la statale e distava cinque chilometri dal centro abitato più vicino. Il collegamento tra Candela e il cantiere era garantito da una corriera che effettuava quattro corse giornaliere. Durante la pausa pranzo gli operai erano costretti a fermarsi al cantiere. Ognuno si portava da casa qualcosa da mangiare, un panino o qualche avanzo della cena del giorno prima. Fu grazie alla pigrizia nel prepararmi il pranzo che ebbi l’idea di come iniziare a frequentare il mercato. Gli operai mostrarono entusiasmo fin da subito, restava da convincere il capo cantiere. All’iniziò si dimostrò restio all’idea di trasformare in una mensa una parte del parcheggio. Tre tavoli di legno avrebbero occupato troppo spazio, e poi chi avrebbe cucinato per venti persone? Chi sarebbe andato a fare la spesa? Gli anni trascorsi al fianco di Lomellini giunsero in mio soccorso e si rivelarono particolarmente utili per persuadere il capo cantiere ad approvare il pranzo in comune. Lo spirito di squadra ne sarebbe uscito rafforzato, gli dissi, e le ripercussioni positive sul lavoro degli operai non avrebbero tardato a farsi notare. Gli operai avrebbero fatto una colletta per coprire i costi e avrebbero cucinato a turno. Per la spesa non c’era problema, mi offrivo io di farla, una volta alla settimana.
Il mercoledì successivo, alle dieci in punto, lasciavo il cantiere a bordo del furgone, col cuore che batteva all’impazzata, diretto al mercato.
Parcheggiai in un viottolo dietro al municipio e proseguii a piedi. All’ingresso della piazza, mi fermai ad osservare il via vai incessante di persone che entravano e uscivano dal mercato. Sembravano un esercito di formiche che diligentemente si intrufolavano una dietro l’altra tra i banchi ricolmi e ne riemergevano poi cariche di provviste, disperdendosi in tutte le direzioni, per far ritorno ognuna al proprio formicaio. Presi il respiro e mi immersi nel cuore del mercato. Venni travolto dalla confusione e sballottato da una parte all’altra. Le grida continue e assordanti dei venditori intenti a declamare le virtù dei propri prodotti si mischiavano a quelle dei compratori che si informavano sulla qualità e i prezzi della merce. Odori forti e profumi intensi riempivano l’aria e saturavano le narici. Trascinato dalla corrente, mi resi immediatamente conto che era impossibile intraprendere un percorso predeterminato e sostare anche solo un istante per guardarsi intorno. Trovare una persona lì dentro equivaleva a vincere alla lotteria. Mi aggirai tra le bancarelle per circa un’ora, sperduto e sempre più demoralizzato. Stavo per rinunciare quando all’improvviso, a una ventina di metri, di fronte a un banco di verdure, notai una ragazza, di spalle, con una folta chioma nera che scendeva fluente lungo la schiena. Ricordavo bene i suoi capelli, avevo impressa l’immagine di lei che si allontanava dopo che Lomellini le aveva detto di non preoccuparsi che alle albicocche sul marciapiede avremmo pensato noi. Con rinnovato entusiasmo, mi feci largo a gomitate per raggiungerla. Mi trovavo ormai a pochi metri quando la vidi salutare il mercante e allontanarsi tra la folla. Accelerai il passo fino a ritrovarmi alle sue spalle e la afferrai per un braccio. La ragazza si voltò di scatto, spaventata, e mi guardò con aria stupita. Non avevo mai visto quel viso prima di allora.
“Scusa, mi eri sembrata un’altra persona” balbettai, profondamente deluso.
Sollevò le spalle e si dileguò tra la calca.
Rassegnato, girai su me stesso per recuperare il senso dell’orientamento e mi avviai in direzione del municipio. Poco prima di abbandonare la piazza, realizzai che mi ero dimenticato di fare la spesa. Recuperai la lista dalla tasca dei pantaloni e ritornai, controvoglia, tra i banchi del mercato. Avrei riempito tre o quattro scatoloni e sarebbero stati necessari altrettanti viaggi. Rimpiansi di non aver parcheggiato il furgone più vicino. Appena fuori dal mercato, diedi una moneta a un bambino dall’aria scaltra affinché controllasse le scatole che mano a mano gli avrei portato. Terminata la spesa, le avrei recuperate tutte insieme, con il furgone.
“Ehi, ma a te ti conosco”.
Mi voltai in direzione della voce.
“Tu un giorno mi rovesciasti una cassetta di albicocche”.
L’avevo ritrovata, era davanti a me, con le braccia tese lungo i fianchi a sorreggere due sporte traboccanti. Sorrideva, disincantata. Lo stesso tono di voce, gli stessi capelli. Neri, aveva gli occhi neri.
“Beh, non dici niente? Che ci fai da queste parti?”.
“Lavoro al cantiere lungo la statale” risposi simulando indifferenza.
“Ma dai. Che caso, no?”.
“Sì, curioso”. Ormai mi ero ripreso dalla sorpresa. “Vivi da queste parti?”.
“A due passi”.
Purtroppo non aveva compiuto nessun gesto per indicare almeno una direzione, per fornirmi un indizio.
“E vieni ogni settimana a comprare al mercato?”.
Mi pentii di averglielo chiesto. Non volevo soffocarla con le domande. Sara sembrò non curarsene.
“Sì, ogni mercoledì”.
Significava attendere una settimana e tentare di ritrovarla tra la moltitudine di gente che affollava il mercato.
“Senti, ti andrebbe se ci incontrassimo un pomeriggio? Sono arrivato da poco, potresti farmi da guida e farmi conoscere il paese e i dintorni” azzardai senza riflettere troppo.
Abbassò lo sguardo, titubante. Forse avevo osato troppo.
“Se sei libero possiamo vederci sabato prossimo” mormorò dopo alcuni secondi di silenzio.
“Per me va benissimo”.
“Dopo pranzo, alle tre, dalle scale del municipio”.
“Dopo pranzo, alle tre, dalle scale del municipio” ripetei come un disco incantato.
“Allora ciao, a sabato”.
“Ciao”.
La osservai allontanarsi, con lo sguardo che lentamente ridiscese lungo la schiena, accarezzandola. Quella sera avrei faticato ad addormentarmi. Sentii il bisogno di condividere l’emozione. Prima di cena avrei telefonato a Marco, per raccontargli dell’incontro e per sapere come procedeva la convalescenza.
Tre giorni dopo Sara giunse puntuale all’appuntamento. Ero arrivato dieci minuti in anticipo e la stavo aspettando seduto sui gradini della scalinata. Le andai incontro. I capelli bruni erano raccolti in una lunga coda e le ciocche ribelli erano fissate ai lati da quattro mollette colorate. La pettinatura le lasciava scoperto interamente il viso, in mezzo al quale, nonostante la carnagione scura, risaltavano le turgide labbra scarlatte. Indossava una camicetta bianca piuttosto aderente, con gli ultimi due bottoni sbottonati, che le fasciava il busto sottile lasciando poco spazio all’immaginazione. Una larga gonna turchese scendeva svolazzante fino alle caviglie. Aveva un’aria serena e spensierata.
“Ciao, come stai?” mi domandò mettendo in mostra due file di denti candidi.
“Bene e tu?”.
“In perfetta forma. Vieni, non perdiamo tempo, ti svelerò i segreti e le meraviglie di questo paese”.
Percorremmo tutte le stradine, anche le più recondite. Entrammo nella chiesa e, di nascosto, nella sagrestia e da lì ci arrampicammo per la stretta scala a chiocciola su per il campanile, dalla cui cima si godeva uno splendido panorama sulla campagna circostante. Visitammo una fattoria dove bevemmo latte appena munto. Rubammo una zucca da un orto di un tizio che, secondo Sara, era il più brutto e antipatico di tutta la provincia. Ridemmo, scherzammo e parlammo senza sosta fino al crepuscolo.
“Mi piacerebbe rivederti” le rivelai prima di separarci.
Questa volta non ebbe tentennamenti.
“Sabato prossimo, stesso posto e stessa ora. Anzi no, facciamo dietro alla vecchia torre”.
Al lavoro notarono il buon umore che mi accompagnava da qualche giorno. Alcuni compagni mi domandarono esplicitamente quale fosse la causa di tanta euforia, ottenendo in cambio risposte vaghe e sibilline. Non avevo alcuna intenzione di svelare loro il mio piccolo segreto, consapevole comunque che presto, in un paese così piccolo, lo avrebbero in ogni caso scoperto. Era stata Sara a raccomandarsi di non rendere pubblici i nostri incontri. Suo padre, un uomo conservatore che esecrava le idee libertine che iniziavano a diffondersi in quegli anni, non avrebbe accettato che la figlia minorenne si incontrasse, sola, con un forestiero vicino alla trentina. Del quale, tra l’altro, non sapeva nulla, e a poco gli sarebbe valso ricorrere alla figlia per ottenere maggiori informazioni. Sara, infatti, aveva provato a scavare nel mio passato, interrogandomi sulla mia famiglia. Non ora, non ancora, le avevo sussurrato. E lei, accorgendosi di avere toccato un tasto sbagliato, aveva prontamente cambiato argomento.
Il posto scelto da Sara era piuttosto isolato. La torre, una costruzione in pietra che in passato era stata eretta a difesa del paese e in seguito utilizzata come granaio, sorgeva ai confini del borgo ed era ormai abbandonata da tempo. Lo spiazzo che la circondava era stato invaso da piante e arbusti selvatici, accentuandone l’aspetto decadente. Da dietro la torre si diramavano due sentieri che si perdevano tra i campi. Ne inforcammo uno tra due ulivi che apparivano come sentinelle, contorte su sé stesse. Sara camminava svelta, come se avesse fretta di allontanarsi dal paese. Dopo una ventina di minuti si arrestò e indicò il prato alla sinistra del sentiero. Non vidi nulla e mi limitai a seguirla tra il verde sbiadito dell’erba alta. Avevamo percorso una cinquantina di metri quando Sara si fermò e iniziò a calpestare l’erba. Dopo qualche minuto osservò soddisfatta il risultato e si coricò supina sul giaciglio che aveva realizzato.
“Qui staremo tranquilli. Dai, sdraiati”.
Mi distesi al suo fianco e restammo in silenzio a fissare il cielo.
“Hai mai pensato a come sarai tra dieci anni?” le domandai all’improvviso.
“Tra dieci anni?” ripeté divertita.
“Sì, come ti immagini”.
“Vediamo... tra dieci anni... mi immagino un’attrice famosa, come Sofia Loren o, quella tedesca, come si chiama...”
“Marlene Dietrich?”
“Esatto, Marlene Dietrich. E mi vedo con addosso vestiti di seta e gioielli preziosi. Mi piacerebbe girare il mondo, percorrere le strade di Roma... o di Parigi!”.
“Roma è meravigliosa. È un museo all’aria aperta. Nelle piazze e nelle strade si respira la grandezza dell’antico impero, si è avvolti da un’atmosfera epica, unica. Ogni pietra che calpesti ha una leggenda da raccontare, dietro ogni angolo si nasconde un pezzetto di Storia”.
“Ti invidio, sai, che ci sei stato. Per me è un sogno e resterà tale”.
“Il solo limite ai nostri sogni è la nostra immaginazione”.
Non era una frase mia, non mi ricordavo dove l’avessi sentita, ma mi sembrò appropriata alle circostanze. Ci voltammo contemporaneamente, le guance adagiate sull’erba, i visi l’uno vicino all’altro. Sorrise. Nei suoi occhi luminosi mi parve di scorgere la sagoma inconfondibile del Colosseo.
Senza quasi rendermene conto, iniziai a parlarle del mio passato. Rispetto al suo, vissuto tra le tranquille mura domestiche e le terre intorno al paese in cui era nata, il mio era eccezionalmente burrascoso e, quando terminai di raccontare, commentò strabiliata:
“È la storia più incredibile che abbia mai sentito”.
Era vero, era difficile da credere, eppure era andata proprio così. La signora Milton, quando cinque anni prima ero tornato da lei in cerca di aiuto, aveva usato lo stesso aggettivo: incredibile. E come allora, quando ebbi finito la narrazione, sentii i ricordi, i più pesanti, alleggerirsi. Ricordi che, malgrado gli anni recenti, non avevano smesso del tutto di tormentarmi. Ebbi la conferma che dar fiato agli episodi più dolorosi della mia vita aveva una funzione terapeutica, equivaleva ad aprire una valvola di sicurezza e diminuire la pressione interna. Conservavo comunque una gelosia perversa per tutto ciò che mi era accaduto e, a dispetto degli effetti benefici, riuscivo a rivelare il mio passato solamente a persone che sentivo particolarmente vicino. Sara, nonostante ci conoscessimo da poco, era una di quelle.
“Quando la realtà trascende l’immaginazione, accade ciò che non avevamo né sognato né immaginato” filosofai.
Sara aggrottò la fronte, intimorita.
“Non dire così, mi fai paura”.
Risi.
“Ma si può sempre ricominciare da zero, non è mai troppo tardi” la rassicurai e con il pensiero ripercorsi a ritroso gli ultimi anni fino all’incontro con Marco.
Sfumature rossastre tinsero il cielo.
“Si è fatto tardi, devo tornare a casa. Ho promesso a mia madre di aiutarla a preparare la cena”.
Mi alzai e le porsi la mano.
“Marlene....”.
“Dai, non mi prendere in giro” si lamentò afferrandomi il braccio e sollevandosi in piedi. Ci fissammo un secondo, seri, poi le nostre risate riecheggiarono nella valle.
Ci vedevamo il mercoledì, al mercato, ma erano incontri fugaci. Il sabato, invece, avevamo tutto il pomeriggio per noi. Più stavamo insieme, più mi sentivo attratto, più la desideravo fisicamente. Passarono alcune settimane fino a quando, una sera, prima di separarci, la attirai verso di me e posai la mia bocca sulla sua. Sara non si ritrasse e restò come in attesa. Spinsi allora la lingua tra le sue labbra morbide e trasformai quel contatto casto in bacio lungo e appassionato.
 Argomenti simili
Argomenti simili» Il baco e la farfalla (capitolo 9)
» Il baco e la farfalla (capitolo 34)
» Il baco e la farfalla (capitolo 28)
» Il baco e la farfalla (capitolo 36)
» Il baco e la farfalla (capitolo 21)
» Il baco e la farfalla (capitolo 34)
» Il baco e la farfalla (capitolo 28)
» Il baco e la farfalla (capitolo 36)
» Il baco e la farfalla (capitolo 21)
:: Vetrina Autori :: Opere :: Diego Repetto
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.|
|
|






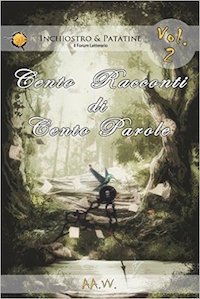
» concorso internazionale poesia e narrativa UN MONTE DI POESIA
» Premio di Poesia, Narrativa, Teatro e Pittura "Luce dell'Arte" 6^ Edizione
» concorso letterario internazionale UN MONTE DI POESIA XVI edizione
» IV^ Edizione del Premio di Narrativa, Teatro e Poesia "Il buon riso fa buon sangue". Scadenza bando 20/07/2022
» UN PONTE TRA NOI - RECENSIONE DI ARMANDO MASCHINI
» UN PONTE TRA NOI - RECENSIONE DI GIULIANA PARAGLIOLA