Il pugnalatore
:: Vetrina Autori :: Opere :: Granchio
Pagina 1 di 1
 Il pugnalatore
Il pugnalatore
Era tardi. Tardi per i rimpianti, per il dolore, per il piacere.
Tardi per avere e per dare, per scegliere, per rinnegare.
Tardi per offrire carità o pretenderne, per tollerare o perdonare.
Tardi per tutto.
Il maggiore aprì la finestra, respirò l’aria che sapeva di salsedine e umidità, poi volse lo sguardo all’orizzonte e volò lontano, in luoghi che solo il pensiero riesce a raggiungere. Immaginò di essere in cima a una montagna, solo, carezzato da una brezza vaporosa e insinuante, come l’alito del desiderio, dolce e voluttuosa come i baci della passione… Socchiuse gli occhi e assaporò quell’attimo, tutti i sensi stimolati dal piacere di una condizione immaginaria e perfetta.
Un attimo…
Il sudore gli imperlava il viso e la testa rasata. Con un gesto meccanico accostò il dorso della mano alla guancia e lo strofinò alcune volte, delicatamente, quasi una carezza. Il sudore diluì la striscia di rosso scarlatto che gli disegnò il viso dalla tempia al mento, simile a una pennellata di colore o a un segno di guerra.
«Quanto è lungo un attimo?… – mormorò, rivolgendosi alla notte – … un baleno o un’eternità?...». Aveva necessità di una risposta. Il senso di quello che era appena successo esigeva una chiara e lucida spiegazione, un riscontro che fosse un barlume di luce nella coltre di tenebre che lo aveva sommerso. Che aveva sommerso tutti…
Inquadrare i fatti con rigore, nella loro struttura logica… trovare un senso negli eventi, il bandolo, la via d’uscita, una qualsiasi giustificazione che non li relegasse a un destino così brutale e vanamente tragico. Ogni azione innaturale e violenta compiuta dall’uomo è indecifrabile, così come era stata la sua… tanto ignobile e abietta da essere inconcepibile. Un militare applica la disciplina nei modi e nei ragionamenti, per questo aveva lasciato l’etica fuori dal suo modo di valutare i fatti. Non era affar suo l’onere di suddividere i comportamenti umani in buoni e cattivi. Lui dentro di sé sapeva cosa era giusto e cosa era sbagliato.
E sapeva quanto dura un attimo.
Tutto questo prima di quel giorno.
Ora non aveva risposte e le chiedeva alla notte.
Non era più su una vetta ma sdraiato nel fondo di un abisso melmoso, fasciato da un silenzio assoluto e cupo, avvolto dall’oscurità, due mani enormi che lo ghermivano nell’ultimo abbraccio, lo trattenevano e lo trascinavano in una profondità senza fine… Annaspò, quasi senza più fiato, poi prese a ingoiare aria, con avidità, sporgendosi all’esterno, con il viso contratto e le vene del collo livide, enormi e pulsanti. Poggiò la mano aperta sul montante della finestra da cui distingueva il mare ed emise un urlo rauco e sordo, come il ringhio di un cane idrofobo, schizzando il vetro di minuscoli spruzzi di saliva e sangue. Sentì l’odore acre e intenso che trasudava dai pori del proprio corpo e il dolore bruciante nel fianco, il dolore… quello che lo aveva riportato dalle tenebre alla luce fioca della stanza, nel finire della notte autunnale.
Passò la lingua sugli incisivi superiori detergendoli da un grumo di sangue rappreso. Gli spasmi arrivavano a intermittenza, sempre più vicini, uno dopo l’altro, lenti ma inesorabili come le onde della risacca.
«Una lunga giornata – pensò – e una notte perfetta per concluderla…».
Si allontanò dalla finestra e si sedette sulla poltrona di pelle consunta, proprio davanti alla rastrelliera delle armi. Osservò la macchia umida e scura sul panciotto di alpaca, all’altezza del fegato, che lentamente si allargava, disegnando un’improbabile composizione floreale.
«Quanto dura un attimo?… – ripeté il maggiore – l’orgasmo degli amanti all’apice della passione è una frazione, ma la fine della vita?… il momento in cui il corpo esala l’ultimo respiro? – continuò, con voce appena più bassa, come se stesse rendendo confessione – … non è forse quello il momento in cui si ripercorre il corso dell’esistenza? Un tempo declinabile o sfugge a qualsiasi catalogazione e classificazione? Ah, interrogativi, dubbi, nessuna ragione ci sostiene in questa impresa folle dove non c’è spazio se non per l’orgoglio. La sofferenza è un utile parametro? Il dolore un’unità di misura? – Un rigurgito di sangue gli colò all’angolo della bocca ma non lo deterse – La notte, questa notte, mi porterà le risposte che cerco».
Il maggiore scosse la testa come per scacciare un grosso e fastidioso insetto. Il rimorso, qualche volta, è un parassita duro da rimuovere. Toccò dove la carne era lacerata, frugando con un dito nella fessura per valutarne la gravità. Il taglio era largo e slabbrato, rosso come la bocca vermiglia di una vecchia puttana e ingoiò la prima falange. La fitta di dolore fu atroce, ritrasse la mano e digrignò i denti, sentì il calore del sangue che scorreva abbondante sull’anca sino a bagnare lo stivale. Non si preoccupò di disinfettare la ferita, tanto, comunque fossero andate le cose, non sarebbe sopravvissuto. E comunque non gliene importava un accidente. Sorrise con una certa soddisfazione, denti e gengive coperti di sangue, perché il ragazzo era stato bravo e lui ne andava fiero. Era stato all’altezza. Suo figlio.
Un buon allievo, un avversario difficile da battere: agile, allenato, di riflessi rapidi. Ma lui era il maestro e maneggiava il coltello con sapienza e consapevolezza; non una semplice arma ma il prolungamento di un arto, una parte del corpo sensibile e percepibile. Tante volte si era scontrato con avversari curiosi di saggiare la sua forza e il suo talento e tutti, tutti, ne avevano subito la superiorità. Aveva incrociato il coltello con i migliori pugnalatori in circolazione, atleti, sicari, criminali o solo cultori. Al primo e all’ultimo sangue.
La lama che affonda nella carne, che squarcia tessuti, muscoli e vene, lo sguardo che diventa opaco, la bocca che si dischiude nell’ultimo gemito, la fine della vita. Oh, quante volte era successo… mentre ancora impugnava l’elsa del pugnale e gli ultimi sussulti si propagavano al suo braccio sino alla spalla, sin dentro l’anima. Quel tempo, l’ultimo battito del cuore, dura un palpito o un’eternità?…
Il ragazzo era stato bravo, l’aveva colpito al costato, prima di taglio poi, con rapidità, aveva infilato la punta dell’arma all’altezza del fegato.
Ma il ragionamento… questo vale più della forza e di ogni altra abilità. Se lo avesse fatto, tutto sarebbe finito lì, tra le rocce di “Su Bentu”, le pietre avrebbero bevuto il suo sangue e il destino gli avrebbe risparmiato ulteriori sofferenze, fisiche e mentali. Invece il ragazzo era stato impetuoso. Ah, la gioventù, che stagione straordinaria… e quanto mal si accompagna alla riflessione, divora la lucidità ed esalta l’impulso, la foga, l’irruenza… La gioventù – un difetto per alcuni versi – induce al fanatismo, alle suggestioni, agli scontri epici, alla temerarietà sino all’incoscienza. Uno spirito che premia nei giochi d’amore ma è fatale nei giochi di morte. In un corpo a corpo dove la posta è la più alta e l’obiettivo è l’annientamento, l’unica ragione che vale è la sopravvivenza. Il corpo comanda sugli arti, li disciplina, ribatte colpo su colpo, ma è la mente che stabilisce le strategie e, come in una partita a scacchi dove mosse e contromosse sono già collaudate, decide quale sarà quella giusta. Se ragioni bene sopravvivi, se ragioni male soccombi. Questa è la logica, nessun’altra. Lui aveva ragionato bene, il ragazzo no. Semplice.
Il dolore al costato, infertogli dal figlio, improvviso e tremendo, aveva richiesto una scelta tattica e l’applicazione di uno schema offensivo, così la mente aveva deciso, attraverso una analisi delle possibili soluzioni, compiuta nella frazione di un attimo, un maledetto attimo, quale fosse la mossa giusta, il movimento da manuale. Aveva scartato di lato e descrivendo una veronica, mentre ruotava su se stesso, aveva colpito con precisione, non con violenza ma con maestria. La lama del kindijal georgiano era penetrata a fondo e l’avversario si era accasciato con un gemito di sorpresa. Suo figlio. Morto prima ancora di toccare il suolo, con il cuore forato da un metallo nobile per un’azione ripugnante. L’omicidio, talvolta, poteva trovare giustificazione se non condivisione, in alcune circostanze era una necessità, altre volte il male minore, spesso una soluzione. La donna, per esempio. La sua morte era stata la necessaria soluzione, l’unica possibile, decisa all’unanimità. E anche in quella circostanza era stato lui a togliere la vita. Era stato un privilegio amarla, e ucciderla.
Nella stessa misura era stato un privilegio amare suo figlio, così come lo è per ogni padre, ed era stato un privilegio ucciderlo, così come lo è per ogni avversario di valore.
Il ragazzo era rimasto tra le rocce di “Su Bentu”, l’aveva coperto con rami e pietre, la ferita non gli aveva consentito di trasportarlo altrove. Lei, invece, l’aveva portata a “Punta Nera” e adagiata nello scoglio più alto, piatto come un altare sacrificale, e lì, su quel giaciglio, abbandonata, offerta agli abissi. Quella morte era stata il pegno di un patto sanguinario e orrendo, stretto tra uomini legati da un vincolo di sangue e dall’amore per la stessa donna, un amore empio e blasfemo, intollerabile.
Il maggiore, preda dei pensieri che vagavano e che, più delle emozioni, si stratificavano e si amplificavano, talmente forti da sembrare materia palpabile, scosse più volte la testa per scacciarli via, per alleviarsi di un peso incontenibile. Gli occhi gli si inumidirono ma solo per il dolore fisico non per quello dello spirito, l’emozione e il sentimento erano stati d’animo che non si poteva permettere un assassino par suo. Ma ora era spossato, nel corpo e nello spirito e tutto ormai gli era indifferente. Il destino aveva deciso la loro sorte e prima della fine della notte un altro figlio e un altro padre sarebbero morti per mano reciproca… Per tutto questo poteva esistere una soglia di tolleranza? Un’indulgenza? Un perdono? No, no di certo. Non in questo mondo.
Il dolore era sempre forte ma più sopportabile, si alzò in piedi e ancora una volta scrutò l’orizzonte e il mare, nero come le tenebre che lo sovrastavano. Tra breve avrebbe incontrato suo padre, l’ultimo incontro sul selciato di Piazza delle Anime, il sagrato della chiesa quale testimone di quell’ultimo estremo misfatto…
La fine della sua storia, della loro storia, era ormai vicina e non vedeva l’ora che quella inutile tragedia volgesse a conclusione. L’arma, però… L’indole del militare e dell’assassino prese il sopravvento e il maggiore si concentrò su alcuni aspetti tecnici. Aveva valutato con disappunto la scelta del figlio: un bowie knife a lama larga, tagliente ma pesante e grossolano, un coltello da cacciatore. Certo adatto a un giovane, pratico, versatile e maneggevole ma in fondo ordinario. Oh, quello in particolare era di eccellente fattura. Da un punto di vista tecnico era un vero gioiello, ben calibrato, preciso nella proporzione tra lama e manico, perfettamente affilato. Indubbiamente pericoloso in mani abili. Il dodicesimo pezzo di una collezione da quindici, realizzato in Texas. Nelle guancette aveva rappresentata la storia, o la leggenda forse, della famosa battaglia di Alamo. Le incisioni raccontavano di come Jim Bowie, nonostante alcune palle in corpo, uccidesse diversi soldati messicani con il suo pugnale, prima di soccombere. Il maggiore lo aveva regalato a suo figlio al compimento del diciottesimo anno e il ragazzo ne aveva fatto l'arma preferita. Era diventato davvero bravo, come dimostrato quella notte.
Dal taschino del panciotto estrasse l’orologio, doveva sbrigarsi, non c’era più molto tempo e il padre lo aspettava. Nella Piazza delle Anime.
Bichaq
Armenia e Turchia
Arma tradizionale a un filo. Anche da duello
Il Bara Jamadu era contrassegnato con il n. 27, nella parte alta della rastrelliera, dentro un fodero d’argento decorato in rilievo. Era un ornamento che rappresentava la posizione de “l’abbraccio inferiore” del Kamasutra e la donna, all’apice del piacere, novella mantide religiosa, era raffigurata nel gesto di colpire l’amante con quel pugnale.
Di fianco un katar dell’India meridionale, fabbricato a Bengalore da un pachistano che con quel coltello aveva massacrato la propria famiglia. Il maggiore non trasse conforto da quell’esempio così simile alla sua esperienza. Lasciò perdere.
Appena sotto era rinfoderato un bichaq armeno. In genere preferiva quelli di fabbricazione turca, li considerava meglio bilanciati, ma questo era stato forgiato con acqua dell’Aras, un pezzo unico. Era quello giusto, un pugnale di trentadue centimetri con un guardamano di ceramica, affilato come un rasoio.
Era certo che il padre avrebbe scelto un’arma un po’ più lunga rispetto alla sua e più leggera, un Chura… un coltello che sapeva maneggiare meglio di un Mahsud. Anche il padre aveva molto viaggiato e molto appreso. O un Dalwel di Burma. Entrambi molto efficaci e temibili. Ma più probabilmente un hachiwara giapponese e “il figlio” nella mano sinistra, un kwaiken con lama di 12-15 cm a due fili. Conosceva bene suo padre, il suo maestro, l’unico che poteva stargli alla pari.
E in quell’ultimo duello l’età avanzata del genitore era compensata dalla sua ferita. Alla fine non era neppure sicuro di resistere sino al momento di incrociare gli sguardi e le lame, aveva il fegato trapassato e il sanguinamento lento e costante gli stava portando via la vita.
Senza indugio estrasse il bichaq dal fodero di corno sulla rastrelliera e lo infilò in quello di cuoio che teneva all’altezza della spalla sinistra, dietro la schiena. Si infilò la giacca e mentre lo faceva dalla tasca cadde una foto, la raccolse, il dolore gli fece emettere un lamento simile all’uggiolare di un cucciolo, poggiò la foto sul palmo della mano, sorrise al sorriso di una donna bruna, dai tratti delicati, bella.
Un filamento di sangue gli colò dalla bocca sulla foto e subito vi passò delicatamente due dita, per detergerla o per un’ultima carezza, poi strinse la mano a pugno, appallottolò quel pezzo di carta e lo buttò via.
«Tutto per una donna – mormorò – come nelle migliori tragedie dell’umanità. Paghi il dovuto con la moneta più preziosa e il risarcimento è la fine della sofferenza, gli spettatori non applaudiranno per questo… ».
Guardò l’orizzonte un’ultima volta, la giornata più lunga della sua vita non era ancora compiuta e il sudore gli irritava la ferita nel costato. Ci poggiò sopra la mano a coppa e compresse, il dolore riprese ad arrivare ad ondate.
«Mi servirà per restare sveglio…» blaterò a voce alta, poi con decisione uscì.
Hachiwara
Giappone
Arma bianca da duello lunga circa 30 cm con lama a sezione quadrata
L’uomo si spogliò, ripiegò con ordine gli indumenti e indossò la divisa. La camicia bianca candida risaltava sulla pelle abbronzata del collo e del viso. Nonostante l’età avanzata era ancora in ottima forma. Magro, muscoloso, solido.
Un segno della vita, un vecchio ricordo, ce l’aveva stampato in faccia: la lunga cicatrice che gli tracciava la pelle in profondità, dal collo all’orecchio sinistro, trasversale al viso. Le labbra e il naso erano distintamente separati dall’affondo di una lama gentile, probabilmente il filo di un rasoio.
Aprì la cassapanca e prese con delicatezza un involucro di lino, richiuse il coperchio e vi posò sopra il fagotto. Il tessuto era leggermente scuro per effetto del tempo e striato di rosso da un cordone, anch’esso vecchio e stinto.
L’uomo tolse il canapo e lo riavvolse in tante spire intorno al polso sinistro, con gesti rapidi e sicuri annodò i capi aiutandosi con i denti, come aveva fatto tante altre volte nella sua vita, poi scostò i lembi del tessuto, lentamente come stesse compiendo un rituale, e liberò il contenuto.
I due pugnali erano fissati tramite due asole cucite alla stoffa e ognuno dentro il proprio fodero. Uno era un golok, un coltello Malese, l’altro un hachiwara giapponese da duello, con il manico in acero, allungato per consentire la presa a due mani e lama lunga 50 centimetri a un solo filo a cui era fissato, con un fermo di bambù, un piccolo kwaiken. L’uomo chiuse gli occhi e toccò i manici di entrambi, lievemente, come stesse accarezzando la donna amata; li toccò più volte, forse cercando ispirazione nelle vibrazioni dell’atmosfera o negli impercettibili brusii dello spazio, sinché afferrò saldamente l’hachiwara e il kwaiken e, con un solo movimento, li estrasse dalla guaina, compì una rotazione di 180 gradi, si flesse sulle gambe e simulò un attacco di prima. Rimase immobile in quella posa, l’arma lunga parallela al corpo con il taglio rivolto all’esterno, quella corta in posizione di guardia con la punta diretta verso il nemico, come un indice puntato minacciosamente. In un ipotetico scontro, quell’azione avrebbe perforato la milza dell’avversario in due punti e la morte sarebbe sopraggiunta rapidamente per dissanguamento.
Dopo alcuni minuti l’uomo si rimise composto, cordoni di sudore gli scorrevano dalle tempie lungo le guance riunendosi nel solco della cicatrice come affluenti di un fiume in piena, scorrendo sino al collo e insinuandosi nel colletto inamidato. Ringuainò il pugnale, lo tolse dall’asola e lo fissò alla fodera della giacca militare, dopodichè prese il kwaiken e lo infilò tra la pelle e la corda arrotolata intorno al polso sinistro. Aveva scelto le armi.
Controllò l’orario e stabilì di dover uscire di casa. Volse lo sguardo intorno, per accertarsi di aver lasciato tutto in ordine, era un uomo meticoloso, quindi dalla tasca interna della giacca prese una foto. La donna era bella. Guardò quell’immagine e gli occhi furono attraversati da bagliori di ricordi vividi e palpitanti, da echi di rimpianto. Ne pronunciò il nome, sommessamente, sapeva che quello stesso nome era stato più volte pronunciato da suo figlio e dal figlio di suo figlio, da tre generazioni di uomini e amanti, quindi ripose la foto nel cassetto della madia, dove risiedevano altre memorie e un altro passato.
Non sapeva chi avrebbe dovuto incontrare, se il figlio o il nipote, uno dei due comunque era già morto. Era stanco, voleva solo concludere tutto al più presto, in modo rapido e pulito. Quella donna non sarebbe mai dovuta entrare nella loro vita, aveva scatenato l’inferno nei loro cuori avvelenandoli con la sua presenza. Li aveva dannati, irrimediabilmente fatalmente dannati e senza appello la condanna era scritta.
La donna era stata la prima, ci aveva pensato il maggiore, poi durante la notte un altro era morto, non sapeva se figlio o nipote, e prima dell’alba sarebbe toccato a un altro ancora…
A lui avevano concesso l’opportunità di un solo scontro, con il sopravissuto, un riguardo per l’età e un atto di rispetto nei confronti di un vecchio guerriero, come insegnava l’antica arte della guerra.
Abbottonò la giacca aderente poi uscì nell’aria frizzante della notte per andare incontro al suo destino.
Sai
arti marziali.
“La disperazione è il più grande dei nostri errori”
Le due figure si muovevano sul selciato della Piazza delle Anime come due ballerini sul palco di un teatro tragico, le lame descrivevano incredibili e improbabili geometrie, scintillando al barlume delle prime timide luci dell’alba. La fine di una notte come tante, la metafora dell’esistenza, una parabola che insieme alle tenebre portava con sé tante vite disperate.
Un uomo cadde riverso, di schianto, sui ciottoli del sagrato, l’altro andò via senza voltarsi, con passo incerto, barcollante, come un ubriaco. L’uomo a terra, supino, rantolava con gli occhi sbarrati. Con le ultime forze si mise in posizione fetale, dischiuse le labbra in un ultimo beffardo sorriso e morì. Le antiche pietre si bagnarono di rosso, il sangue, abbondante, si allargò in cerchi sempre più ampi sino a lambire la scala di granito, poi iniziò a tracimare dai gradini, condensandosi in piccole pozze di colore.
Infine era l’alba.
Tardi per avere e per dare, per scegliere, per rinnegare.
Tardi per offrire carità o pretenderne, per tollerare o perdonare.
Tardi per tutto.
Il maggiore aprì la finestra, respirò l’aria che sapeva di salsedine e umidità, poi volse lo sguardo all’orizzonte e volò lontano, in luoghi che solo il pensiero riesce a raggiungere. Immaginò di essere in cima a una montagna, solo, carezzato da una brezza vaporosa e insinuante, come l’alito del desiderio, dolce e voluttuosa come i baci della passione… Socchiuse gli occhi e assaporò quell’attimo, tutti i sensi stimolati dal piacere di una condizione immaginaria e perfetta.
Un attimo…
Il sudore gli imperlava il viso e la testa rasata. Con un gesto meccanico accostò il dorso della mano alla guancia e lo strofinò alcune volte, delicatamente, quasi una carezza. Il sudore diluì la striscia di rosso scarlatto che gli disegnò il viso dalla tempia al mento, simile a una pennellata di colore o a un segno di guerra.
«Quanto è lungo un attimo?… – mormorò, rivolgendosi alla notte – … un baleno o un’eternità?...». Aveva necessità di una risposta. Il senso di quello che era appena successo esigeva una chiara e lucida spiegazione, un riscontro che fosse un barlume di luce nella coltre di tenebre che lo aveva sommerso. Che aveva sommerso tutti…
Inquadrare i fatti con rigore, nella loro struttura logica… trovare un senso negli eventi, il bandolo, la via d’uscita, una qualsiasi giustificazione che non li relegasse a un destino così brutale e vanamente tragico. Ogni azione innaturale e violenta compiuta dall’uomo è indecifrabile, così come era stata la sua… tanto ignobile e abietta da essere inconcepibile. Un militare applica la disciplina nei modi e nei ragionamenti, per questo aveva lasciato l’etica fuori dal suo modo di valutare i fatti. Non era affar suo l’onere di suddividere i comportamenti umani in buoni e cattivi. Lui dentro di sé sapeva cosa era giusto e cosa era sbagliato.
E sapeva quanto dura un attimo.
Tutto questo prima di quel giorno.
Ora non aveva risposte e le chiedeva alla notte.
Non era più su una vetta ma sdraiato nel fondo di un abisso melmoso, fasciato da un silenzio assoluto e cupo, avvolto dall’oscurità, due mani enormi che lo ghermivano nell’ultimo abbraccio, lo trattenevano e lo trascinavano in una profondità senza fine… Annaspò, quasi senza più fiato, poi prese a ingoiare aria, con avidità, sporgendosi all’esterno, con il viso contratto e le vene del collo livide, enormi e pulsanti. Poggiò la mano aperta sul montante della finestra da cui distingueva il mare ed emise un urlo rauco e sordo, come il ringhio di un cane idrofobo, schizzando il vetro di minuscoli spruzzi di saliva e sangue. Sentì l’odore acre e intenso che trasudava dai pori del proprio corpo e il dolore bruciante nel fianco, il dolore… quello che lo aveva riportato dalle tenebre alla luce fioca della stanza, nel finire della notte autunnale.
Passò la lingua sugli incisivi superiori detergendoli da un grumo di sangue rappreso. Gli spasmi arrivavano a intermittenza, sempre più vicini, uno dopo l’altro, lenti ma inesorabili come le onde della risacca.
«Una lunga giornata – pensò – e una notte perfetta per concluderla…».
Si allontanò dalla finestra e si sedette sulla poltrona di pelle consunta, proprio davanti alla rastrelliera delle armi. Osservò la macchia umida e scura sul panciotto di alpaca, all’altezza del fegato, che lentamente si allargava, disegnando un’improbabile composizione floreale.
«Quanto dura un attimo?… – ripeté il maggiore – l’orgasmo degli amanti all’apice della passione è una frazione, ma la fine della vita?… il momento in cui il corpo esala l’ultimo respiro? – continuò, con voce appena più bassa, come se stesse rendendo confessione – … non è forse quello il momento in cui si ripercorre il corso dell’esistenza? Un tempo declinabile o sfugge a qualsiasi catalogazione e classificazione? Ah, interrogativi, dubbi, nessuna ragione ci sostiene in questa impresa folle dove non c’è spazio se non per l’orgoglio. La sofferenza è un utile parametro? Il dolore un’unità di misura? – Un rigurgito di sangue gli colò all’angolo della bocca ma non lo deterse – La notte, questa notte, mi porterà le risposte che cerco».
Il maggiore scosse la testa come per scacciare un grosso e fastidioso insetto. Il rimorso, qualche volta, è un parassita duro da rimuovere. Toccò dove la carne era lacerata, frugando con un dito nella fessura per valutarne la gravità. Il taglio era largo e slabbrato, rosso come la bocca vermiglia di una vecchia puttana e ingoiò la prima falange. La fitta di dolore fu atroce, ritrasse la mano e digrignò i denti, sentì il calore del sangue che scorreva abbondante sull’anca sino a bagnare lo stivale. Non si preoccupò di disinfettare la ferita, tanto, comunque fossero andate le cose, non sarebbe sopravvissuto. E comunque non gliene importava un accidente. Sorrise con una certa soddisfazione, denti e gengive coperti di sangue, perché il ragazzo era stato bravo e lui ne andava fiero. Era stato all’altezza. Suo figlio.
Un buon allievo, un avversario difficile da battere: agile, allenato, di riflessi rapidi. Ma lui era il maestro e maneggiava il coltello con sapienza e consapevolezza; non una semplice arma ma il prolungamento di un arto, una parte del corpo sensibile e percepibile. Tante volte si era scontrato con avversari curiosi di saggiare la sua forza e il suo talento e tutti, tutti, ne avevano subito la superiorità. Aveva incrociato il coltello con i migliori pugnalatori in circolazione, atleti, sicari, criminali o solo cultori. Al primo e all’ultimo sangue.
La lama che affonda nella carne, che squarcia tessuti, muscoli e vene, lo sguardo che diventa opaco, la bocca che si dischiude nell’ultimo gemito, la fine della vita. Oh, quante volte era successo… mentre ancora impugnava l’elsa del pugnale e gli ultimi sussulti si propagavano al suo braccio sino alla spalla, sin dentro l’anima. Quel tempo, l’ultimo battito del cuore, dura un palpito o un’eternità?…
Il ragazzo era stato bravo, l’aveva colpito al costato, prima di taglio poi, con rapidità, aveva infilato la punta dell’arma all’altezza del fegato.
Ma il ragionamento… questo vale più della forza e di ogni altra abilità. Se lo avesse fatto, tutto sarebbe finito lì, tra le rocce di “Su Bentu”, le pietre avrebbero bevuto il suo sangue e il destino gli avrebbe risparmiato ulteriori sofferenze, fisiche e mentali. Invece il ragazzo era stato impetuoso. Ah, la gioventù, che stagione straordinaria… e quanto mal si accompagna alla riflessione, divora la lucidità ed esalta l’impulso, la foga, l’irruenza… La gioventù – un difetto per alcuni versi – induce al fanatismo, alle suggestioni, agli scontri epici, alla temerarietà sino all’incoscienza. Uno spirito che premia nei giochi d’amore ma è fatale nei giochi di morte. In un corpo a corpo dove la posta è la più alta e l’obiettivo è l’annientamento, l’unica ragione che vale è la sopravvivenza. Il corpo comanda sugli arti, li disciplina, ribatte colpo su colpo, ma è la mente che stabilisce le strategie e, come in una partita a scacchi dove mosse e contromosse sono già collaudate, decide quale sarà quella giusta. Se ragioni bene sopravvivi, se ragioni male soccombi. Questa è la logica, nessun’altra. Lui aveva ragionato bene, il ragazzo no. Semplice.
Il dolore al costato, infertogli dal figlio, improvviso e tremendo, aveva richiesto una scelta tattica e l’applicazione di uno schema offensivo, così la mente aveva deciso, attraverso una analisi delle possibili soluzioni, compiuta nella frazione di un attimo, un maledetto attimo, quale fosse la mossa giusta, il movimento da manuale. Aveva scartato di lato e descrivendo una veronica, mentre ruotava su se stesso, aveva colpito con precisione, non con violenza ma con maestria. La lama del kindijal georgiano era penetrata a fondo e l’avversario si era accasciato con un gemito di sorpresa. Suo figlio. Morto prima ancora di toccare il suolo, con il cuore forato da un metallo nobile per un’azione ripugnante. L’omicidio, talvolta, poteva trovare giustificazione se non condivisione, in alcune circostanze era una necessità, altre volte il male minore, spesso una soluzione. La donna, per esempio. La sua morte era stata la necessaria soluzione, l’unica possibile, decisa all’unanimità. E anche in quella circostanza era stato lui a togliere la vita. Era stato un privilegio amarla, e ucciderla.
Nella stessa misura era stato un privilegio amare suo figlio, così come lo è per ogni padre, ed era stato un privilegio ucciderlo, così come lo è per ogni avversario di valore.
Il ragazzo era rimasto tra le rocce di “Su Bentu”, l’aveva coperto con rami e pietre, la ferita non gli aveva consentito di trasportarlo altrove. Lei, invece, l’aveva portata a “Punta Nera” e adagiata nello scoglio più alto, piatto come un altare sacrificale, e lì, su quel giaciglio, abbandonata, offerta agli abissi. Quella morte era stata il pegno di un patto sanguinario e orrendo, stretto tra uomini legati da un vincolo di sangue e dall’amore per la stessa donna, un amore empio e blasfemo, intollerabile.
Il maggiore, preda dei pensieri che vagavano e che, più delle emozioni, si stratificavano e si amplificavano, talmente forti da sembrare materia palpabile, scosse più volte la testa per scacciarli via, per alleviarsi di un peso incontenibile. Gli occhi gli si inumidirono ma solo per il dolore fisico non per quello dello spirito, l’emozione e il sentimento erano stati d’animo che non si poteva permettere un assassino par suo. Ma ora era spossato, nel corpo e nello spirito e tutto ormai gli era indifferente. Il destino aveva deciso la loro sorte e prima della fine della notte un altro figlio e un altro padre sarebbero morti per mano reciproca… Per tutto questo poteva esistere una soglia di tolleranza? Un’indulgenza? Un perdono? No, no di certo. Non in questo mondo.
Il dolore era sempre forte ma più sopportabile, si alzò in piedi e ancora una volta scrutò l’orizzonte e il mare, nero come le tenebre che lo sovrastavano. Tra breve avrebbe incontrato suo padre, l’ultimo incontro sul selciato di Piazza delle Anime, il sagrato della chiesa quale testimone di quell’ultimo estremo misfatto…
La fine della sua storia, della loro storia, era ormai vicina e non vedeva l’ora che quella inutile tragedia volgesse a conclusione. L’arma, però… L’indole del militare e dell’assassino prese il sopravvento e il maggiore si concentrò su alcuni aspetti tecnici. Aveva valutato con disappunto la scelta del figlio: un bowie knife a lama larga, tagliente ma pesante e grossolano, un coltello da cacciatore. Certo adatto a un giovane, pratico, versatile e maneggevole ma in fondo ordinario. Oh, quello in particolare era di eccellente fattura. Da un punto di vista tecnico era un vero gioiello, ben calibrato, preciso nella proporzione tra lama e manico, perfettamente affilato. Indubbiamente pericoloso in mani abili. Il dodicesimo pezzo di una collezione da quindici, realizzato in Texas. Nelle guancette aveva rappresentata la storia, o la leggenda forse, della famosa battaglia di Alamo. Le incisioni raccontavano di come Jim Bowie, nonostante alcune palle in corpo, uccidesse diversi soldati messicani con il suo pugnale, prima di soccombere. Il maggiore lo aveva regalato a suo figlio al compimento del diciottesimo anno e il ragazzo ne aveva fatto l'arma preferita. Era diventato davvero bravo, come dimostrato quella notte.
Dal taschino del panciotto estrasse l’orologio, doveva sbrigarsi, non c’era più molto tempo e il padre lo aspettava. Nella Piazza delle Anime.
Bichaq
Armenia e Turchia
Arma tradizionale a un filo. Anche da duello
Il Bara Jamadu era contrassegnato con il n. 27, nella parte alta della rastrelliera, dentro un fodero d’argento decorato in rilievo. Era un ornamento che rappresentava la posizione de “l’abbraccio inferiore” del Kamasutra e la donna, all’apice del piacere, novella mantide religiosa, era raffigurata nel gesto di colpire l’amante con quel pugnale.
Di fianco un katar dell’India meridionale, fabbricato a Bengalore da un pachistano che con quel coltello aveva massacrato la propria famiglia. Il maggiore non trasse conforto da quell’esempio così simile alla sua esperienza. Lasciò perdere.
Appena sotto era rinfoderato un bichaq armeno. In genere preferiva quelli di fabbricazione turca, li considerava meglio bilanciati, ma questo era stato forgiato con acqua dell’Aras, un pezzo unico. Era quello giusto, un pugnale di trentadue centimetri con un guardamano di ceramica, affilato come un rasoio.
Era certo che il padre avrebbe scelto un’arma un po’ più lunga rispetto alla sua e più leggera, un Chura… un coltello che sapeva maneggiare meglio di un Mahsud. Anche il padre aveva molto viaggiato e molto appreso. O un Dalwel di Burma. Entrambi molto efficaci e temibili. Ma più probabilmente un hachiwara giapponese e “il figlio” nella mano sinistra, un kwaiken con lama di 12-15 cm a due fili. Conosceva bene suo padre, il suo maestro, l’unico che poteva stargli alla pari.
E in quell’ultimo duello l’età avanzata del genitore era compensata dalla sua ferita. Alla fine non era neppure sicuro di resistere sino al momento di incrociare gli sguardi e le lame, aveva il fegato trapassato e il sanguinamento lento e costante gli stava portando via la vita.
Senza indugio estrasse il bichaq dal fodero di corno sulla rastrelliera e lo infilò in quello di cuoio che teneva all’altezza della spalla sinistra, dietro la schiena. Si infilò la giacca e mentre lo faceva dalla tasca cadde una foto, la raccolse, il dolore gli fece emettere un lamento simile all’uggiolare di un cucciolo, poggiò la foto sul palmo della mano, sorrise al sorriso di una donna bruna, dai tratti delicati, bella.
Un filamento di sangue gli colò dalla bocca sulla foto e subito vi passò delicatamente due dita, per detergerla o per un’ultima carezza, poi strinse la mano a pugno, appallottolò quel pezzo di carta e lo buttò via.
«Tutto per una donna – mormorò – come nelle migliori tragedie dell’umanità. Paghi il dovuto con la moneta più preziosa e il risarcimento è la fine della sofferenza, gli spettatori non applaudiranno per questo… ».
Guardò l’orizzonte un’ultima volta, la giornata più lunga della sua vita non era ancora compiuta e il sudore gli irritava la ferita nel costato. Ci poggiò sopra la mano a coppa e compresse, il dolore riprese ad arrivare ad ondate.
«Mi servirà per restare sveglio…» blaterò a voce alta, poi con decisione uscì.
Hachiwara
Giappone
Arma bianca da duello lunga circa 30 cm con lama a sezione quadrata
L’uomo si spogliò, ripiegò con ordine gli indumenti e indossò la divisa. La camicia bianca candida risaltava sulla pelle abbronzata del collo e del viso. Nonostante l’età avanzata era ancora in ottima forma. Magro, muscoloso, solido.
Un segno della vita, un vecchio ricordo, ce l’aveva stampato in faccia: la lunga cicatrice che gli tracciava la pelle in profondità, dal collo all’orecchio sinistro, trasversale al viso. Le labbra e il naso erano distintamente separati dall’affondo di una lama gentile, probabilmente il filo di un rasoio.
Aprì la cassapanca e prese con delicatezza un involucro di lino, richiuse il coperchio e vi posò sopra il fagotto. Il tessuto era leggermente scuro per effetto del tempo e striato di rosso da un cordone, anch’esso vecchio e stinto.
L’uomo tolse il canapo e lo riavvolse in tante spire intorno al polso sinistro, con gesti rapidi e sicuri annodò i capi aiutandosi con i denti, come aveva fatto tante altre volte nella sua vita, poi scostò i lembi del tessuto, lentamente come stesse compiendo un rituale, e liberò il contenuto.
I due pugnali erano fissati tramite due asole cucite alla stoffa e ognuno dentro il proprio fodero. Uno era un golok, un coltello Malese, l’altro un hachiwara giapponese da duello, con il manico in acero, allungato per consentire la presa a due mani e lama lunga 50 centimetri a un solo filo a cui era fissato, con un fermo di bambù, un piccolo kwaiken. L’uomo chiuse gli occhi e toccò i manici di entrambi, lievemente, come stesse accarezzando la donna amata; li toccò più volte, forse cercando ispirazione nelle vibrazioni dell’atmosfera o negli impercettibili brusii dello spazio, sinché afferrò saldamente l’hachiwara e il kwaiken e, con un solo movimento, li estrasse dalla guaina, compì una rotazione di 180 gradi, si flesse sulle gambe e simulò un attacco di prima. Rimase immobile in quella posa, l’arma lunga parallela al corpo con il taglio rivolto all’esterno, quella corta in posizione di guardia con la punta diretta verso il nemico, come un indice puntato minacciosamente. In un ipotetico scontro, quell’azione avrebbe perforato la milza dell’avversario in due punti e la morte sarebbe sopraggiunta rapidamente per dissanguamento.
Dopo alcuni minuti l’uomo si rimise composto, cordoni di sudore gli scorrevano dalle tempie lungo le guance riunendosi nel solco della cicatrice come affluenti di un fiume in piena, scorrendo sino al collo e insinuandosi nel colletto inamidato. Ringuainò il pugnale, lo tolse dall’asola e lo fissò alla fodera della giacca militare, dopodichè prese il kwaiken e lo infilò tra la pelle e la corda arrotolata intorno al polso sinistro. Aveva scelto le armi.
Controllò l’orario e stabilì di dover uscire di casa. Volse lo sguardo intorno, per accertarsi di aver lasciato tutto in ordine, era un uomo meticoloso, quindi dalla tasca interna della giacca prese una foto. La donna era bella. Guardò quell’immagine e gli occhi furono attraversati da bagliori di ricordi vividi e palpitanti, da echi di rimpianto. Ne pronunciò il nome, sommessamente, sapeva che quello stesso nome era stato più volte pronunciato da suo figlio e dal figlio di suo figlio, da tre generazioni di uomini e amanti, quindi ripose la foto nel cassetto della madia, dove risiedevano altre memorie e un altro passato.
Non sapeva chi avrebbe dovuto incontrare, se il figlio o il nipote, uno dei due comunque era già morto. Era stanco, voleva solo concludere tutto al più presto, in modo rapido e pulito. Quella donna non sarebbe mai dovuta entrare nella loro vita, aveva scatenato l’inferno nei loro cuori avvelenandoli con la sua presenza. Li aveva dannati, irrimediabilmente fatalmente dannati e senza appello la condanna era scritta.
La donna era stata la prima, ci aveva pensato il maggiore, poi durante la notte un altro era morto, non sapeva se figlio o nipote, e prima dell’alba sarebbe toccato a un altro ancora…
A lui avevano concesso l’opportunità di un solo scontro, con il sopravissuto, un riguardo per l’età e un atto di rispetto nei confronti di un vecchio guerriero, come insegnava l’antica arte della guerra.
Abbottonò la giacca aderente poi uscì nell’aria frizzante della notte per andare incontro al suo destino.
Sai
arti marziali.
“La disperazione è il più grande dei nostri errori”
Le due figure si muovevano sul selciato della Piazza delle Anime come due ballerini sul palco di un teatro tragico, le lame descrivevano incredibili e improbabili geometrie, scintillando al barlume delle prime timide luci dell’alba. La fine di una notte come tante, la metafora dell’esistenza, una parabola che insieme alle tenebre portava con sé tante vite disperate.
Un uomo cadde riverso, di schianto, sui ciottoli del sagrato, l’altro andò via senza voltarsi, con passo incerto, barcollante, come un ubriaco. L’uomo a terra, supino, rantolava con gli occhi sbarrati. Con le ultime forze si mise in posizione fetale, dischiuse le labbra in un ultimo beffardo sorriso e morì. Le antiche pietre si bagnarono di rosso, il sangue, abbondante, si allargò in cerchi sempre più ampi sino a lambire la scala di granito, poi iniziò a tracimare dai gradini, condensandosi in piccole pozze di colore.
Infine era l’alba.

granchio- Admin

- Messaggi : 3004
Località : sardegna
:: Vetrina Autori :: Opere :: Granchio
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.|
|
|





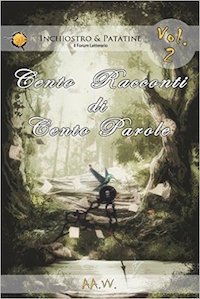
» concorso internazionale poesia e narrativa UN MONTE DI POESIA
» Premio di Poesia, Narrativa, Teatro e Pittura "Luce dell'Arte" 6^ Edizione
» concorso letterario internazionale UN MONTE DI POESIA XVI edizione
» IV^ Edizione del Premio di Narrativa, Teatro e Poesia "Il buon riso fa buon sangue". Scadenza bando 20/07/2022
» UN PONTE TRA NOI - RECENSIONE DI ARMANDO MASCHINI
» UN PONTE TRA NOI - RECENSIONE DI GIULIANA PARAGLIOLA