Il baco e la farfalla (capitolo 7)
:: Vetrina Autori :: Opere :: Diego Repetto
Pagina 1 di 1
 Il baco e la farfalla (capitolo 7)
Il baco e la farfalla (capitolo 7)
Settembre 1952
Le speranze di una tranquilla e serena vita famigliare vennero frustrate fin dall’inizio. Il rapporto con mia madre era logorato da continue tensioni e perfino gli episodi più insignificanti erano fonte di discussioni accese e dolorose. Costanza si dimostrò presto incapace di compiere nei miei confronti quei gesti d’affetto che una madre abitualmente rivolge ai propri figli. Una sera, prima di addormentarmi, avrei avuto piacere di un suo bacio. Lo desideravo, ne sentivo il bisogno. Decisi di vincere il mio orgoglio e chiederglielo apertamente. La chiamai. La sua risposta fu così brusca che mi strozzò in gola le parole. Mi morsi il labbro, ingoiai l’amarezza e non dissi nulla.
Usciva presto ogni mattina per andare a vendere il pesce al mercato di Nervi e rientrava nel tardo pomeriggio. Un lavoro faticoso, soprattutto d’inverno. Durante il nostro primo incontro ero rimasto impressionato dalla ruvidezza delle sue mani, segnate indelebilmente dalle ore trascorse a pulire il pesce con l’acqua gelida. Rimasi presto colpito dalla sua generosità. Quando preparava la minestra, era solita farne due pentole. Una per noi, una che mi dava da portare ai vicini del piano di sopra che, quasi contemporaneamente, si erano ritrovati con un figlio in più e un lavoro in meno. Un giorno Giovanna si fermò a pranzo da loro e quando rientrò in casa disse candidamente:
“Mamma, chiedi alla Ketty come fa la minestra. La sua è molto più buona della tua”.
Con Giovanna mi trovavo bene. Non sembrava particolarmente turbata dalla mia presenza. Era una bambina piuttosto timida e riservata. La sua tranquillità si contrapponeva alla mia esuberanza. Eravamo come il giorno e la notte. I cinque anni che ci separavano impedirono che diventassimo compagni di giochi, ma non sorsero mai grandi problemi nel nostro rapporto, sempre sereno e condito ogni tanto da qualche sprazzo di dolcezza.
Suo padre, Vincenzo, mi accolse come un secondo figlio. Era un bell’uomo, dal fisico asciutto e l’abbigliamento impeccabile. Aveva un viso magro, i capelli neri, gli occhi scuri e intelligenti e un paio di baffi sottili che lo facevano assomigliare ad Amedeo Nazzari. Ogni mattina dedicava una ventina di minuti alla cura del viso. Si radeva la barba e ritoccava i baffi con precisione chirurgica. Non aveva potuto sposare Costanza in quanto già sposato in precedenza con un’altra donna. Pur trovandosi costretta ad accettare la convivenza con un uomo senza il privilegio di vedere riconosciuta la loro relazione di fronte a Dio e alla legge, mia madre gli aveva dato, prima di Giovanna, altri due figli, morti per malattia durante i primi mesi di vita. Lavorava sulle navi come pompiere di bordo ed era spesso via per lunghi periodi. Quando ritornava dai viaggi portava sempre alcuni regali senza fare distinzioni tra me e Giovanna e questo particolare, unito al fatto che con me era sempre gentile e premuroso, me lo fece presto considerare come un padre adottivo. Ricordo la prima volta, quando ci portò un paio di ciabatte chiuse dietro con il pon pon sul tallone, a lei giallo e a me rosso. Ero felice. Ma i regali più belli furono senza dubbio una batteria dal Brasile e un kimono con le frange dorate dal Giappone.
Un giorno mi assalì la malinconia per una sua prolungata assenza e chiesi a mia madre:
“Perché Vincenzo naviga? Se lavorasse a terra non sarebbe costretto a stare lontano per tutti questi mesi”.
“Vincenzo non ha sempre navigato. Un tempo era autista, guidava gli autobus. Un lavoro ben pagato e non particolarmente faticoso. Poi un bel giorno gli dissero che per continuare a lavorare doveva essere iscritto al partito fascista. Piuttosto che rinnegare le sue convinzioni politiche, preferì rinunciare al lavoro. E così accadde per tutti i lavori successivi. Iniziava a lavorare e quando gli veniva chiesta la tessera del partito, il giorno successivo non si presentava e incominciava la ricerca di un nuovo lavoro. Ne ha cambiati una decina. Fino a quando gli è stata offerta la possibilità di lavorare a bordo di una nave i cui proprietari sono inglesi. Pagano bene, ma soprattutto non si preoccupano se sei fascista o comunista”.
Nel primo anno trascorso alla Casa Svizzera avevo incontrato un paio di volte il fratello di mio padre. Mi aveva raccontato di Mussolini, della resistenza, del nazismo, cercando di descrivere con parole semplici il periodo storico in cui era vissuto mio padre e di contestualizzare la sua morte. A premere il grilletto era stato un commissario dei carabinieri. Era l’assassino materiale, su questo non avevo dubbi. Ma non era lui il responsabile della situazione sociale che si era creata prima, durante e dopo la guerra. In questo senso, non era lui che aveva la responsabilità morale. Me ne ero convinto negli ultimi mesi, cercando una risposta a una delle domande che mi avevano travolto quattro anni prima all’ospedale.
“È il secondo padre che mi rubano i fascisti” commentai sconsolato scuotendo la testa.
Verso metà settembre iniziai a lavorare sui battelli per Punta Chiappa e San Fruttuoso. Non avevo mai fatto il marinaio, ma imparai presto i pochi compiti che dovevo eseguire a bordo. Il lavoro si svolgeva quasi esclusivamente durante la fase di arrivo, in cui si doveva assicurare il battello alla banchina, e di partenza, quando si slegavano i cavi dalle bitte e bisognava saltare rapidamente sul battello prima che fosse troppo lontano dal molo. Prima della partenza vendevo i biglietti per il viaggio. Durante la traversata invece avevo la possibilità di riposarmi e trascorrevo il tempo osservando i turisti e cercando di immaginare come potessero essere le loro vite. La signora ricoperta di gioielli viveva sicuramente in un favoloso castello in compagnia di giovani amanti. L’uomo con la barba bianca era quasi certamente un pittore, o forse uno scultore. La donna dallo sguardo triste che teneva per mano il bambino dai riccioli biondi era probabilmente rimasta vedova da poco tempo. I due giovani con gli occhi a cuoricino erano giunti fino al mare in luna di miele. La coppia e i due figli erano semplicemente ciò che avrei desiderato anche per me stesso, una famiglia felice. Un desiderio legittimo, pensavo, eppure mai come in quei giorni mi era sembrato un obiettivo irraggiungibile.
Per lavorare sui battelli avevo dovuto fare un libretto speciale per cui mi era stato chiesto, tra le altre cose, il documento di identità. Ogni volta che leggevo “figlio di Pietro Tommasi e n.n.” venivo investito da una lacerante tristezza. E così accadde anche quella mattina. Mentre osservavo il comandante del porto prendere nota dei miei dati, decisi che avrei chiesto spiegazioni, in fondo era un mio diritto. La sera, finita la cena, aspettai che Giovanna andasse a dormire e dissi a mia madre che volevo parlarle.
“Perché quando sono nato non mi hai riconosciuto?” le domandai a bruciapelo.
Non sembrava sorpresa, era come se sapesse che prima o poi quella domanda sarebbe arrivata.
“È una storia amara” rispose.
“Non mi importa. Ho il diritto di sapere”. Ero convinto di essere ormai vaccinato contro il dolore.
“Non volevamo un figlio, non ancora. Non eravamo sposati. Ero così giovane, non ero nemmeno maggiorenne. La mia gravidanza ci colse di sorpresa. La tua nascita ha sconvolto i precari equilibri su cui si basava la relazione tra me e tuo padre”.
Mi sbagliavo, al dolore non ci si abitua mai. Uno scherzo crudele del destino, un figlio indesiderato, ecco cosa ero. Sentii le gambe cedermi e mi accasciai su una sedia.
“Ci conoscevamo appena” continuò senza compassione. “Non avevamo costruito nulla. Non eravamo pronti per avere un figlio. Ma soprattutto non eravamo in grado di decidere autonomamente e Pietro seguì il consiglio dei suoi genitori. Gli dissero che ti avrebbero cresciuto loro, che si sarebbero presi cura di te come un figlio. Mia madre era vedova, era sola e con quattro figli da sfamare. Pensarono, credo in buona fede, che né io né lei saremmo state in grado di prenderci cura di te. Convinsero tuo padre a riconoscerti, a darti il suo nome e a portarti in casa loro”.
Avrei voluto scappare da quella stanza, ma la sua voce riecheggiò ancora inchiodandomi alla sedia e penetrò senza resistenza nella profonda ferita che mi si era aperta in mezzo allo stomaco.
“Pietro mi abbandonò. Da un giorno all’altro. Senza darmi alcuna spiegazione”. Separava le frasi, come se, attraverso le pause, volesse darmi il tempo di assorbirle tutte. “Non volle più incontrarmi. Non ho mai capito perché e non gliel’ho mai perdonato”.
Stava demolendo l’immagine che avevo di mio padre. Per me era sempre stato un uomo buono, coraggioso, giusto. Ero messo di fronte a una nuova verità sulla mia infanzia. O meglio, a un’inaspettata e desolante versione dei fatti che, data la morte di mio padre, non poteva più essere né confermata né smentita. Nel dubbio, la rifiutai.
“Non sarà stata una sua decisione, o almeno non solo sua. E poi tu, scusa, non hai fatto niente? Non mi hai più cercato? Sono trascorsi quattordici anni” dissi. “Quattordici anni” ripetei.
Sorrise amaramente.
“Ero poco più di una ragazza. Non lavoravo ancora. Forse ti sembrerà assurdo, ma anch’io mi ero convinta che per te fosse meglio restare in casa dei tuoi nonni paterni. Per il tuo bene”.
Non era la prima volta che persone che mi erano vicino avevano preso delle decisioni sul mio conto convinte di agire per il mio bene, causandomi invece tormento e sofferenza. Bisognerebbe essere comprensivi in questo caso. Ma in quel momento proprio non ci riuscivo, ero in balìa dell’odio che avevo provato durante troppi anni per quella donna che, per quanto mi sforzassi, non ero capace di accettare come madre. E poi c’era qualcosa che non quadrava. Se era vero che i genitori di mio padre gli avevano detto che si sarebbero presi cura di me, perché all’età di cinque anni ero stato affidato alla madre della sua compagna? Insistetti con tono inquisitorio.
“E quando lo hanno ammazzato? Nemmeno allora ti sei fatta viva”.
La voce dura, lo sguardo severo. Ero un giudice che aveva già scritto la sentenza di colpevolezza. Costanza avrebbe potuto dire qualsiasi cosa a sua discolpa, ma sarebbero state tutte parole inutili. Solamente la confessione del crimine dell’abbandono avrebbe messo fine a quell’interrogatorio.
“Durante i primi anni, dopo che ti avevano portato via, per sopportare l’angoscia e lo smarrimento ho provato a dimenticare che avevo un figlio”. Le lacrime iniziarono a rigarle il viso. “Quando ho letto sul giornale della morte di Pietro è riaffiorato improvvisamente un passato che ero riuscita con fatica a seppellire in un angolo recondito della memoria. Mi è balenato il pensiero di cercarti per sapere come stavi, dove eri, con chi vivevi. Ma con Vincenzo stavo bene. Eravamo felici. Ero finalmente serena, dopo tanta sofferenza. E Giovanna aveva quattro anni. Come madre mi sentii in dovere di proteggerla. Non me la sono sentita di iniziare una ricerca che con tutta probabilità sarebbe risultata difficile, lunga e dolorosa”.
“Il dovere di una madre è prendersi cura di tutti i suoi figli” replicai secco. Mi alzai e mi avviai verso la porta di casa. Avevo bisogno di aria fresca e di restare solo. Prima di uscire mi voltai.
“Io ci ho messo un giorno solo a trovarti. Non è stato né lungo né difficile”. Però è vero, pensai mentre scendevo le scale, è stato doloroso.
Mi ero immaginato tante volte questa conversazione, soprattutto da quando era nato il desiderio di conoscere mia madre. Mi ero immaginato il momento in cui le avrei fatto le domande che così a lungo mi avevano tormentato. Pensavo che non sarebbe stato facile. E così in effetti era stato. Avevo sempre avuto però l’illusione che una volta sapute le risposte mi sarei sentito sollevato, come quando ci si leva un enorme peso dallo stomaco e ci si sente leggeri e più che camminare si ha la sensazione di volare. Invece, mentre percorrevo il molo senza incontrare anima viva, mi sentii invadere da una densa e insopportabile pesantezza. Trascinai i piedi e lo spirito fino al faro. Guardai prima il paese, un pittoresco groviglio di case con le finestre illuminate, poi il mare, scuro e agitato. Il cielo era coperto e non si vedevano le stelle. La brezza rinfrescava l’aria. Era finita l’estate. Ripensai al dialogo con mia madre. Avevo le lacrime appese e un groppo in gola. Chiusi gli occhi, serrai i pugni e urlai più forte che potei con la bocca spalancata.
Usciva presto ogni mattina per andare a vendere il pesce al mercato di Nervi e rientrava nel tardo pomeriggio. Un lavoro faticoso, soprattutto d’inverno. Durante il nostro primo incontro ero rimasto impressionato dalla ruvidezza delle sue mani, segnate indelebilmente dalle ore trascorse a pulire il pesce con l’acqua gelida. Rimasi presto colpito dalla sua generosità. Quando preparava la minestra, era solita farne due pentole. Una per noi, una che mi dava da portare ai vicini del piano di sopra che, quasi contemporaneamente, si erano ritrovati con un figlio in più e un lavoro in meno. Un giorno Giovanna si fermò a pranzo da loro e quando rientrò in casa disse candidamente:
“Mamma, chiedi alla Ketty come fa la minestra. La sua è molto più buona della tua”.
Con Giovanna mi trovavo bene. Non sembrava particolarmente turbata dalla mia presenza. Era una bambina piuttosto timida e riservata. La sua tranquillità si contrapponeva alla mia esuberanza. Eravamo come il giorno e la notte. I cinque anni che ci separavano impedirono che diventassimo compagni di giochi, ma non sorsero mai grandi problemi nel nostro rapporto, sempre sereno e condito ogni tanto da qualche sprazzo di dolcezza.
Suo padre, Vincenzo, mi accolse come un secondo figlio. Era un bell’uomo, dal fisico asciutto e l’abbigliamento impeccabile. Aveva un viso magro, i capelli neri, gli occhi scuri e intelligenti e un paio di baffi sottili che lo facevano assomigliare ad Amedeo Nazzari. Ogni mattina dedicava una ventina di minuti alla cura del viso. Si radeva la barba e ritoccava i baffi con precisione chirurgica. Non aveva potuto sposare Costanza in quanto già sposato in precedenza con un’altra donna. Pur trovandosi costretta ad accettare la convivenza con un uomo senza il privilegio di vedere riconosciuta la loro relazione di fronte a Dio e alla legge, mia madre gli aveva dato, prima di Giovanna, altri due figli, morti per malattia durante i primi mesi di vita. Lavorava sulle navi come pompiere di bordo ed era spesso via per lunghi periodi. Quando ritornava dai viaggi portava sempre alcuni regali senza fare distinzioni tra me e Giovanna e questo particolare, unito al fatto che con me era sempre gentile e premuroso, me lo fece presto considerare come un padre adottivo. Ricordo la prima volta, quando ci portò un paio di ciabatte chiuse dietro con il pon pon sul tallone, a lei giallo e a me rosso. Ero felice. Ma i regali più belli furono senza dubbio una batteria dal Brasile e un kimono con le frange dorate dal Giappone.
Un giorno mi assalì la malinconia per una sua prolungata assenza e chiesi a mia madre:
“Perché Vincenzo naviga? Se lavorasse a terra non sarebbe costretto a stare lontano per tutti questi mesi”.
“Vincenzo non ha sempre navigato. Un tempo era autista, guidava gli autobus. Un lavoro ben pagato e non particolarmente faticoso. Poi un bel giorno gli dissero che per continuare a lavorare doveva essere iscritto al partito fascista. Piuttosto che rinnegare le sue convinzioni politiche, preferì rinunciare al lavoro. E così accadde per tutti i lavori successivi. Iniziava a lavorare e quando gli veniva chiesta la tessera del partito, il giorno successivo non si presentava e incominciava la ricerca di un nuovo lavoro. Ne ha cambiati una decina. Fino a quando gli è stata offerta la possibilità di lavorare a bordo di una nave i cui proprietari sono inglesi. Pagano bene, ma soprattutto non si preoccupano se sei fascista o comunista”.
Nel primo anno trascorso alla Casa Svizzera avevo incontrato un paio di volte il fratello di mio padre. Mi aveva raccontato di Mussolini, della resistenza, del nazismo, cercando di descrivere con parole semplici il periodo storico in cui era vissuto mio padre e di contestualizzare la sua morte. A premere il grilletto era stato un commissario dei carabinieri. Era l’assassino materiale, su questo non avevo dubbi. Ma non era lui il responsabile della situazione sociale che si era creata prima, durante e dopo la guerra. In questo senso, non era lui che aveva la responsabilità morale. Me ne ero convinto negli ultimi mesi, cercando una risposta a una delle domande che mi avevano travolto quattro anni prima all’ospedale.
“È il secondo padre che mi rubano i fascisti” commentai sconsolato scuotendo la testa.
Verso metà settembre iniziai a lavorare sui battelli per Punta Chiappa e San Fruttuoso. Non avevo mai fatto il marinaio, ma imparai presto i pochi compiti che dovevo eseguire a bordo. Il lavoro si svolgeva quasi esclusivamente durante la fase di arrivo, in cui si doveva assicurare il battello alla banchina, e di partenza, quando si slegavano i cavi dalle bitte e bisognava saltare rapidamente sul battello prima che fosse troppo lontano dal molo. Prima della partenza vendevo i biglietti per il viaggio. Durante la traversata invece avevo la possibilità di riposarmi e trascorrevo il tempo osservando i turisti e cercando di immaginare come potessero essere le loro vite. La signora ricoperta di gioielli viveva sicuramente in un favoloso castello in compagnia di giovani amanti. L’uomo con la barba bianca era quasi certamente un pittore, o forse uno scultore. La donna dallo sguardo triste che teneva per mano il bambino dai riccioli biondi era probabilmente rimasta vedova da poco tempo. I due giovani con gli occhi a cuoricino erano giunti fino al mare in luna di miele. La coppia e i due figli erano semplicemente ciò che avrei desiderato anche per me stesso, una famiglia felice. Un desiderio legittimo, pensavo, eppure mai come in quei giorni mi era sembrato un obiettivo irraggiungibile.
Per lavorare sui battelli avevo dovuto fare un libretto speciale per cui mi era stato chiesto, tra le altre cose, il documento di identità. Ogni volta che leggevo “figlio di Pietro Tommasi e n.n.” venivo investito da una lacerante tristezza. E così accadde anche quella mattina. Mentre osservavo il comandante del porto prendere nota dei miei dati, decisi che avrei chiesto spiegazioni, in fondo era un mio diritto. La sera, finita la cena, aspettai che Giovanna andasse a dormire e dissi a mia madre che volevo parlarle.
“Perché quando sono nato non mi hai riconosciuto?” le domandai a bruciapelo.
Non sembrava sorpresa, era come se sapesse che prima o poi quella domanda sarebbe arrivata.
“È una storia amara” rispose.
“Non mi importa. Ho il diritto di sapere”. Ero convinto di essere ormai vaccinato contro il dolore.
“Non volevamo un figlio, non ancora. Non eravamo sposati. Ero così giovane, non ero nemmeno maggiorenne. La mia gravidanza ci colse di sorpresa. La tua nascita ha sconvolto i precari equilibri su cui si basava la relazione tra me e tuo padre”.
Mi sbagliavo, al dolore non ci si abitua mai. Uno scherzo crudele del destino, un figlio indesiderato, ecco cosa ero. Sentii le gambe cedermi e mi accasciai su una sedia.
“Ci conoscevamo appena” continuò senza compassione. “Non avevamo costruito nulla. Non eravamo pronti per avere un figlio. Ma soprattutto non eravamo in grado di decidere autonomamente e Pietro seguì il consiglio dei suoi genitori. Gli dissero che ti avrebbero cresciuto loro, che si sarebbero presi cura di te come un figlio. Mia madre era vedova, era sola e con quattro figli da sfamare. Pensarono, credo in buona fede, che né io né lei saremmo state in grado di prenderci cura di te. Convinsero tuo padre a riconoscerti, a darti il suo nome e a portarti in casa loro”.
Avrei voluto scappare da quella stanza, ma la sua voce riecheggiò ancora inchiodandomi alla sedia e penetrò senza resistenza nella profonda ferita che mi si era aperta in mezzo allo stomaco.
“Pietro mi abbandonò. Da un giorno all’altro. Senza darmi alcuna spiegazione”. Separava le frasi, come se, attraverso le pause, volesse darmi il tempo di assorbirle tutte. “Non volle più incontrarmi. Non ho mai capito perché e non gliel’ho mai perdonato”.
Stava demolendo l’immagine che avevo di mio padre. Per me era sempre stato un uomo buono, coraggioso, giusto. Ero messo di fronte a una nuova verità sulla mia infanzia. O meglio, a un’inaspettata e desolante versione dei fatti che, data la morte di mio padre, non poteva più essere né confermata né smentita. Nel dubbio, la rifiutai.
“Non sarà stata una sua decisione, o almeno non solo sua. E poi tu, scusa, non hai fatto niente? Non mi hai più cercato? Sono trascorsi quattordici anni” dissi. “Quattordici anni” ripetei.
Sorrise amaramente.
“Ero poco più di una ragazza. Non lavoravo ancora. Forse ti sembrerà assurdo, ma anch’io mi ero convinta che per te fosse meglio restare in casa dei tuoi nonni paterni. Per il tuo bene”.
Non era la prima volta che persone che mi erano vicino avevano preso delle decisioni sul mio conto convinte di agire per il mio bene, causandomi invece tormento e sofferenza. Bisognerebbe essere comprensivi in questo caso. Ma in quel momento proprio non ci riuscivo, ero in balìa dell’odio che avevo provato durante troppi anni per quella donna che, per quanto mi sforzassi, non ero capace di accettare come madre. E poi c’era qualcosa che non quadrava. Se era vero che i genitori di mio padre gli avevano detto che si sarebbero presi cura di me, perché all’età di cinque anni ero stato affidato alla madre della sua compagna? Insistetti con tono inquisitorio.
“E quando lo hanno ammazzato? Nemmeno allora ti sei fatta viva”.
La voce dura, lo sguardo severo. Ero un giudice che aveva già scritto la sentenza di colpevolezza. Costanza avrebbe potuto dire qualsiasi cosa a sua discolpa, ma sarebbero state tutte parole inutili. Solamente la confessione del crimine dell’abbandono avrebbe messo fine a quell’interrogatorio.
“Durante i primi anni, dopo che ti avevano portato via, per sopportare l’angoscia e lo smarrimento ho provato a dimenticare che avevo un figlio”. Le lacrime iniziarono a rigarle il viso. “Quando ho letto sul giornale della morte di Pietro è riaffiorato improvvisamente un passato che ero riuscita con fatica a seppellire in un angolo recondito della memoria. Mi è balenato il pensiero di cercarti per sapere come stavi, dove eri, con chi vivevi. Ma con Vincenzo stavo bene. Eravamo felici. Ero finalmente serena, dopo tanta sofferenza. E Giovanna aveva quattro anni. Come madre mi sentii in dovere di proteggerla. Non me la sono sentita di iniziare una ricerca che con tutta probabilità sarebbe risultata difficile, lunga e dolorosa”.
“Il dovere di una madre è prendersi cura di tutti i suoi figli” replicai secco. Mi alzai e mi avviai verso la porta di casa. Avevo bisogno di aria fresca e di restare solo. Prima di uscire mi voltai.
“Io ci ho messo un giorno solo a trovarti. Non è stato né lungo né difficile”. Però è vero, pensai mentre scendevo le scale, è stato doloroso.
Mi ero immaginato tante volte questa conversazione, soprattutto da quando era nato il desiderio di conoscere mia madre. Mi ero immaginato il momento in cui le avrei fatto le domande che così a lungo mi avevano tormentato. Pensavo che non sarebbe stato facile. E così in effetti era stato. Avevo sempre avuto però l’illusione che una volta sapute le risposte mi sarei sentito sollevato, come quando ci si leva un enorme peso dallo stomaco e ci si sente leggeri e più che camminare si ha la sensazione di volare. Invece, mentre percorrevo il molo senza incontrare anima viva, mi sentii invadere da una densa e insopportabile pesantezza. Trascinai i piedi e lo spirito fino al faro. Guardai prima il paese, un pittoresco groviglio di case con le finestre illuminate, poi il mare, scuro e agitato. Il cielo era coperto e non si vedevano le stelle. La brezza rinfrescava l’aria. Era finita l’estate. Ripensai al dialogo con mia madre. Avevo le lacrime appese e un groppo in gola. Chiusi gli occhi, serrai i pugni e urlai più forte che potei con la bocca spalancata.
 Argomenti simili
Argomenti simili» Il baco e la farfalla (capitolo 2)
» Il baco e la farfalla (capitolo 12)
» Il baco e la farfalla (capitolo 24)
» Il baco e la farfalla (capitolo 3)
» Il baco e la farfalla (capitolo 13)
» Il baco e la farfalla (capitolo 12)
» Il baco e la farfalla (capitolo 24)
» Il baco e la farfalla (capitolo 3)
» Il baco e la farfalla (capitolo 13)
:: Vetrina Autori :: Opere :: Diego Repetto
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.|
|
|






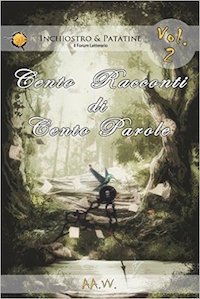
» concorso internazionale poesia e narrativa UN MONTE DI POESIA
» Premio di Poesia, Narrativa, Teatro e Pittura "Luce dell'Arte" 6^ Edizione
» concorso letterario internazionale UN MONTE DI POESIA XVI edizione
» IV^ Edizione del Premio di Narrativa, Teatro e Poesia "Il buon riso fa buon sangue". Scadenza bando 20/07/2022
» UN PONTE TRA NOI - RECENSIONE DI ARMANDO MASCHINI
» UN PONTE TRA NOI - RECENSIONE DI GIULIANA PARAGLIOLA