Il baco e la farfalla (capitolo 17)
:: Vetrina Autori :: Opere :: Diego Repetto
Pagina 1 di 1
 Il baco e la farfalla (capitolo 17)
Il baco e la farfalla (capitolo 17)
Gennaio 1958
La fila doveva essere perfetta. Dovevamo camminare al centro del corridoio, tra due pareti invisibili distanti mezzo metro l’una dall’altra. Guardare sempre di fronte. Mantenere costantemente la solita distanza da chi ti precedeva. Assolutamente vietato perdere il passo. Proibito parlare. Si entrava nei bagni a gruppi di cinque, sfasati di due minuti e mezzo, in modo che nelle docce non ci fossero mai più di dieci persone contemporaneamente. Trenta secondi per spogliarsi. I secondi cinque si insaponavano, mentre i primi cinque terminavano di sciacquarsi. Un minuto e mezzo per la prima operazione, altrettanto per la seconda. Altri trenta secondi per asciugarsi. Un minuto per rivestirsi. Tempo totale: cinque minuti.
La prima volta sei schifato dagli scarafaggi che ti sfrecciano tra i piedi e imbarazzato da tutti quei corpi nudi, molti dei quali in disfacimento, che a volte ti sfiorano e altre volte ti scontrano. Non sai dove rivolgere lo sguardo, hai il timore di venire sorpreso mentre ti soffermi disgustato sui casi estremi, quelli troppo adiposi e quelli invece che ti ricordano un ramo secco e spoglio. Poi ci fai l’abitudine, agli insetti e a tutto il resto, ti rendi conto che il tempo è contato, ti dimentichi di ciò che ti circonda e ti concentri sulle azioni da compiere, impegnandoti a non sgarrare.
“Non fidarti di nessuno”.
Mi volsi per vedere a chi apparteneva la voce alle mie spalle. Un uomo col volto scavato, ciuffi radi di peli neri in testa, l’unico incisivo rimasto spezzato a metà, le spalle spioventi.
“Scusa?”.
“Non fidarti di nessuno. Il più buono qui dentro venderebbe sua madre per un pacchetto di sigarette. Diffida sempre di chi ti offre un favore”.
Ero disorientato.
“Perché me lo dici?” domandai senza smettere di insaponarmi.
“Perché hai la faccia simpatica. Sicuro che sei qui per sbaglio”.
Allungò il braccio.
“Enrico”.
“Guido” mi presentai titubante.
Le mani scivolarono l’una sull’altra, ribellandosi alla stretta. Terminammo di lavarci in un incrocio di sguardi. Mentre mi infilavo i pantaloni, facendo attenzione a non farmi udire dalla guardia, gli sussurrai:
“E di te mi posso fidare?”.
Sorrise.
“Di me sì” rispose ammiccando.
In cella, sdraiato sulla branda, ripensai all’incontro. Quel tizio aveva proprio una brutta cera, ma in prigione un aspetto del genere era quasi la norma. Gli occhi però erano vivi e, soprattutto, mi erano parsi sinceri. In ogni caso non riuscivo a spiegarmi come mai mi avesse messo in guardia, da cosa e da chi. Forse era solo un avvertimento generico, forse gli ero simpatico davvero. Pensava che fossi lì per errore. Si sbagliava. E lui? Chissà per quale ragione si trovava lì. Magari anche lui aveva provato ad ammazzare qualcuno. Magari, diversamente da me, ci era anche riuscito, ed ora aveva la coscienza a posto e l’anima in pace. Io, invece, avevo coltivato la mia nemesi per anni. Mi aveva, non ancora identificata, tormentato e divorato dall’interno. Poi, quando finalmente ero riuscito a darle forma e azione, era sfumata per pochi miserabili centimetri, lasciandomi invaso da aride sensazioni, prosciugato, più assetato che mai.
Ora non mi restava altro che rincorrere pensieri che, come una pallina impazzita di gomma, rimbalzavano caotici tra le quattro pareti che delimitavano lo spazio angustio in cui ero rinchiuso.
Rividi Enrico il sabato successivo, durante l’ora d’aria. Era seduto su una panchina e osservava distrattamente la partita di calcetto che si stava svolgendo nel cortile della prigione. Lo raggiunsi e mi sedetti al suo fianco. Mi allungò il pacchetto di sigarette, guardandomi di sfuggita.
“Vuoi?”.
Dopo aver sparato al commissario Baldoni avevo deciso di smettere, ma il fallimento della vendetta, mi dissi, annullava automaticamente quella promessa.
“Grazie”.
Quando si accorse che la sigaretta penzolava spenta tra le mie labbra, mi porse la sua per accenderla. Aspirai a lungo per riempirmi i polmoni. La prima tirata era sempre la migliore. Soffiai il fumo verso l’alto e rimasi a fissare il cielo. Enrico sembrava ignorare la mia presenza. Il suo atteggiamento contrastava con l’approccio confidenziale che aveva avuto nelle docce qualche giorno prima. Si era ficcato in bocca il mozzicone che gli avevo restituito e, con aria annoiata, aveva aspettato che si consumasse solo.
“Perché non giochi?” domandai per rompere il ghiaccio.
“Perché voglio troppo bene alle mie gambe per regalarle a dei macellai. Le partite servono per regolare i piccoli diverbi avuti durante la settimana. Guarda, alcuni si disinteressano completamente della palla e puntano diretti alle caviglie”.
Con un movimento del capo mi invitò a verificare quanto aveva affermato.
“Ogni tanto nella confusione qualcuno si sbaglia e rompe la caviglia di uno che non c’entra un cazzo. Non mi va di correre il rischio, tutto qui” chiarì sollevando appena le spalle.
“Perché hai detto “piccoli diverbi”?”.
“Si vede che sei arrivato da poco”. Il suo tono mi fece sentire un ingenuo.
“Quando hai un problema, uno vero, non ti accontenti delle caviglie”.
Giocava con le pause, si divertiva a stuzzicare la mia curiosità. Raccolse la palla che era rotolata ai suoi piedi e la restituì a un giocatore che si era avvicinato alla panchina.
“Vedi quello che ha preso la palla?”.
Annuii.
“Lo chiamano il “droghiere”. Se hai bisogno di qualcosa, lui te la procura. I prezzi sono onesti. La merce più richiesta sono i coltelli. Servono per risolvere i problemi, quelli seri”.
Iniziavo a capire.
“Vedi il portiere?”.
“A destra o sinistra?”.
“Destra”.
Feci cenno di sì.
“Gaetano detto “Marzapane”. Meglio stargli alla larga. Quando era fuori faceva parte di un gruppo di banditi siciliani. Qui in carcere controlla il giro delle scommesse. Un paio di mesi fa ha sorpreso uno mentre gli rubava dei soldi. Due giorni dopo l’hanno trovato nelle docce in un lago di sangue, una decina di coltellate alla schiena, altrettante in pancia, le dieci dita amputate infilate in bocca. Un lavoretto da professionisti”.
Sentii un conato di vomito salire dallo stomaco. Riuscii a fatica a rispedire al mittente i succhi gastrici che percorsero a ritroso la laringe lasciandomi in bocca un disgustoso retrogusto acidulo. Restai a fissare, incredulo, l’uomo che giocava in porta alla mia destra. A vederlo dava l’impressione di uno che non avrebbe ucciso nemmeno una mosca.
“Perché “Marzapane”?” domandai non appena ritornai in me.
“Pare che sia goloso di pasta di mandorle. Sai com’è, ognuno ha i suoi vizi” sospirò Enrico allargando le braccia.
Un fischio acuto e prolungato annunciò il rientro in cella. I giocatori smisero di essere giocatori, gli spettatori di essere spettatori, e tutti si trasformarono nuovamente in carcerati. Un insieme scomposto e zoppicante di volti madidi e impolverati si trascinò stancamente verso la porta del cortile. Anche quel giorno, come sempre, quei maledetti sessanta minuti, pessimo surrogato della libertà perduta, erano passati troppo in fretta.
Quando giunsi di fronte alla cella vidi che i miei due compagni erano già rientrati. Respiravano la mia stessa aria da quasi tre settimane, eppure non sapevo nulla di loro. Ignoravo le loro storie, perché si trovassero lì, quanti anni dovessero scontare. Del resto in prigione si imparano subito alcune regole di “sopravvivenza” senza che nessuno te le spieghi. Non ce n’è bisogno, semplicemente lo avverti. Anche se nessuno te l’ha detto, sai che non devi mai chiedere a una persona il motivo per cui si trova in carcere. Se e quando sarà il momento, sarà lei a dirtelo. Scopri che meno ti interessi di ciò che succede intorno a te e meglio è. Capisci che il modo migliore per non incorrere in una domanda inopportuna è non farla. Presto ti rendi conto che la prigione è come un grande bazar di seconda mano, sporco e maleodorante, dove la speranza è esaurita da un pezzo, la morte è perennemente in saldo e la curiosità ha quasi sempre un prezzo elevatissimo.
Mi sdraiai sul letto, lentamente, cercando inutilmente di non farlo cigolare per non infrangere il silenzio. Assunsi una posizione fetale sotto la coperta ricoperta di pulci e, rassegnato, attesi che la noia e il torpore venissero a farmi visita.
Trascorse un’altra settimana.
Appena varcata la porta del cortile mi accorsi che la panchina era vuota. Cercai Enrico con lo sguardo, ma in tutto lo spiazzo non c’era traccia della sua presenza. Attesi che l’azione si svolgesse lontano da me e attraversai di corsa il campo da gioco. Presi posto sulla panchina. La visione era perfetta, potevo controllare il cortile intero con un semplice movimento degli occhi. “Marzapane” quel giorno non stava giocando. Era appoggiato al muro, scortato da un paio dei suoi uomini, e si guardava intorno nervosamente, come se si sentisse minacciato da qualcosa.
Finalmente apparve Enrico, sulla soglia della porta d’ingresso. Alzai un braccio e lo mantenni sollevato fino a quando non lo vidi venire verso di me.
“Il medico è proprio un figlio di puttana” sbottò prima ancora di sedersi. “Lo devi supplicare perché ti dia una medicina del cazzo. Avevo lo stomaco in fiamme, non riuscivo nemmeno a stare in piedi. Mi hanno portato in infermeria dove ’sto stronzo mi ha visitato e mi ha detto che non era niente. Quanto si è fatto pregare per due pastiglie! Manco le pagasse lui! Ti auguro davvero di non averci mai nulla a che fare”. Sputò per terra la sua rabbia.
“Mi spiace. Ora come va?”.
“Meglio” rispose poco convinto, sfregandosi con una mano il viso e con l’altra la pancia.
Si sedette al mio fianco e si accese una sigaretta senza offrirmene. Fece due tiri, poi me la passò.
“Vuoi fumare? È l’ultima”.
“No grazie”.
Restammo qualche minuto in silenzio ad osservare la partita.
“Ho chiesto la grazia” disse senza voltarsi.
“Cosa hai chiesto?”.
“La grazia. Al presidente della Repubblica. Che mi faccia uscire da qui”.
Probabilmente si rese conto che non mi aveva mai detto per quale ragione si trovasse lì, perché prima che potessi dire qualcosa iniziò a raccontare:
“Sono otto anni che sono dentro e non ho ammazzato nessuno. Si tratta di un gioco da ragazzi, mi avevano detto. Niente armi vere, solo pistole giocattolo. Non devi nemmeno entrare in banca, tu resti fuori e fai da palo. Dai Chicco, senza di te il colpo salta. Erano amici di vecchia data, mi sono fidato. Invece Lele si era portato dietro una pistola vera e quando l’impiegato si è rifiutato di aprirgli la cassaforte lo ha fatto secco. Ma come cazzo si fa a sparare a una persona disarmata?”.
Non riuscii a sostenere il suo sguardo. Non saprei dire se non notò o ignorò deliberatamente il mio imbarazzo. In preda a un’improvvisa agitazione, proseguì travolgente, come un fiume in piena.
“Li ho visti uscire di corsa. Sei un coglione! Un idiota! Gli urlava Johnny. Salta in macchina. Presto. E dopo aver sbattuto le portiere. Dai cazzo Chicco, metti in moto e parti che se ci beccano siamo fottuti!”.
Prese il respiro, espirò piano, recuperando la calma.
“Ci hanno beccato a un posto di blocco all’uscita della città” concluse con voce atona.
Otto anni e chissà quanti altri ancora da scontare per aver fatto da palo in una rapina finita male. Cinque anni per aver voluto ammazzare una persona e non esserci riuscito per avere sbagliato il tiro. Mai come in quel momento la giustizia mi sembrò così poco giusta.
“Pensi che te la concederanno? La grazia, intendo”.
“Non lo so. Ma sono stufo di marcire qui dentro. Guardami. Ho trentacinque anni e ne dimostro cinquanta. Ogni anno trascorso in prigione equivale a tre passati fuori”.
Pensai che era vero, pareva molto più vecchio di quanto fosse in realtà. Enrico socchiuse gli occhi, vergognandosi del velo di tristezza che li aveva ricoperti.
“Vedrai che accetteranno la tua richiesta” cercai di consolarlo.
Fummo interrotti dal segnale di rientro. Ci incamminammo in direzione dell’uscita, mischiandoci al resto dei detenuti, trascinando i piedi, risucchiati contro la nostra volontà come tanti piccoli granelli di polvere.
Vidi che “Marzapane” si manteneva ai lati del flusso, protetto dalle sue guardie del corpo. Ogni due o tre passi, dava una rapida occhiata alle proprie spalle. Lo feci notare a Enrico.
“Tre giorni fa, in un casolare nella campagna di Palermo, hanno arrestato Totò “Barracuda”. Gaetano era il suo braccio destro. Girano voci che sia stato proprio lui a fare la soffiata ai carabinieri. Se anche i complici di “Barracuda” ne sono convinti, “Marzapane” è un uomo morto”.
Mi domandai come facesse a saperlo, evitando accuratamente di chiederglielo. Avevo sentito dire che in prigione le voci girano più rapidamente che in ogni altro posto. La notizia dell’arresto di “Barracuda” aveva impiegato tre giorni per raggiungermi. Sollevai le spalle e sorrisi dentro di me, dovevo proprio essere l’ultimo in tutto il carcere di Viterbo a esserne venuto a conoscenza.
Un paio di giorni dopo mi toccò il turno nelle docce insieme a Enrico.
“Te l’avevo detto che era un fantasma che camminava” disse piano.
“Lo hanno ammazzato?” domandai sorpreso.
“Avvelenato con un caffè. Per uno come lui, una morte sciocca e senza gloria. Sinceramente lo facevo più intelligente” rispose beffardo.
La fila doveva essere perfetta. Dovevamo camminare al centro del corridoio, tra due pareti invisibili distanti mezzo metro l’una dall’altra. Guardare sempre di fronte. Mantenere costantemente la solita distanza da chi ti precedeva. Assolutamente vietato perdere il passo. Proibito parlare. Si entrava nei bagni a gruppi di cinque, sfasati di due minuti e mezzo, in modo che nelle docce non ci fossero mai più di dieci persone contemporaneamente. Trenta secondi per spogliarsi. I secondi cinque si insaponavano, mentre i primi cinque terminavano di sciacquarsi. Un minuto e mezzo per la prima operazione, altrettanto per la seconda. Altri trenta secondi per asciugarsi. Un minuto per rivestirsi. Tempo totale: cinque minuti.
La prima volta sei schifato dagli scarafaggi che ti sfrecciano tra i piedi e imbarazzato da tutti quei corpi nudi, molti dei quali in disfacimento, che a volte ti sfiorano e altre volte ti scontrano. Non sai dove rivolgere lo sguardo, hai il timore di venire sorpreso mentre ti soffermi disgustato sui casi estremi, quelli troppo adiposi e quelli invece che ti ricordano un ramo secco e spoglio. Poi ci fai l’abitudine, agli insetti e a tutto il resto, ti rendi conto che il tempo è contato, ti dimentichi di ciò che ti circonda e ti concentri sulle azioni da compiere, impegnandoti a non sgarrare.
“Non fidarti di nessuno”.
Mi volsi per vedere a chi apparteneva la voce alle mie spalle. Un uomo col volto scavato, ciuffi radi di peli neri in testa, l’unico incisivo rimasto spezzato a metà, le spalle spioventi.
“Scusa?”.
“Non fidarti di nessuno. Il più buono qui dentro venderebbe sua madre per un pacchetto di sigarette. Diffida sempre di chi ti offre un favore”.
Ero disorientato.
“Perché me lo dici?” domandai senza smettere di insaponarmi.
“Perché hai la faccia simpatica. Sicuro che sei qui per sbaglio”.
Allungò il braccio.
“Enrico”.
“Guido” mi presentai titubante.
Le mani scivolarono l’una sull’altra, ribellandosi alla stretta. Terminammo di lavarci in un incrocio di sguardi. Mentre mi infilavo i pantaloni, facendo attenzione a non farmi udire dalla guardia, gli sussurrai:
“E di te mi posso fidare?”.
Sorrise.
“Di me sì” rispose ammiccando.
In cella, sdraiato sulla branda, ripensai all’incontro. Quel tizio aveva proprio una brutta cera, ma in prigione un aspetto del genere era quasi la norma. Gli occhi però erano vivi e, soprattutto, mi erano parsi sinceri. In ogni caso non riuscivo a spiegarmi come mai mi avesse messo in guardia, da cosa e da chi. Forse era solo un avvertimento generico, forse gli ero simpatico davvero. Pensava che fossi lì per errore. Si sbagliava. E lui? Chissà per quale ragione si trovava lì. Magari anche lui aveva provato ad ammazzare qualcuno. Magari, diversamente da me, ci era anche riuscito, ed ora aveva la coscienza a posto e l’anima in pace. Io, invece, avevo coltivato la mia nemesi per anni. Mi aveva, non ancora identificata, tormentato e divorato dall’interno. Poi, quando finalmente ero riuscito a darle forma e azione, era sfumata per pochi miserabili centimetri, lasciandomi invaso da aride sensazioni, prosciugato, più assetato che mai.
Ora non mi restava altro che rincorrere pensieri che, come una pallina impazzita di gomma, rimbalzavano caotici tra le quattro pareti che delimitavano lo spazio angustio in cui ero rinchiuso.
Rividi Enrico il sabato successivo, durante l’ora d’aria. Era seduto su una panchina e osservava distrattamente la partita di calcetto che si stava svolgendo nel cortile della prigione. Lo raggiunsi e mi sedetti al suo fianco. Mi allungò il pacchetto di sigarette, guardandomi di sfuggita.
“Vuoi?”.
Dopo aver sparato al commissario Baldoni avevo deciso di smettere, ma il fallimento della vendetta, mi dissi, annullava automaticamente quella promessa.
“Grazie”.
Quando si accorse che la sigaretta penzolava spenta tra le mie labbra, mi porse la sua per accenderla. Aspirai a lungo per riempirmi i polmoni. La prima tirata era sempre la migliore. Soffiai il fumo verso l’alto e rimasi a fissare il cielo. Enrico sembrava ignorare la mia presenza. Il suo atteggiamento contrastava con l’approccio confidenziale che aveva avuto nelle docce qualche giorno prima. Si era ficcato in bocca il mozzicone che gli avevo restituito e, con aria annoiata, aveva aspettato che si consumasse solo.
“Perché non giochi?” domandai per rompere il ghiaccio.
“Perché voglio troppo bene alle mie gambe per regalarle a dei macellai. Le partite servono per regolare i piccoli diverbi avuti durante la settimana. Guarda, alcuni si disinteressano completamente della palla e puntano diretti alle caviglie”.
Con un movimento del capo mi invitò a verificare quanto aveva affermato.
“Ogni tanto nella confusione qualcuno si sbaglia e rompe la caviglia di uno che non c’entra un cazzo. Non mi va di correre il rischio, tutto qui” chiarì sollevando appena le spalle.
“Perché hai detto “piccoli diverbi”?”.
“Si vede che sei arrivato da poco”. Il suo tono mi fece sentire un ingenuo.
“Quando hai un problema, uno vero, non ti accontenti delle caviglie”.
Giocava con le pause, si divertiva a stuzzicare la mia curiosità. Raccolse la palla che era rotolata ai suoi piedi e la restituì a un giocatore che si era avvicinato alla panchina.
“Vedi quello che ha preso la palla?”.
Annuii.
“Lo chiamano il “droghiere”. Se hai bisogno di qualcosa, lui te la procura. I prezzi sono onesti. La merce più richiesta sono i coltelli. Servono per risolvere i problemi, quelli seri”.
Iniziavo a capire.
“Vedi il portiere?”.
“A destra o sinistra?”.
“Destra”.
Feci cenno di sì.
“Gaetano detto “Marzapane”. Meglio stargli alla larga. Quando era fuori faceva parte di un gruppo di banditi siciliani. Qui in carcere controlla il giro delle scommesse. Un paio di mesi fa ha sorpreso uno mentre gli rubava dei soldi. Due giorni dopo l’hanno trovato nelle docce in un lago di sangue, una decina di coltellate alla schiena, altrettante in pancia, le dieci dita amputate infilate in bocca. Un lavoretto da professionisti”.
Sentii un conato di vomito salire dallo stomaco. Riuscii a fatica a rispedire al mittente i succhi gastrici che percorsero a ritroso la laringe lasciandomi in bocca un disgustoso retrogusto acidulo. Restai a fissare, incredulo, l’uomo che giocava in porta alla mia destra. A vederlo dava l’impressione di uno che non avrebbe ucciso nemmeno una mosca.
“Perché “Marzapane”?” domandai non appena ritornai in me.
“Pare che sia goloso di pasta di mandorle. Sai com’è, ognuno ha i suoi vizi” sospirò Enrico allargando le braccia.
Un fischio acuto e prolungato annunciò il rientro in cella. I giocatori smisero di essere giocatori, gli spettatori di essere spettatori, e tutti si trasformarono nuovamente in carcerati. Un insieme scomposto e zoppicante di volti madidi e impolverati si trascinò stancamente verso la porta del cortile. Anche quel giorno, come sempre, quei maledetti sessanta minuti, pessimo surrogato della libertà perduta, erano passati troppo in fretta.
Quando giunsi di fronte alla cella vidi che i miei due compagni erano già rientrati. Respiravano la mia stessa aria da quasi tre settimane, eppure non sapevo nulla di loro. Ignoravo le loro storie, perché si trovassero lì, quanti anni dovessero scontare. Del resto in prigione si imparano subito alcune regole di “sopravvivenza” senza che nessuno te le spieghi. Non ce n’è bisogno, semplicemente lo avverti. Anche se nessuno te l’ha detto, sai che non devi mai chiedere a una persona il motivo per cui si trova in carcere. Se e quando sarà il momento, sarà lei a dirtelo. Scopri che meno ti interessi di ciò che succede intorno a te e meglio è. Capisci che il modo migliore per non incorrere in una domanda inopportuna è non farla. Presto ti rendi conto che la prigione è come un grande bazar di seconda mano, sporco e maleodorante, dove la speranza è esaurita da un pezzo, la morte è perennemente in saldo e la curiosità ha quasi sempre un prezzo elevatissimo.
Mi sdraiai sul letto, lentamente, cercando inutilmente di non farlo cigolare per non infrangere il silenzio. Assunsi una posizione fetale sotto la coperta ricoperta di pulci e, rassegnato, attesi che la noia e il torpore venissero a farmi visita.
Trascorse un’altra settimana.
Appena varcata la porta del cortile mi accorsi che la panchina era vuota. Cercai Enrico con lo sguardo, ma in tutto lo spiazzo non c’era traccia della sua presenza. Attesi che l’azione si svolgesse lontano da me e attraversai di corsa il campo da gioco. Presi posto sulla panchina. La visione era perfetta, potevo controllare il cortile intero con un semplice movimento degli occhi. “Marzapane” quel giorno non stava giocando. Era appoggiato al muro, scortato da un paio dei suoi uomini, e si guardava intorno nervosamente, come se si sentisse minacciato da qualcosa.
Finalmente apparve Enrico, sulla soglia della porta d’ingresso. Alzai un braccio e lo mantenni sollevato fino a quando non lo vidi venire verso di me.
“Il medico è proprio un figlio di puttana” sbottò prima ancora di sedersi. “Lo devi supplicare perché ti dia una medicina del cazzo. Avevo lo stomaco in fiamme, non riuscivo nemmeno a stare in piedi. Mi hanno portato in infermeria dove ’sto stronzo mi ha visitato e mi ha detto che non era niente. Quanto si è fatto pregare per due pastiglie! Manco le pagasse lui! Ti auguro davvero di non averci mai nulla a che fare”. Sputò per terra la sua rabbia.
“Mi spiace. Ora come va?”.
“Meglio” rispose poco convinto, sfregandosi con una mano il viso e con l’altra la pancia.
Si sedette al mio fianco e si accese una sigaretta senza offrirmene. Fece due tiri, poi me la passò.
“Vuoi fumare? È l’ultima”.
“No grazie”.
Restammo qualche minuto in silenzio ad osservare la partita.
“Ho chiesto la grazia” disse senza voltarsi.
“Cosa hai chiesto?”.
“La grazia. Al presidente della Repubblica. Che mi faccia uscire da qui”.
Probabilmente si rese conto che non mi aveva mai detto per quale ragione si trovasse lì, perché prima che potessi dire qualcosa iniziò a raccontare:
“Sono otto anni che sono dentro e non ho ammazzato nessuno. Si tratta di un gioco da ragazzi, mi avevano detto. Niente armi vere, solo pistole giocattolo. Non devi nemmeno entrare in banca, tu resti fuori e fai da palo. Dai Chicco, senza di te il colpo salta. Erano amici di vecchia data, mi sono fidato. Invece Lele si era portato dietro una pistola vera e quando l’impiegato si è rifiutato di aprirgli la cassaforte lo ha fatto secco. Ma come cazzo si fa a sparare a una persona disarmata?”.
Non riuscii a sostenere il suo sguardo. Non saprei dire se non notò o ignorò deliberatamente il mio imbarazzo. In preda a un’improvvisa agitazione, proseguì travolgente, come un fiume in piena.
“Li ho visti uscire di corsa. Sei un coglione! Un idiota! Gli urlava Johnny. Salta in macchina. Presto. E dopo aver sbattuto le portiere. Dai cazzo Chicco, metti in moto e parti che se ci beccano siamo fottuti!”.
Prese il respiro, espirò piano, recuperando la calma.
“Ci hanno beccato a un posto di blocco all’uscita della città” concluse con voce atona.
Otto anni e chissà quanti altri ancora da scontare per aver fatto da palo in una rapina finita male. Cinque anni per aver voluto ammazzare una persona e non esserci riuscito per avere sbagliato il tiro. Mai come in quel momento la giustizia mi sembrò così poco giusta.
“Pensi che te la concederanno? La grazia, intendo”.
“Non lo so. Ma sono stufo di marcire qui dentro. Guardami. Ho trentacinque anni e ne dimostro cinquanta. Ogni anno trascorso in prigione equivale a tre passati fuori”.
Pensai che era vero, pareva molto più vecchio di quanto fosse in realtà. Enrico socchiuse gli occhi, vergognandosi del velo di tristezza che li aveva ricoperti.
“Vedrai che accetteranno la tua richiesta” cercai di consolarlo.
Fummo interrotti dal segnale di rientro. Ci incamminammo in direzione dell’uscita, mischiandoci al resto dei detenuti, trascinando i piedi, risucchiati contro la nostra volontà come tanti piccoli granelli di polvere.
Vidi che “Marzapane” si manteneva ai lati del flusso, protetto dalle sue guardie del corpo. Ogni due o tre passi, dava una rapida occhiata alle proprie spalle. Lo feci notare a Enrico.
“Tre giorni fa, in un casolare nella campagna di Palermo, hanno arrestato Totò “Barracuda”. Gaetano era il suo braccio destro. Girano voci che sia stato proprio lui a fare la soffiata ai carabinieri. Se anche i complici di “Barracuda” ne sono convinti, “Marzapane” è un uomo morto”.
Mi domandai come facesse a saperlo, evitando accuratamente di chiederglielo. Avevo sentito dire che in prigione le voci girano più rapidamente che in ogni altro posto. La notizia dell’arresto di “Barracuda” aveva impiegato tre giorni per raggiungermi. Sollevai le spalle e sorrisi dentro di me, dovevo proprio essere l’ultimo in tutto il carcere di Viterbo a esserne venuto a conoscenza.
Un paio di giorni dopo mi toccò il turno nelle docce insieme a Enrico.
“Te l’avevo detto che era un fantasma che camminava” disse piano.
“Lo hanno ammazzato?” domandai sorpreso.
“Avvelenato con un caffè. Per uno come lui, una morte sciocca e senza gloria. Sinceramente lo facevo più intelligente” rispose beffardo.
 Argomenti simili
Argomenti simili» Il baco e la farfalla (capitolo 2)
» Il baco e la farfalla (capitolo 12)
» Il baco e la farfalla (capitolo 24)
» Il baco e la farfalla (capitolo 3)
» Il baco e la farfalla (capitolo 13)
» Il baco e la farfalla (capitolo 12)
» Il baco e la farfalla (capitolo 24)
» Il baco e la farfalla (capitolo 3)
» Il baco e la farfalla (capitolo 13)
:: Vetrina Autori :: Opere :: Diego Repetto
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.|
|
|






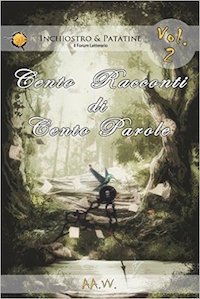
» concorso internazionale poesia e narrativa UN MONTE DI POESIA
» Premio di Poesia, Narrativa, Teatro e Pittura "Luce dell'Arte" 6^ Edizione
» concorso letterario internazionale UN MONTE DI POESIA XVI edizione
» IV^ Edizione del Premio di Narrativa, Teatro e Poesia "Il buon riso fa buon sangue". Scadenza bando 20/07/2022
» UN PONTE TRA NOI - RECENSIONE DI ARMANDO MASCHINI
» UN PONTE TRA NOI - RECENSIONE DI GIULIANA PARAGLIOLA